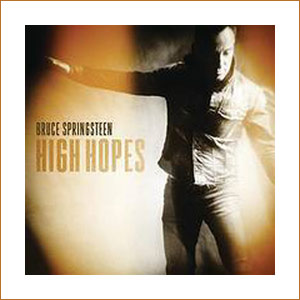“Van Ronk
says to Bobby: she’s the next real thing". E’ un verso di (You will) Set the World On Fire, un brano del David Bowie di The Next Day, nel quale si disegna un
quadro del Greenwich Village degli anni sessanta attraverso le figure che più
lo hanno caratterizzato. C’è Bobby (Dylan), ci sono Joan Baez, Pete Seeger e
Phil Ochs, c’è il futuro (la lei del
verso si riferisce a Joni Mitchell). E poi c’è Dave Van Ronk, l’uomo
onnipresente in ogni foto o in ogni grande avvenimento del quartiere più
bollente di New York. Lui stesso, fino alla morte (2002), ha ripetuto in ogni
intervista che non capiva come mai lo si infilasse sempre negli elenchi degli
eroi del periodo, visto che i suoi dischi restano perlopiù dimenticati. I
cultori del genere vi diranno che No
Dirty Names del 1966 è un disco sottovalutato, fatto di trame
chitarristiche sopraffine e con una modernità ancora oggi evidente, ma per sua
sfortuna uscì quando il folk era già in fase calante, ucciso l’anno prima dalle
elettriche di Dylan e dalla scoperta dei Byrds che le stesse canzoni potevano
anche divenire pop-songs di successo. Lo chiamavano “Il Sindaco di MacDougal
Street”, insegnò il blues a Dylan e fu un timido testimone di eventi e personaggi
più grandi di lui. E si rifiutò per tutta la vita di prendere la patente e di
volare su un aereo, così, senza un motivo particolare. Proprio come un
personaggio di un film dei Coen.
Nicola Gervasini