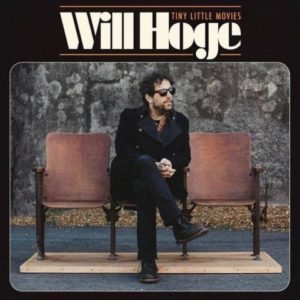| X
| ||
Son passati 40 anni esatti dall’uscita di Los Angeles, uno degli esordi più fulminanti e meno invecchiati del rock californiano dell’epoca, vera e propria Stele di Rosetta per capire tutto il rock sotterraneo USA degli anni 80, eppure siamo ancora qui oggi a recensire un disco degli X. Non me l’aspettavo devo dire, anche se la reunion dei Flesh Eaters dello scorso anno aveva già fatto capire che John Doe e il batterista DJ Bonebrake erano in vena di rimpatriate. La seconda era della band d’altronde aveva lasciato un po’ di amaro in bocca dopo quattro album senza difetti, a causa del disperato tentativo di aggiornare un sound probabilmente inaggiornabile, prima abbracciando le tastiere degli anni 80 (Ain’t Life Grand del 1985), poi facendosi guidare da Dave Alvin nel mondo della roots music con il comunque convincente See How We Are del 1987, e infine con il disastro di Hey Zeus!, cioè come suonare già vecchi nel 1993, anno in cui davvero succedeva di tutto nel rock, e non approfittarne fu davvero un sacrilegio.
Nel frattempo John Doe si è costruito una più che soddisfacente carriera da rocker americano di razza, dimostrando che l’episodio via-Dave Alvin non era un caso, ma una regola futura, mentre Exene Cervenka, dopo due discreti album quasi da cantautrice come Old Wives’ Tales e Running Sacred, ha fatto più fatica a trovare una sua regolarità artistica. Gli X si riuniscono dopo 27 anni dall’ultimo album (ci fu un singolo natalizio del 2009 a rompere il silenzio), ma ben 35 dall’ultima uscita con questa formazione, che vede quindi tornare in squadra il chitarrista Billy Zoom, di nuovo in sella nonostante abbia passato gli ultimi anni tra una chemioterapia e un’altra. Ma la vera sorpresa è che Alphabetland pare davvero ripartire da zero, suona come se fosse il loro terzo album uscito appena dopo Wild Gift del 1981, e se ormai non ci si meraviglia più di quanta energia si possa ancora avere a settant’anni, impressiona però sentire un disco che pare registrato davvero in uno scantinato della Sunset Strip di Los Angeles da una banda di ragazzini con tanta rabbia in corpo da sfogare.
Insomma, l’aria di revival tira più sulla carta che in canzoni come la pogo-song Delta 88 Nightmare o Star Chambered, dove l’alternarsi delle voci di Doe e della Cervenka ritrova l’antica intesa. Stavolta non c’è ovviamente lo scomparso Ray Manzarek in cabina di regia, e allora si invita Robby Krieger a dare il suo inconfondibile tocco-Doors allo spoken finale di All the Time in the World, brano che fa l’occhiolino al talking di Jim Morrison in The Wasp (Texas Radio & the Big Beat). Ma il vero artefice della riuscita dell’operazione è il produttore Rob Schnapf, l’uomo dietro molti titoli del compianto Elliott Smith, capace di rendere il suono X decisamente attuale anche a quarant’anni di distanza, come dimostra l’uno-due iniziale di Alphabetland e Free. Billy Zoom pare in gran forma, anche se non c’è un solo riff che non suoni già sentito, con pochissime variazioni sul tema (la danzereccia Cyrano DeBerger’s Back, un vecchio scarto proprio di Los Angeles), giusto per tirare a 27 minuti di un rock che forse può ancora dire qualcosa anche alle giovani generazioni.