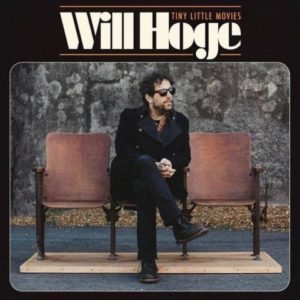Odla
Oltre il cielo alberatO
[Snowdonia 2020]
File Under: Cantautori e detta schiera
Snowdonia.bandcamp.com
di Nicola Gervasini
Giovane e poliedrico (ha al suo attivo anche un libro di poesie), il trentino Odla approda alla Snowdonia (l’etichetta dei Maisie) beneficiando della loro passione per i progetti musicali nati con spirito letterario (e spesso accompagnanti da veri e propri libri) per il suo primo album Oltre il Cielo Alberato. Si tratta di un concept che prova a tracciare una linea parallela tra la storia personale dell’artista, fatta di tutte le problematiche in cui può facilmente incappare un ventisettenne italiano di oggi (depressione, delusioni amorose, frustrazione da lavoro precario e poca fiducia nel futuro) e la vita (questa invece immaginaria) di Hassan, bambino in perenne fuga dalla guerra, per cui la speranza rappresenta non più un lusso, ma una necessità. Nessun intento politico o polemico però nel confronto, ma solo una ricerca di un tratto comune esistenziale da esprimere nei versi di undici brani che si rifanno a quella nuova tradizione di cantautorato italiano con De Andrè e Fossati nel cuore, comunque figlia della storia scena indipendente italiana di questi anni 2000. Il suono, realizzato in collaborazione con il produttore roveretano V.Edo, è scarno e acustico, ma non mancano i diversivi come la quasi-tarantella di I Pescatori di Lete, impreziosita dal mandolino siciliano di Davide Prezzo. Diviso tra pezzi lenti e oscuri come Il Sogno di Una Madre ad altri anche più scanzonati e cantabili come Al Fuoco di Luna, Odla lavora bene anche sugli arrangiamenti, da quelli più da folk psichedelico anni 60 come All’Alba Una Terra a quelli con taglio più da canzone popolare (San Giuseppe da Copertino), anche se ovunque la base resta il suo arpeggio alla Leonard Cohen prima maniera.