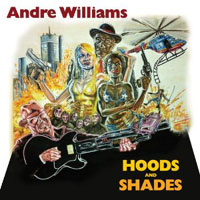| Delta Spirit Delta Spirit [Rounder 2012] www.deltaspirit.net di Nicola Gervasini (06/04/2012) |  | |
Ci ha riflettuto molto il pover uomo, ha ascoltato queste canzoni più volte, in macchina, a casa sullo stereo, in cuffia nell'ipod, in cucina mentre pelava le patate, sul computer mentre scrive queste righe, ma non solo non ha trovato il senso di questa svolta stilistica, ma neppure ne ha compreso appieno la funzione. E sì che il vostro aveva addirittura nominato il loro disco precedente (History From Below) tra i Top 10 albums del 2010, per cui partiva ben disposto verso questa attesa opera terza, ma davvero non ci siamo. La scelta è quella di allinearsi al generale ritorno agli anni 80, e arrivano buon ultimi ormai (Okkervil River, Paul Weller, Bright Eyes, Mark Lanegan, fermatemi perché posso tirare la fine della recensione solo con questo elenco), ma se è possibile con idee ancora più confuse sull'argomento dell'analogo disastroso tentativo dei Felice Brothers (vi rimando alla recensione di Celebration, Florida), perché il sound magniloquente di Tear It Up o il pasticcio new wave (un'onda che da loro arriva in ritardo di quarant'anni circa) di Money Saves davvero non trovano giustificazione se non nel voler esibire la propria versatilità.
In questi casi il recensore, sfiancato dall'interminabile e stancante muro di suoni a casaccio che regna più o meno per tutto l'album, prova a dirigersi verso la scrittura, nel tentativo di salvare il salvabile, e qui, raschiando la patina di orpelli inutili, affiorano perlomeno Idaho o Into The Darkness, e in generale una capacità di raccontare i disagi del proprio essere artista che segna comunque un punto a loro favore. Troppo poco però, il fallimento è tutto nel non essere riusciti a costruire un suono "loro", che li possa identificare tra i tanti, perché comunque non è certo questa l'essenza dei Delta Spirit, neanche di quelli che vorranno essere in futuro se proprio la vena freak-folk degli esordi gli sta così stretta. Altrimenti una buona retromarcia è caldamente consigliata.