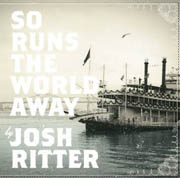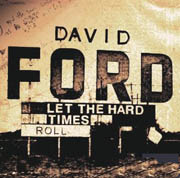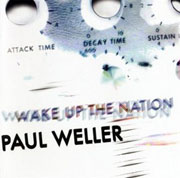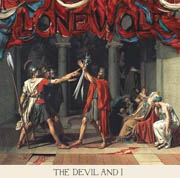
Domanda: si può essere dei completi cloni di altri e produrre un buon disco? Me ne esco subito poco elegantemente con il più ruffiano dei "dipende" e potrei anche chiudere la recensione qui, lasciandovi da soli a riflettere sull'argomento (confido esista ancora qualcuno che spende anche 5 minuti a cogitare su simili problematiche, altrimenti la recensione manco l'avrei iniziata…). Dipende da quello che cercate: volete un disco nuovo che vi sorprenda? The Devil And I dei Lone Wolf non fa per voi allora. Volete invece un disco al passo con i tempi e perfettamente calato nel clichè del miglior indie-rock anni 2000? Allora ci siamo in pieno. Sono svedesi, e questo già aiuta molto se è vero che un altro super-clone come il connazionale The Tallest Man On Earth è stato accettato dal gotha critico senza troppi problemi. Sono al primo disco, un esordio voluto da un'etichetta decisamente "trendy" come la Bella Union (Fleet Foxes, Andrew Bird, John Grant, Midlake, per citare i più à la page del momento) per far risaltare le potenzialità del giovane Paul Marshall, sconosciuto songwriter con all'attivo un disco acustico e solitario speso nel 2007 (Vultures), senza troppi ritorni economici, ma con tanti complimenti dai critici in patria.
Per la propria crescita musicale Marshall ha unito le forze con Kristofer Jonson, un veterano dell'attivissima scena svedese fin dai primi anni 90 con i suoi Jeniferever, e il risultato potrebbe essere il lato b inedito di The Sheperd's Dog di Iron & Wine. Di quel disco The Devil And I ha la stessa maniacale ricercatezza nell'utilizzo di mille strumenti, il far sembrare poco e scarno quel che è in verità tanto e polposo, l'insistenza sulle svariate percussioni come elemento di diversificazione tra un brano e l'altro, l'impianto acustico di base coperto da archi e tastiere di ogni tipo (molto bello il wurlitzer che apre This Is War) e anche qualche piccola sorpresa (nel finale di Keep Your Eyes On The Road affiorano pure delle elettriche incattivite e cori freak alla Port O'Brien, mentre i testi mistico-invasati sanno più di David Eugene Edwards dei Woven Hand). Ma al di sopra di tutto ciò c'è sempre quel folk morbido alla Nick Drake prima, alla Belle & Sebastian o alla Mojave 3 in seguito, alla Amandine (giusto per tornare in Scandinavia) dopo ancora, alla… (inviate il resto dell'elenco in redazione, vi regaleremo una recensione personalizzata con la vostra scelta).
Eppure sapete qual è il problema del vostro fidato recensore ora? E' dover giustificare il fatto che The Devil And I sia pur sempre un bel disco, che è vero che fra dieci anni ricorderemo altri artisti come capofila, e che forse dei Lone Wolf ce ne rammenteremo solo per stilare un elenco dei seguaci di (Will Oldham? Sufjan Stevens? Jens Lekman? Josè Gonzalez?…l'elenco s'ingrossa.), ma il disco gira che è un piacere, e la parte seconda della title track che chiude l'album entra di diritto nella playlist preferenziale di questo 2010. Se ve li vendono come un nuovo fenomeno diffidate pure, ma non fategli il torto di ignorarli solo per quello.
(Nicola Gervasini)