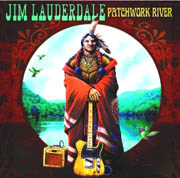+Pusiano.jpg)
Si dice che non bisogna giudicare un libro dalla copertina, eppure mi sembra che le copertine dei tuoi ultimi album esprimano con titolo e immagine due emozioni ben diverse: Canzoni per Uomini di Latta aveva una copertina aggressiva, che nascondeva una rabbia e una difficoltà a relazionarsi con questo mondo, O tutto o l'Amore sembra invece voler parlare di un uomo che ha trovato una sua tranquillità e la sua giusta dimensione. Laddove c'era un robot oggi c'è una strada ed un orizzonte. E' davvero cambiato così Evasio Muraro in questo ultimo anno?
Quella del robot è un'immagine che mi portavo dietro da parecchi anni, fin dai tempi di Settore Out, e come per molte altre cose, mi sembrava giusto ad un certo punto "chiudere", dare un senso compiuto a quei pensieri, a quelle sensazioni, a tutto un periodo. E' per questo che la copertina di Canzoni per uomini di latta mi sembrava un buon modo per fermarsi un attimo, e poi ripartire. Quindi non parlerei tanto di cambiamento, quanto di quella voglia di andare verso nuovi orizzontiche poi si è concretizzata con la copertina di O tutto o l'amore.
Nonostante il team produttivo sia rimasto sostanzialmente lo stesso, anche l'aspetto musicale ha subìto una radicale trasformazione. L'impressione è che Canzoni per uomini di latta aveva più varietà e ricchezza di arrangiamenti (e infatti anche più musicisti coinvolti), probabilmente perché c'era ancora una ricerca di un proprio stile definito, mentre O tutto o l'amore sembra essere approdato ad un sound più scarno, ma forse più personale e definito. E' così?
Non poteva che essere così. Considera che da quando ho deciso di lavorare a Canzoni per uomini di latta alla sua uscita sono passati due anni, con tutto quello che ne consegue. Per O tutto o l'amore sono passati solo sei mesi, due session con i musicisti, un giorno di incisioni per le tracce fondamentali. Ma più di tutto quando ho focalizzato Fidel Fogaroli alle tastiere e Stefano Bertoli alla batteria, ho capito di aver trovato una bella fetta del sound che andavo cercando e che non mi serviva molto altro. Quello che è rimasto lo stesso, è la quantità birra (ride).
Restando all'aspetto produttivo, quando scrivi una canzone pensi già subito a come la vorresti sentire suonata e arrangiata nella versione definitiva, o preferisci concentrarti sulle parole e sorprenderti del risultato quando lavori in studio?
Non ho una regola fissa. Fondamentalmente scrivo per la canzone in sé, solo con la chitarra: mi deve bastare così. Penso che sarebbe un grosso limite pensare che poi si potrebbe sostenere meglio con un buon arrangiamento, la canzone deve esistere da sola, non si può mica inventare. Certo non nascondo che poi mi piace molto lavorare in studio, e provare a sperimentare soluzioni nuove, soprattutto al fianco di quel folle genio di Daniele Denti.
Recentemente ci siamo incontrati in occasione di un piccolo concerto d'addio alle scene dei Groovers, la band con cui hai condiviso tanti anni come bassista. Mi ha colpito in quell'occasione la tua spiegazione alla decisione di sciogliere la band: "Non è più il mio rock questo" dicesti. Qual è il rock di Evasio Muraro oggi?
Mah, ripensandoci credo che nel concerto dell'addio dei Groovers ho rivissuto quello che non abbiamo fatto per i Settore Out, che alla fine si sono sciolti senza annunci e senza tante storie. Sono esperienze a cui ho dato moltissimo, che ho assimilato e che ho amato, ma l'elaborazione e poi tutto il lavoro su Canzoni per uomini di latta mi ha imposto di chiudere delle parentesi, e non è mai facile. Il mio rock oggi è quello delle scelte: da che parte stare, con chi stare, ma soprattutto cosa essere. E' stata una voglia di attenzione che le dinamiche di un gruppo, di una rock'n'roll band non ti consentono. E' stato un bisogno di pause che suonano più forte di una chitarra distorta, dell'ascoltare chi ha solo un filo di voce, ed è tutto quello che ha, del vedere chi è invisibile, dell'essere nauseato da continue promesse vane, dai miraggi, da una politica e una società vuote e svuotate, dell'essere in questo vortice e cercare disperatamente di non far spegnere quella scintilla che ancora cerco dentro me.

Quella dei Groovers era una musica figlia del "combat-rock" alla Clash, musica da strada e da rivoluzione collettiva, così come anche quella dei Settore Out, la tua prima storica band. Mi sembra invece che la tua musica oggi preferisca concentrarsi di più sulle sensazioni dei singoli. E' emblematica in questo senso Smetto Quando Voglio, una sorta di elenco delle battaglie piccole e ben poco mitizzabili della gente comune, cose semplici come smettere di fumare o di tradire la moglie. Sono davvero queste le nuove battaglie da combattere per te o semplicemente stiamo rinunciando a spenderci per qualcosa di più grande?
Eh, eh, in fondo non è poi così difficile essere un super eroe. Tu ci provi: se ti va bene sei super, se ti va male sei morto. Semplice, no? Ma quanto è difficile combattere nella quotidianità? Difendersi dall'apatia? Fare un piccolo passo avanti giorno dopo giorno tenendoci ben stretto quello che abbiamo costruito con tanta fatica…essere coerenti ma non ottusi, avere il sorriso sulle labbra e nel cuore ma essere determinati ricettivi, ma non condizionabili. Questa è la vera rivoluzione, per me.
Se, uno dei brani più belli del disco secondo me, è in verità nato vent'anni fa all'epoca dei Settore Out. Cosa aveva ancora da dirti questa canzone dopo così tanto tempo?
Se c'è una cosa che ho imparato lavorando prima a Canzoni per uomini di latta e poi a O tutto o l'amore è che il nostro tempo e quello delle canzoni sono due variabili diverse. Anche Raccolgo la vita mi è rimasta lì nel cassetto per vent'anni e poi, in una sera, eccola lì, che arriva. Il discorso di Se è simile, anche se diverso: è una canzone che amo e l'avevamo inciso in quello che reputo il più bel disco di Settore Out che, ironia della sorte, non è nemmeno mai uscito e guarda caso la prima volta che l'ho suonata, a Spaziomusica l'anno scorso, durante il Distrattour, c'eravamo tutti ed era la prima volta che ci ritrovavamo negli ultimi anni. Da allora è rimasta fissa nella scaletta dei miei concerti e, visto che non era mai uscita in versione "ufficiale", mi è sembrato giusto metterla in O tutto o l'amore.
Nel disco ci sono tre cover. Ballata dell'Estate Sfinita era un brano del disco Falene di Giancarlo Onorato, disco bellissimo di un autore poliedrico quanto misconosciuto, nonostante vanti più di trent'anni di carriera. Cosa deve comunicare secondo te una cover che non sia stato già comunicato dall'autore?
Nulla, assolutamente nulla. La differenza è che nell'interpretare una canzone, cerco di succhiarne tutta la linfa vitale, solo per me stesso. E' un'ammissione dei propri limiti, no? Vorrei averla scritta, ma dato che non è così non è, mi faccio un regalo, se poi lo faccio anche ad altri, tanto meglio.
Invece Se Perdo Anche Te è la rilettura in chiave "italian-country" (se mi perdoni la definizione..) della stranota Solitary Man di Neil Diamond. Anche se credo che qui abbia giocato molto la versione che diede Johnny Cash sugli American Recordings, o sbaglio? Pensi che il fatto che il pubblico conosca più o meno bene l'originale, abbia influito sul tuo modo di reinterpretare il brano?
Anche quella è una canzone che mi ha seguito per tutto il Distrattour. Devo dire che la figura di Johnny Cash mi ha lasciato un segno, perché oltre a Solitary Man, mi ha colpito sempre la sua versione di One degli U2. Però quando ho sentito la "sua" Solitary Man mi sono ricordato di una melodia di molto tempo fa e allora ho chiesto a mia sorella, che a qualche anno più di me, e lei mi ha fatto ricordare la versione di Gianni Morandi. Per cui per tutto il Distrattour, ho suonato un patchwork tra la Solitary Man di Johnny Cash con le parole in italiano. Dato che era piaciuta ovunque, mi piaceva lasciare una traccia, ma al momento di registrarla, ho lavorato per sottrazione e alla fine sono rimasti sono il banjo di Dino Barbé, il dobro di Gnola e le belle voci dei Gobar. In qualche modo, sarà l'atmosfera, mi ricorda la Carter Family, e forse anche questo è un cerchio che si chiude.
La terza cover è O cara moglie di Ivan della Mea, che in un certo senso tradisce quanto dicevamo prima, e riporta il disco da una dimensione intima ad una battaglia sociale e comunitaria come quella sindacale.
Ammetto che quando l'ho risentita ho pensato potesse essere anacronistica ormai, poi mi sono passate davanti le immagini degli operai FIAT che votavano mestamente il loro futuro a Termini Imerese, senza neanche poter più combattere con dei "porci padroni" in carne e ossa, e mi sono chiesto se lo stesso Ivan (Della Mea) oggi la scriverebbe ancora così. Ma poi, penso che di anacronistico oggi ci sia la nostra classe dirigente ed il modo di porsi, ma soprattutto di pensare della classe operaia, a chi lavora. Non possiamo opporci a chi ha in mano il potere e poi nel nostro intimo ambire ad esser come loro, vivere come loro, pensare come loro. Ivan Della Mea aveva colto un grande punto fermo, ed è qui che è attuale più che mai, che è il dialogo aperto con il proprio figlio, ma che penso sarebbe utile anche nel confronto con le istituzioni, a partire dai sindacati che una qualche riflessione su questi argomenti prima o poi dovranno farla.
Sussurrami canzoni omaggia ancora Ivan Della Mea e Enzo Jannacci, ma più in generale mi è sembrata una dichiarazione di appartenenza ad un certo modo di scrivere canzoni raccontando le storie dell'uomo semplice, che è tipica della canzone milanese. Ti senti davvero artisticamente figlio di questa tradizione?
Non proprio, come dicevamo vengo da esperienze più rock, che sono una parte di me. Anche se devo ammettere che su un binario parallelo ho sempre avuto un certo interesse per la cultura popolare e tradizionale, per esempio per la canzone in dialetto milanese, che adoro.
Un'ora d'aria è forse uno dei momenti più tesi del disco, il più vicino ad un idea di rock italiano alla Alberto Fortis. La definirei "infastidita" più che arrabbiata, una riflessione sul tempo che perdiamo in inutili chiacchiere che sembra proprio volerci dire che il nostro male è proprio il quotidiano che siamo costretti a vivere. Val la pena combatterlo o siamo condannati a dover sopportare in silenzio?
Mai sopportare in silenzio, mai mettersi sullo stesso piano di chi non condivide le nostre idee. Noi proponiamo il dialogo sul nostro terreno, noi evitiamo lo scontro frontale, noi gettiamo i semi per l'albero della civiltà. Magari una canzone non cambierà nulla, ma vuoi mettere la bellezza di una melodia con l'orrido squallore di una congiura?
Parafrasando una celebre frase di Roberto Freak Antoni, che diceva che in Italia non c'è gusto ad essere intelligenti, che gusto c'è in Italia a fare il cantautore oggi?
È il gusto di pensare di aver scritto qualcosa di buono, di avere una piccola dignità da salvaguardare, di essersi inventati una strada, di aver inseguito un'idea. Suppongo che questo valga per tutte le professioni, i mestieri. C'è gusto nel mettere un seme, di legarsi alle radici. E' solo questo, ma non è poco.
Non ti chiedo gli album da isola deserta perché ho pietà di te, però dimmi invece un disco non tuo che potrebbe tranquillamente esserlo, che ti rappresenta e descrive in pieno.
Due anni fa avrei risposto Sky Blue Sky degli Wilco, una rock'n'roll in cui mi ritrovo moltissimo. Oggi ti dico Josh Ritter: il suo So Worlds Run Away è fisso nel mio lettore da quando è uscito e dubito che ne verrà fuori presto. Un grande disco, con molte idee che sento vicine.
Chi è che invece potrebbe sentirsi pienamente descritto da Evasio Muraro oggi?
Nessuno direi, già non è semplice rappresentare se stessi, figurarsi qualcun altro. Ti dirò invece che mi basterebbe riuscire a descrivere un momento, una piccola storia, un personaggio. Sarebbe già un bel traguardo.
http://www.evasiomuraro.com/