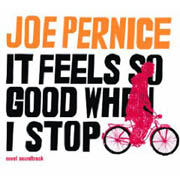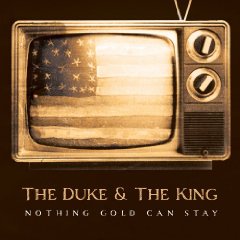Novembre 2009
Buscadero
Così come il buon giorno si vede dal mattino, i bei dischi si riconoscono spesso fin dalle prime note. Basta quindi la corale Coal War, stupendo brano sospeso a metà tra uno spiritual, una work-song di protesta e il Paul Simon di Diamonds On The Soles Of Her Shoes, per capire che sta succedendo qualcosa di importante in questo Build Me This, secondo atteso disco di Joshua James. Succede ad esempio che ci troviamo davanti ad un artista già in grado fin dal secondo disco di cambiare suono, stile e registro delle proprie canzoni, di osare arditi arrangiamenti, anche pesanti e magniloquenti in alcuni casi, laddove avrebbe potuto continuare a raccogliere i consensi avuti insistendo sullo stile intimo e sospirato del suo primo disco (il buon The Sun Is Always Brighter ) o dei successivi EP. Lui invece, in combutta col giovane amico e produttore Shannon Edgar, si inventa un disco strafottente, che azzarda pure impensabili (per lui ovviamente) hard-blues come Black July, irish-folk balzellanti alla Waterboys (Annabelle) e tocca pure l’epica da cowboy con Mother Mary, un brano che Sergio Leone avrebbe utilizzato per un nuovo spaghetti western al fianco di Outlaw Pete di Springsteen. Normale quindi che chi si aspettava la nuova colonna sonora delle proprie disgrazie, si possa sentire spiazzato davanti all’imponenza di certi muri del suono ottenuti sfruttando tutti i registri delle tastiere di Phil Parlapiano, e magari inizialmente cerchi conforto nei brani più chiusi come Weeds, Pitchfork o In The Middle, i più vicini al James dell’esordio, quanto alla fine i meno interessanti. E magari lamenteranno l’appeal radiofonico sospetto (quanto irresistibile) di Magazine, brano degno del miglior David Gray nel descrivere la fine di un rapporto trovando il giusto equilibrio tra tragicità, melodia e un occhio al marketing discografico. James ha rischiato tanto in questo disco, e questa è oggi una dote rara, perché è vero che ogni tanto qualcosa non funziona, che il disco alla fine appare sfilacciato e che l’amalgama presenta qualche grumo ancora da sciogliere, ma presi singolarmente anche brani che appaiono minori come la country-song Lawn Full Of Marigolds o la sospesa Kitchen Tile conservano una grande tensione emotiva alla Ray LaMontagne, probabilmente il nome che più James aveva in mente. L’apoteosi arriva con Daniel, non quella di Elton John, ma che proprio all’Elton John più abile a giocare con cori, tastiere, teatralità e spinta drammaticità, finisce per richiamarsi. Buono anche il finale con la poetica Wilted Daisies e l’ultima riflessione acustica di Benediction, giusta chiusura di un disco che conferma James come uno dei migliori talenti di questi ultimi anni, sebbene una certa incompletezza generale faccia pensare che possa ancora andare oltre.
Nicola Gervasini
Nicola Gervasini