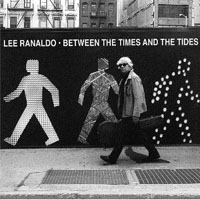FATHER JOHN MISTY
FEAR FUN
Bella Union
***1/2
Trattasi di una eccezione alla regola: se nel rock l’unione di grandi
talenti ha sempre sortito risultati inferiori alla somma dei due fattori, ecco
che invece il mondo indie può bearsi della buona riuscita dell’atteso progetto
a nome Father John Misty. Lo scontro
qui è tra titani di genere: da una parte il padrone di casa, quel J. Tillman che dal 2003 produce dischi
da sottobosco spesso portati su un palmo di mano dalla critica specializzata
(su tutti forse Vacilando Territory Blues
del 2009), trovando magari anche il tempo di fare il batterista dei
pluridecorati Fleet Foxes (ma l’esperienza pare essere stata definitivamente
accantonata). Dall’altra parte c’è invece il produttore, lo stesso Jonathan Wilson che l’anno scorso ha
strabiliato con al sua West Coast music riletta in chiave freak-folk del
bellissimo album Gentle Spirit, album
dal mood all’antica riportato
fedelmente anche in questi solchi. Ne è uscito Fear Fun, convincente
patchwork di tutte queste esperienze, quelle di folk minimale (Funtimes in Babylon), i muri vocali alla
Beach Boys/Fleet Foxes (Nancy From Now On, O I Long To Feel Your Arms
Around Me), le pesanti e ipnotiche cavalcate percussive (Hollywood Forever Cemetery Sings), ma
anche ballate folk classiche (la bellissima I’m
Writing A Novel o Tee Pees 1-12 e Misty’s Nightmares 1 And 2, quasi un
country-rock d’altritempi) e orchestrazioni elaborate (Now I’m Learning To Love The War). In alcuni casi sembra di sentire
il Bonnie Prince Billy più variegato di Beware
(This is Sally Hatchet potrebbe
tranquillamente essere un suo brano), con un bagaglio pieno di omaggi agli eroi
del passato che regala risultati addirittura vicini a certe soluzioni vintage
alla Ray LaMontagne (Well, You Can Do It
Without Me). Concentrato non solo a scrivere brani ma anche a scegliere la
giusta veste con cui presentarli al pubblico, Tillman realizza così la sua
opera più accessibile, dove per la prima volta episodi come Everyman Needs A Companion riescono
subito a farsi memorizzare e richiedono una coralità e una partecipazione che
contrasta lo spirito solitario e depresso dei testi dell’autore. Perchè poi la
presentazione del disco parla del solito parto dell’artista che non si abitua
al mondo, ma stavolta il risultato è solare e pieno di vita, pure quando le
liriche calcano la mano sulla malinconia. E sta proprio in questa salutare
contraddizione il lato più positivo di questo progetto.
Nicola Gervasini