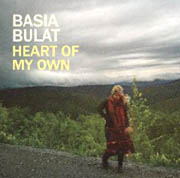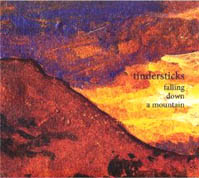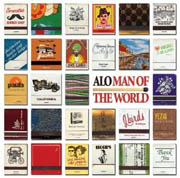
Rootshighway
Man Of The World non fa eccezione se dovessimo elencare pregi e difetti di queste produzioni, che mischiano sempre troppe idee, troppi stili, hanno sempre momenti altissimi affiancati da lungaggini o esperimenti fini a se stessi. Esattamente quello che ha impedito a band come Phish o Widespread Panic di uscire dal rango di cult-band a livello di uscite discografiche (non certo come entità del loro seguito, che resta enorme), nonostante a ben guardare il loro repertorio sia pieno di grandi canzoni e momenti memorabili, ma che vanno ben cercati in mezzo ad un mare di note only for fans. E qui di memorabili ci sono i sette minuti di Suspended che aprono il disco, brano emozionante, incedere lento e sofferto alla Felice Brothers, interpretazione da antologia del leader Zach Gill e applausi già conquistati. Peccato che poi il disco non viaggi sempre sullo stesso livello (ma sarebbe stato difficile), e se grazie alla divertente title-track e alla toccante Put Away The Past si procede a buona velocità di crociera, quando si arriva a cosette un po' più inconsistenti come Big Appetite o Gardener's Grave si atterra nuovamente.
Nel finale comunque subentra l'estro e la fantasia della band, quelle che rendono le danzerecce The Champ e I Love Music un finale con i fiocchi e The Country Electro un riuscito azzardo. Ma come ben potete notare, ci siamo ricascati, stiamo leggendo il particolare e analizzando il dettaglio, quando gli ALO sono solo una di quelle american-band che vanno considerate nell'insieme di un movimento culturale. Colpa nostra che ci ostiniamo a pensare ancora i dischi in termini di opera d'arte e non di semplici contenitori di canzoni a casaccio, forse perché siamo davvero un po' come Totò, che in Totò a colori disse "Non si preoccupi, sono un uomo di mondo", ma aggiunse "ho fatto 3 anni di militare a Cuneo".
(Nicola Gervasini)