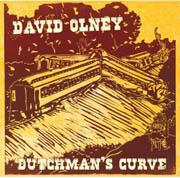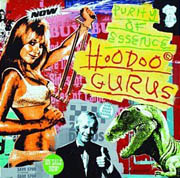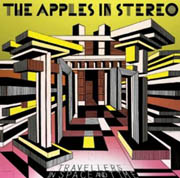
Se le vie della contaminazione e dell'eclettismo musicale a tutti i costi sono davvero infinite, gli Apples In Stereo sono sicuramente una delle band dell'ultimo ventennio che più ha tentato di viaggiare nello spazio e nel tempo per cercare quel limite impossibile. D'altronde questa formazione americana è nata nel 1992, uno degli ultimi anni sacri della creazione rock, tempi in cui nell'underground del mercato discografico il rock indipendente e il mondo dell'elettronica (se non proprio dei disc-jokey visto che erano gli anni in cui si sviluppava anche il big beat dei Prodigy e dei Chemical Borthers…) cominciavano a flirtare con alcuni risultati di indubbio interesse. Da allora la band è rimasta sempre sotto l'ala del leader Robert Schneider, vero padre-padrone di un gruppo che ha visto molte defezioni e che per questo settimo capitolo della saga (Travellers In Space And Time appunto…) acquista come membri fissi ben tre new entries (John Dufilho, Bill Doss e John Ferguso).
Tornati a far parlare di sé dopo un lungo silenzio nel 2007 con il come-back album New Magnetic Wonder, album di buon successo che ha spinto la Yep Roc a pubblicare lo scorso anno la loro prima raccolta di successi (#1 Hits Explosion), Travellers In Space And Time continua sulla strada di un rock indipendente fatto di brani brevi e incisivi di matrice power-pop, infarciti di elementi tipici della dance e dell'elettronica (non metteremmo più la parola "moderna", visto che certe soluzioni cominciano ad avere vent'anni buoni e nuove certo non sono). Il disco presenta 16 titoli, un bel tour de force tutto ritmo (Dance Floor) e viaggi nello spazio da b-movie (C.P.U. sembra uno di quegli esperimenti tutto circuiti e robotica che si ascoltavano spesso nei primi anni 80), ma anche di piacevoli pop-song (No One In The World) che evidenziano, in tutta la loro finta leggerezza, la passione mai nascosta della band per il mondo musicale dei Beach Boys, o addirittura riff rock rubati agli Who di Can't Explain (Dignified Dignitary).
Impossibile in questa sede citare tutti i brani, alcuni episodi come No Vacation, Nobody But You o Dream About the Future sono evidentemente il frutto di mille idee e ripensamenti in fase di produzione, e forse meriterebbero più attenzione e il giudizio del tempo per capirne l'effettiva portata, ma l'impressione generale è che questo sia un disco di una band ormai entrata nel novero degli "storici" che semplicemente continua a professare quel verbo nato tra i dischi degli Style Council, evidentemente consumati in gioventù, e più recentemente degli Air. Se possa essere di vostro interesse e godimento dipende solo da dove eravate e cosa stavate ascoltando 15 anni fa.
(Nicola Gervasini)