OKKERVIL RIVER STORY: Will Sheff e la ricerca di Vera Vasilevna
“Quando il sole si muove nel segno dello scorpione, il clima diventa
ventoso, scuro e piovoso”.
Ecco come inizia un bel racconto,
con una frase apparentemente nata dal nulla, gettata in pasto al lettore proprio
quando lui non stava minimente pensando al tempo. Ma Will Sheff amava questi particolari, erano la sua ossessione al
college ogni volta che provava a filmare quelli che nei suoi sogni sarebbero
diventati i primi cortometraggi di un grande regista. E quei racconti di una
misconosciuta autrice russa sembravano ideali per trarre la sceneggiatura di un
esordio d’effetto, di quelli che ti fanno sembrare un uomo di grande cultura, perché
esibire nomi sconosciuti da sempre l’impressione di conoscere a fondo un argomento.
Eppure ogni volta che provava a riscrivere la storia e a pensare al film,
qualcosa non andava, l’ispirazione giusta non arrivava mai. Finché poi capì
qual’era il problema: la parole di quel racconto di Tatyana Tolstaya non gli
evocavano immagini, ma suoni. Erano i suoni che sentiva il protagonista Simeonov,
un solitario traduttore di brutti libri che non voleva cedere a sposare la
normale e rassicurante Tamara solo per seguire il sogno di conoscere Vera Vasilevna,
una diva della musica decaduta e ormai scomparsa dalle scene. Will cercava
d’immaginarsi il film, ma alla fine era come se continuasse a sentire anche lui
quel “vecchio e pesante disco di
antracite colorata, non deturpato dai monotoni cerchi concentrici, con una
canzone d’amore per lato.” Non aveva ancora in mente di fare veramente il musicista
quando incontrò Seth Warren e Zachary Thomas,
compagni di un college dello New Hampshire, ma soprattutto sezione ritmica
improvvisata per le prime uscite in pubblico. Era la fine del 1998, Will aveva
22 anni e ancora troppe letture sulle spalle per avere le idee chiare su dove andare
a parare nella vita. Quando nel gennaio del 1999 i tre fecero il loro primo
concerto, Will si ricordò di quel racconto, e si ricordò di come si era immedesimato
in Simeonov, che paragonava la diva dei propri sogni ad un fiume che un tempo fu
bellissimo, ma che ora era deturpato da fabbriche e nuovi quartieri
residenziali. L’Okkervil River però,
nell’omonimo brano della Tolstaya, tagliava ancora la parte est di Leningrado
con spavalda fierezza, con le barche che lo intarsiavano esattamente come la
puntina del giradischi fendeva i solchi del 33 giri. Nacque così il nome della
band, un’immagine perfetta per quel folk strano che veniva fuori dalla chitarra
di Will. Che musica facevano gli Okkervil River? Nessuno al college era in
grado di definirlo, pare che Will si fosse improvvisamente “intrippato” con i
dischi della Incredible String Band, ensamble degli anni 60 che il folk lo
avevo preso come pretesto per una musica stramba e irripetibile, psichedelia
che si era spinta fino a confini indefinibili, rimasti inesplorati per almeno 3
decenni in cui il rock era andato altrove. Ma qualcosa in quella fine degli
anni 90 stava cambiando, nelle vene del mercato discografico indipendente
scorreva una nuova linfa che nutriva il rock con un folk scarno e minimale, un
nuovo corso animato da nomi come Will Oldahm, Smog, Sparklehorse. Uno stile che
anche le riviste di musica sparse nella sua stanza stentavano a definire, pure
quando nel 1998 avevano decantato le lodi di un disco come In The
Aeroplane Over The Sea di quello strano gruppo chiamato Neutral Milk Hotel.
Un disco che Sheff aveva ascoltato fino alla nausea, innamorato di quel sound
primordiale, non più legato a canoni classici, ma libero di spaziare, di
deviare, di stonare anche. Già, perché Will era sempre stato un po’ stonato,
uno di quelli che quando si canta in compagnia cerca di raggiungere note a lui
non consentite gracchiando e deragliando rovinosamente. Quando gli Okkervil
River si esibirono per la prima volta allo Steamboat, si presentarono già con
un cd masterizzato intitolato The Bedroom
EP, roba grezza creata davvero nel suo dormitorio da studente, quanto basta
per dare una prima idea della band. Vale a dire nessuna idea precisa.

“In giorni come questi, quando la pioggia,
l’oscurità e il vento che batte sulle finestre riflettono la solenne faccia
della solitudine…”
All’inizio dell’estate del
1999 Will Sheff è nel pieno della depressione, I suoi propositi da regista non
trovano sviluppi, e il progetto Okkervil River non sembra aver suscitato
l’interesse sperato. Si era di nuovo chiuso nella sua stanza per scriver nuove
canzoni, esattamente come Simeonov nel
racconto della Tolstaya si isolava in camera per sognare, ascoltando il disco
della sua diva perduta. Ma nulla più usciva dalla sua chitarra, solo un’ossessiva
voglia di riascoltare quanto aveva registrato con i suoi amici l’anno prima in
soli tre giorni. Ma esattamente come Simeonov non si era dato per vinto
e si era veramente messo a cercare la sua Vera per le vie di Leningrado, così
Sheff da quella stanza uscì con due decisioni: la prima era quella che nella
vita avrebbe semplicemente voluto fare il fallito, la seconda che avrebbe
pubblicato quei nastri di registrazioni casalinghe. Vera d’altronde viveva da
qualche parte in Leningrado, dimenticata da tutti meno che da quei pochi
ossessivi fans che collezionavano i suoi dischi come cimeli. E così vivevano
quelle canzoni, nel suo cassetto, visitate ossessivamente solo dal loro
creatore, nonché unico fan. Stars Too Small to Use è nato così, 31
minuti di musica registrata in presa diretta, negli anni 60 un minutaggio
normale per un disco, nei 90, dopo la sbornia dei cd a lunga durata e la moda
di fare album di 70 minuti, il disco venne catalogato come EP. Ancora oggi le
canzoni di quell’esordio sono oggetto di discussione tra i fans, ma che la
poetica di Sheff non sarebbe andata per sentieri convenzionali lo si capiva
subito dal personaggio descritto in Auntie Alice, una zia che potrebbe
anche essere un simulacro sessuale da commedia sexy, di quelle che ti svegliano
in mezzo la notte per offrire dolce cioccolato proprio quando gli ormoni
richiedono vittime, ma anche un personaggio oscuro e quasi tetro, che alleva
ragni e ulula nei boschi con la sua bocca sdentata. In ogni caso nel disco si
raccontano omicidi passionali (Kathy Keller), storie di pura alienazione
sociale (Oh Precious), segni di una contorta religiosità sospesa tra
redenzione e rifiuto di un Dio e semplice ansia per la vita (For The Captain
o The Velocity of Saul at the Time of His Conversion), oscuri presagi (He
Passes Number Thirty-Trhee) e la normale paura del futuro di chi della
strada che percorre vede solo l’inizio (Whole Wide World). Tutte storie
lontane dal binomio donne spezzacuori/ubriacature moleste di eroi di frontiera
che popolava il 90% delle canzoni partorite dall’industria discografica di
Austin.

“…un muto, soffocante e puzzolente fumo, o
qualcosa’altro di disperato, provinciale e banale.”
Alla
fine di uno dei soliti concerti in cui si aveva difficoltà anche a far
pronunciare correttamente il nome della band dai presentatori (Okkerut River, Occerville River, venne fuori di tutto),
Sheff venne avvicinato da un giovane che gli disse “siete la cosa peggiore che
io abbia mai sentito…ma so per certo che lo avete fatto apposta”. Jonathan Meiburg entrò nel gruppo così,
grazie ad un insulto. In dote portava una perizia tecnica superiore, nata in
ore e ore di studio ossessivo degli assoli di David Gilmour, ma anche la
capacità di suonare più strumenti a corde, tastiere, percussioni…sembrava
davvero che quel ragazzo potesse governare qualsiasi oggetto in grado di
emettere suoni. Poi arrivò un articoletto sull’Austin Chronicle, uno di quei
trafiletti bonari e compiacenti verso qualche giovane band, ma abbastanza
preciso da captare l’attenzione di Brian
Beattie, musicista che Will Sheff conosceva bene perché aveva registrato
con Daniel Johnston, paladino di quella Austin più oscura che ovviamente lui
aveva preso a modello. E’ nel garage di Beattie che è nato nel corso del 2000 Don’t
Fall in Love with Everyone You See, esattamente quell’opera che nei sogni
di Sheff gli avrebbe aperto le porte della riconoscenza del mondo musicale e
soprattutto reso giustizia alla sua arte, esattamente come Simeonov voleva
render giustizia alla dimenticata Vera. Ma qualcosa andò storto, Jeff inviò i
nastri a tutte le case discografiche della zona, ma dopo un anno l’unica
risposta semi-positiva l’aveva data la Jagjaguwar, interessata al prodotto ma
con poche possibilità di pubblicarlo a breve. E così quelle nove canzoni
restavano lì, nel cassetto, a sentirsi da sole e ad invecchiare come Vera. Ma
Sheff credeva in quelle registrazioni, le aveva studiate e ristudiate, aveva
deciso che Red (un triste valzer che
narra di una madre che vede nei facili costumi e nella vita dissoluta della
figlia i segni del proprio fallimento di genitore) avrebbe aperto le danze del
disco, che il viaggio a ritmo di slow-country in cerca di cocaina e perdizione
della coppia di Kansas City avrebbe
continuato il tragico racconto, e che la sofferta Lady Liberty, ambigua tra il suo essere una canzone di amore
irrisolto o una metafora politica, avrebbe impedito all’ascoltatore di
rilassarsi veramente. Perché poi sarebbe arrivata My Bad Days, una mazzata emozionale, un rito funebre delle proprie
paure, lenta, triste, quasi insostenibile nell’interpretazione rotta e
piagnucolante della voce, e poi ancora Westfall,
tesa murder-song vicina al country di Austin, dove l’amicizia di due ragazzi
sembra essere l’unico movente possibile per il fatto che abbiano ucciso le
ragazze appena rimorchiate, visto che quando i poliziotti guardano negli occhi
uno dei protagonisti per cercarvi il male, scoprono quanto esso sia
irriconoscibile e fortemente somigliante al nulla. Will aveva frenesia di far conoscere
al mondo il suo lavoro a due voci con il mito Daniel Johnston (Happy Hearts), la corsa dei mandolini di
Dead Dog Song, e si rifiutava di
lasciare nell’oblio una canzone come Listening
to Otis Redding at Home During Christmas, dove al verso “casa è dove i
letti sono fatti e il burro è spalmato sul toast”, fa eco un Will che ribadisce
che no, casa è dove nello stereo risuona I’ve
Got Dreams To Remember di Otis Redding. Il finale del disco era invece
affidato ad Okkervil River Song, non
la storia del racconto della Tolstaya, ma un triste ricordo di bei momenti
passati sul fiume con una donna che al risveglio non c’è già più. Troppa
tristezza forse? Eppure in quegli anni la musica non esprimeva certo gioia
neppure alla radio, il gruppo più acclamato della fine degli anni 90 erano
stati i Radiohead, che avevano insegnato al mondo a sondare le tragedie
personali senza alcuna remora stilistica, e le cose più rassicuranti che
uscivano dal mondo del nuovo folk erano i gruppi soft-core come Belle &
Sebastian o Arab Straps, musica molto melodica che faceva della malinconia il
proprio dardo infuocato. Ma quel mezzo folk mezzo country mezzo non-so-chè
degli Okkervil River non aveva senso per nessuno, e quando nel settembre del
2001 Will vide le torri di Ground Zero cadere in una massa di fumo e fuoco, la
sensazione che la tragica realtà non potesse più essere sublimata da nessuna
arte lo mandò in depressione totale.
Nel
gennaio del 2002 finalmente la Jagjaguwar trovò spazio per il disco nel suo
catalogo, senza dannarsi troppo nella promozione. Don’t Fall in Love with Everyone
You See vendette poco in proporzione alle positive recensioni che
ricevette, per cui via a squallidi tour con notti passate per terra e tanti
concerti senza paga se non la birra e la bistecca di sopravvivenza. Una vita
che Seth Warren decise di abbandonare, mentre Sheff e Mellburg passavano le ore
a scrivere canzoni e a scambiarsi idee artistiche, un’intesa che aveva bisogno
di uno sfogo personale per Jonathan, che chiese all’amico di fondare un
progetto parallelo che battezzarono in quell’estate del 2001 con il nome di un
uccello marino, Shearwater.
Suonò alla porta di Vera. “Pazzo” gli disse
il suo diavoletto sulla sinistra.
La Jagjaguwar fu comunque soddisfatta dei risultati e per il secondo
capitolo spedì la band a San Francisco a cercare ispirazione e suoni giusti.
Sheff si sentiva ora davvero come Simeonov, che incurante dei pericoli che la
coscienza gli evidenziava, si reca a casa di Vera per vedere se davvero il suo
mito era così malridotto, immaginandola romanticamente abbandonata nella
propria arte, accantonata dall’ignoranza comune, incapace di leggere nei solchi
dei suoi vinili la sublimazione massima del suono dell’amore. Il risultato
delle sessions, registrate con la nuova formazione a quattro comprendente
Meiburg, fu il disco Down The River Of The Golden Dreams,
album indolente e melmoso come le acque dell’Okkervil River descritte dalla
Tolstaya. Il titolo divenne fin da subito un nuovo caposaldo dell’indie-rock,
definizione che nel 2003 aveva ormai assunto una consolidata connotazione. Il
disco era perfettamente dosato tra il suo essere sofferto fin dalla micidiale
accoppiata iniziale It Ends With A Fall
e For The Enemy, ma musicalmente
presentava un inedito “wall of sound” che aveva perso tutto il folk minimale
degli esordi in favore delle maestose aperture strumentali di Blanket And Crib, fatte di organi
hammond, fiati, archi. Mancavano giusto i cori femminili perché si potesse
tranquillamente parlare di una nuova via lo-fi del Phil Spector-pensiero. Anche
la scrittura di Sheff era cresciuta vertiginosamente, capace di toccare vette
letterarie come The War Criminal Rises
And Speaks, sorta d’imparziale processo ad un carnefice, visto sia con gli
occhi di chi racconta che del criminale stesso, che invita a considerare la sua
situazione umana prima di giudicare. In
ogni caso tutto suona maturo, anche la nuova versione di The Velocity Of Saul At The Time Of His Conversion, non più
sofferta e urlata come sul disco d’esordio, ma tranquilla e ragionata, oltre
che impercettibilmente più arrangiata. Nonostante il grande dispiego di session
men e strumenti, non c’era comunque nessuna concessione alla spettacolarità,
brani come Dead Faces o Maines Island Lovers richiedevano un
ascolto attento sia alle liriche sempre piene di trabocchetti e sensi nascosti,
sia alle contorte trame sonore, raramente orecchiabili fin da subito (solo Song About A Star ricorreva ad un
ritornello realmente riconoscibile al primo ascolto). Un disco inviluppato nel
suo esistenzialismo (Yellow), ma
meravigliosamente dosato in ogni sua componente, anche quelle inevitabilmente
più melodrammatiche e auto-compiacenti (Seas
Too Far To Reach).

“O beata solitudine! La solitudine mangia
direttamente dalla padella, trafigge una fredda polpetta di carne direttamente
da un sudicio mezzo vasetto, fa il tè direttamente nella tazza, insomma…Pace e Libertà!”
Ormai
riconosciuti dalla critica e già eletti a gruppo cult dalle nuove generazioni,
gli Okkervil River nel 2005 licenziano la loro opera più ambiziosa, Black
Sheep Boy. Libero di muoversi artisticamente, Sheff allarga la formazione
a sei elementi, e utilizza un personaggio uscito dalla penna del cult-songwriter
Tim Hardin per dar vita ad una sorta di concept che unisce tante storie diverse,
dove è sempre comunque centrale la figura di una “pecora nera”, ragazzi
frustrati (For Real), depressi (In a A Radio Song), o anche abusati (Black). Mai come in questo disco il
mondo di Sheff si popola di freaks che non sono solo quelli della tetra
copertina di William Schaff, ma anche personaggi che manifestano sempre un’impossibilità
di amare che spesso è forzata da una realtà che non li accetta, come nel brano A Stone (ma il finale rivelatorio della
storia sarà nel brano Song Of Our
So-Called Friend), dove anche il classico triangolo da tragedia
lui-ama-lei-ma-lei-ama-un-altro si trasforma in una grottesca storia degna di
un film di Tim Burton, dove lei, piuttosto che amare lui, ama un altro ormai
morto e ridotto a pietra tombale. Forte poi anche di un EP chiamato Appendix che nelle successive riedizioni
renderà l’opera doppia e forse fin troppo monumentale, Black Sheep Boy musicalmente riusciva a tenere un perfetto
equilibro tra le sue atmosfere dark e deprimenti e la grandeur di strumenti e
muri del suono, quasi che Sheff abbia realizzato con successo e con 28 anni di
ritardo quanto Leonard Cohen e Phil Spector avevano rovinosamente tentato di
fare con l’album Death Of A Ladies Man.
Le reazioni della critica furono entusiaste, anche se il disco si rivelò ostico
e contribuì a dare alla band la fama di indie-band per intenditori di nicchia.

“Vera Vasilevna è morta, morta da tanto
tempo, uccisa, smembrata e mangiata da questa vecchia signora”
Simeonov
alla fine del racconto scopre che il suo mito Vera è diventata una patetica
signora, ancora circondata da adulatori e uomini piccoli che le ricordano
quotidianamente la propria antica grandezza. Una scena squallida che fa capire
la differenza tra mito e realtà, il tradimento finale della star rispetto al
fan che viveva “nella” e “per la” sua immagine. Sembrò quasi logico dunque il
“tradimento” operato con il successivo The Stage Names, senza dubbio il disco più accessibile e public-friendly della band, concepito da Sheff proprio per essere
un altro lungo concept sul quanto l’arte abbia saputo produrre allo stesso
tempo opere durature o immense patacche, e dunque su quanto i “nomi d’arte” del
titolo non mettano al riparo le star dalle miserie della vita (Our Life Is Not A Movie Or Maybe è il
significativo titolo che apre l’album). La girandola di stili che anima l’album
è stordente, dalla lunga Girl In Port
che strizza l’occhio a Van Morrison ad una A
Hand To Take Hold of The Scene che mette in vetrina addirittura riff da rock-band,
e altrove ancora influenze soul che cominciano ad allontanare la band del
freak-folk a cui venivano generalmente associati. Tantissimi i riferimenti ad
opere musicali: John Allyn Smith Sails richiama nel finale Sloop John B dei Beach Boys, il titolo del brano You Can’t Hold the Hand of A Rock And Roll
Man ruba un verso di Blonde in the Bleachers di Joni Mitchell, Plus Ones è una sorta di gioco a comporre un testo con titoli di
altre canzoni aggiungendoci un uno ad ogni numerazione (ad esempio: TVC15 di Bowie diventa TVC16, le 96 Tears dei ? & The Mysterians qui sono 97, ecc..) Ma anche
reminiscenze letterarie (Title Track
è ispirata dal libro scandalo Hollywood Babylon
di Kenneth Anger), cinematografiche (Savannah
Smiles è la storia della nota pornostar Savannah, A Hand to Take Hold of the Scene descrive le loro esperienze nel
mondo delle serie TV) e tanto altro che ogni fan possa sbizzarrirsi a svelare.
Una girandola di riferimenti volutamente volta a non dividere bello da brutto,
arte da spazzatura, che trova la sua sublimazione anche nell’appendice al
disco, che stavolta non esce come compendio, ma sottoforma di vero e proprio
album a sè stante con il titolo di The Stand-ins (ma con disegno di copertina
che completa quella di The Stage Names,
a testimonianza della stretta parentela), con altre riflessioni sulla vita da
artista e rock-band (Singer Songwriter,
On Tour With Zykos e una Lost
Coastlines che chiama a duettare l’amico - e ormai sempre più dedicato al
progetto Shearwater - Jonathan Meiburg su un testo che parla proprio delle
difficoltà di rimanere nella stessa band con i tanti impegni diversi presi),
finali di storie precedentemente iniziate (Starry
Stairs racconta del suicidio della stessa Savannah di Savannah Smiles) e storie di rockstar mancate e dimenticate (Bruce Wayne Campbell Interviewed on the Roof
of the Chelsea Hotel, 1979, sullo sfortunato glam-rocker Jobriath). La
critica sui due dischi comincia a dividersi, ma vendite e popolarità
garantiscono finalmente a Sheff e soci un futuro più sicuro.
“Ancora uno!”
Le storie di Simeonov e Sheff hanno un finale diverso: il
primo alla fine smette di vivere di sogni esattamente come il secondo, il quale
ha avuto però migliore fortuna, ha trovato la sua Vera nella figura di Rory Erickson, anche lui rockstar decaduta,
ma con ancora dentro tanta musica da comunicare e quella grandiosità artistica
che Simeonov sperava di trovare nella sua diva. Erickson invece, grazie a Sheff
e agli Okkervil River, pubblica il disco migliore della sua carriera (True Love Cast Out All Evil) e dimostra
che forse è proprio la lucida follia del vecchio leader dei 13th Floor
Elevators l’unico vero tratto distintivo dell’artista in grado di preservarlo
dalle miserie quotidiane tipiche dell’uomo comune. Per Sheff è dunque stato
tempo di una lunga pausa, per ripartire con una nuova maturità, una verginità
persa, e un disco adulto e concreto come I Am Very Far, che è l’inizio di una
storia nuova e completamente diversa da quella nata in quel college dello New
Hampshire. Una storia in cui i sogni infranti di Simeonov non sono più
previsti.
Nicola Gervasini
I brani in corsivo sono tratti dal racconto
“Okkervil River” di Tatyana Tolstaya, dal libro “White Walls”, Ed. Nyrb (mai
tradotto in Italia).


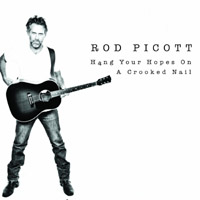









 I dodici brani confezionati per Lost Souls funzionavano alla grande, unendo appeal melodico (
I dodici brani confezionati per Lost Souls funzionavano alla grande, unendo appeal melodico (

