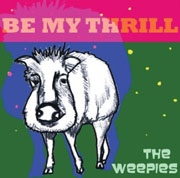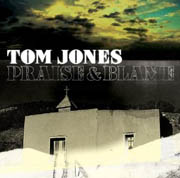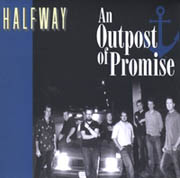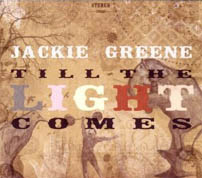Ci sono copertine che gridano "stammi lontano! Non comprarmi! Sono robaccia da scartare dopo due note!", e The Quickening di David Leonard nel genere è davvero da competizione, con buone probabilità di vittoria come cover più pacchiana dell'anno. Come se non bastasse, sul retro si legge che il buon Leonard ha fatto tutto da solo (coadiuvato dal batterista Steve Holley), ma in studio ospita una bella accolita di attempati sopravvissuti del rock anni '70, la classica compagnia che si ritrova dopo anni per fare uno un cd che definire "nostalgico" è l'eufemismo giusto per non dover sparare un "vecchio" che non lascia scampo. Ma prima serve fare un passo indietro, perché vi starete ancora chiedendo "Sì, va bene, ma chi diavolo è David Leonard"? E' una vecchia anticaglia del mondo del rock pure lui, con anni da turnista delle sei corde alle spalle dell'ex Television Richard Lloyd, e poi lavori in back-office per Chuck Berry, Cindy Lauper, e una nutrita e musicalmente variopinta schiera di artisti, come da copione di un tipico session man.
E che fa un uomo del genere, con alle spalle un solo album solista del lontano 1984, e nulla da perdere? Semplice: scrive tranquillamente canzoni, le registra tra Brighton e New York in studi di registrazione da sogno, e si porta appresso i figli piccoli (è una vocina infantile infatti che batte il tempo iniziale di Turn The World). E incontra vecchie conoscenze dicevamo: in tre brani suona alla grande il chitarrista Rick Derringer, sei corde dei McCoys negli anni 60 (la ricordate Hang On Sloopy?), sparring partner dei fratelli Johnny e Edgar Winter negli anni 70 (con anche qualche breve successo personale, ricordate Rock 'n Roll Hoochie Koo?), e infine negli 80 scopritore e produttore del talento comico di Weird Al Yankovic. Altrove appaiono invece le percussioni di Mick Fleetwood, padre-padrone dei Fleetwood Mac e la chitarra di Chris Spedding (anche lui ha suonato con il meglio degli anni 70, da Elton John ai Roxy Music). A valle di tutto c'è però una sorpresa: The Quickering, lungi dall'essere un disco che cambia qualcosa nelle nostre vite, è un prodotto comunque piacevole, che scava a piene mani nel garage-rock degli anni 60, mischiando lunghe schitarrate bluesy (Turn The World e She's A Woman) a qualche buona prova d'autore (Garden Of Regrets).
Le due cover presenti d'altronde sono lì a chiarire gli intenti, visto che si parte da I Had To Tell You dei 13th Floor Elevators, per poi approdare ad una dylaniana My Back Pages, un brano che Bob scrisse guardando al passato dopo solo 4 anni di carriera, mentre questi onesti vecchierelli possono permettersi di cantarlo al massimo dopo 40, ma ad ognuno il suo giusto tempo. Nostalgico e retrogrado, questo è The Quickering, un disco che ti lascia con l'idea che un giorno, quando questo rock sarà morto veramente, forse avremo nostalgia noi stessi anche di questi bei sottoprodotti generazionali.
(Nicola Gervasini)