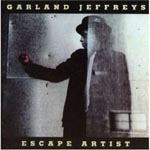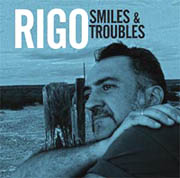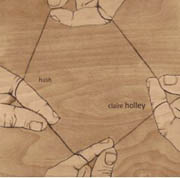1980
1980Bob Seger & The Silver Bullett Band
Against the Wind
[Capitol]
L'epica della working class di Detroit era stata dalla parte giusta della corrente proprio grazie a lui per tutta la seconda metà degli anni 70, ma negli anni 80 il vento sarebbe cambiato, e anche per Bob Seger sarebbero finiti gli anni ruggenti. Lui però nel decennio ci era entrato con tutto l'ingenuo romanticismo di questo disco, che fu anche il suo ultimo a non essere controvento e a vendere cifre da capogiro. Equamente diviso tra il suo caro "old time rock and roll" e le ariose ballate acustiche che gli diedero fama e soldi, Against The Wind fu l'epitaffio di una generazione che stava per abbandonare la scena al grido disperato di "Let The Cowboys Ride!". Purtroppo l'unico cowboy che cavalcò negli anni 80 stava alla Casa Bianca ad uccidere i sogni di tutti i bei perdenti segeriani. (NG)
Take #2, prova anche: The Distance (Capitol 1982)
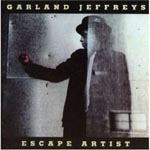 1981Garland Jeffreys
1981Garland Jeffreys
Escape Artist[Epic]
Nel 1981 la musica era ormai preda dell'isteria futurista dell'elettronica, ma a far capire che nel sottobosco si stava organizzando una resistenza a base di sixties-sound fu l'entrata nelle charts di una cover di 96 Tears, un brano del 1966 dei dimenticati ? & The Mysterians. A proporla, in una travolgente versione caratterizzata da un organo pulsante, era Garland Jeffreys. Prodotto da un gigante del rock mainstream come Bob Clearmountain e particolarmente influenzato dal pub-rock inglese di Elvis Costello, Escape Artist faceva scorrere nei suoi solchi tutti gli umori delle strade di New York dei primi anni 80: rock, pop, reggae/ska, black music, roots-rock, persino strizzatine d'occhio alla dance. Di "crossover" se ne sarebbe parlato qualche anno dopo, ma Jeffreys ci stava già lavorando da tempo. (NG)
 1981
1981
Mink DeVille
Coup de Grace [Atlantic]
Partito dal rock urbano di New York e approdato alle ballate soul di Doc Pomus, Willy DeVille decise per il suo quarto album di dare un restyling al proprio gruppo travestendolo da E-Street Band, confezionando così il suo disco più muscoloso e tipicamente americano. Con il sax di Louis Cortelezzi impegnato ad essere il nuovo Clarence Clemmons e il piano di Kenny Margolis a lezione dal professor Roy Bittan, l'intruglio dei Mink DeVille a base di roots-rock, musica ispanica e soul perse molte delle asprezze degli esordi ma guadagnò in calore e pathos. You Better Move On di Arthur Alexander l'aveva cantata anche Mick Jagger quasi vent'anni prima, ma la versione vincente di Willy dimostrò che nessuno al mondo poteva cantare serenate con lo stesso credibile mix di machismo e romanticismo. (NG)
Take #2, prova anche: Miracle (A&M 1987)
 1983Rain Parade
1983Rain Parade
Emergency Third Rail PowerTrip [Enigma]
Se c'è un disco che fu tra i primi a "mostrare la via" a tutto il movimento del Paisley Underground questo fu proprio Emergency Third Rail Power Trip dei Rain Parade. Il singolo What She Done To Your Mind devastò le radio universitarie americane come solo Radio Free Europe dei R.E.M. riuscì a fare in quel lontano 1983, con il suo mix di chitarre in stile Byrds unito ad un gusto psycho-pop che guardacaso non era poi tanto lontano da quello che proponevano i ragazzi di Athens con il loro Murmur. Meno ruvidi e forse meno attenti al songwriting dei Dream Syndicate, i Rain Parade erano molto più interessati all'ipnotico impatto sonoro, lo stesso stile onirico che il leader Dave Roback porterà in eredità e svilupperà più estremamente negli Opal e nei Mazzy Star. (NG)
 1984Dream Syndicate
1984Dream Syndicate
Medicine Show [A&M]
L'ondata di band californiane che finirono sotto l'etichetta del Paisley Underground (dal nome di un tipico modo di vestire dell'era hippie) trovò nei Dream Syndicate la massima realizzazione di quello che era il nuovo credo musicale. Le chitarre sporche alla Lou Reed, gli assoli acidi imparati sulle partiture di John Cipollina dei Quicksilver Messenger Service, la rabbia del punk dilatata con l'abbandono dell'era delle two-minute-songs per il ritorno ai lunghi minutaggi di John Coltrane Stereo Blues, i tempi isterici e nervosi di una sezione ritmica che respirava la New Wave dei Television e dei Talking Heads. Il primo album della band fu il manifesto di tutto questo, ma con Medicine Show, il secondo disco, la teoria si fece capolavoro grazie alla scoperta di un autore, Steve Wynn, che resta ancora oggi una delle migliori eredità degli anni 80. (NG)
Take #2, prova anche: Ghost Stories (A&M 1988)
 1985
1985
Hoodoo Gurus
Mars Need Guitars [Big Time]
California chiama, Australia risponde: l'arruolamento in difesa del rock duro e puro attivato dal Paisley Underground raccolse la piena adesione degli Hoodoo Gurus di Dave Faulkner. Il titolo di questo secondo album era un grido di battaglia: il mondo aveva bisogno di chitarre, anche se grezze e mal rifinite. Ma la loro grandezza fu quella di capire che l'estetismo fine a sé stesso che imperava nel loro tempo poteva tranquillamente essere riciclato con puro spirito punk operando sulle melodie, generando così una sorta di matrimonio ideale, tutto australiano, tra l'anima estremamente pop dei Bee Gees e quella estremamente rock degli Ac/Dc. Oggi questo mix di punk e pop lo chiameremmo power-pop, ma loro ci aggiunsero pure venature evidenti di roots-rock e un songwriting ironico e geniale. (NG)
Take #2, prova anche: Blow your Cool (Elektra 1987)
 1985
1985
Jeffrey Lee Pierce
Wildweed [Statik]
Quello che mancò a Jeffrey Lee Pierce per diventare un'icona giovanile alla Jim Morrison o alla Kurt Cobain fu la "fortuna" di morire all'indomani di questo suo primo disco solista. Quando quella morte che aveva così ossessivamente intriso tutta la sua poetica lo raggiunse veramente nel 1996, il suo nome era già finito nel cimitero dei dinosauri degli anni 80 o negli elenchi degli artisti di culto delle riviste specializzate. Forse anche la sua visione di un'America distorta e corrotta e le sue apocalittiche previsioni del futuro avrebbero potuto impressionare le più fervide menti adolescenziali, ma la musica che pulsava in Wildweed era un roots-rock maturo, reso nevrotico da batterie pulsanti e decisamente new-wave e con parti vocali vicine al David Byrne più allucinato; tutto molto elettrizzante, quanto troppo poco definibile per generare inni generazionali di massa. (NG)
 1985John Fogerty
1985John Fogerty
Centerfield [Warner]
Probabilmente le beghe contrattuali che lo hanno tenuto per dieci anni lontano dal mondo discografico gli evitarono la pena di dover fare dischi brutti e poco ispirati per stare al passo dell'era della disco-dance e dell'elettronica. Sicuramente Centerfield vinse la scommessa di riportare in cima alle classifiche il nome dimenticato di John Fogerty, salvando capra e cavoli con un lato in puro "creedence-style" e un lato con drum-machines e l'evidente presa per i fondelli finale di Vanz Kant Danz. L'America reaganiana si appropriò indebitamente dell'epica puramente yankee della title-track, esattamente come fece con Born in The Usa di Springsteen, ma a noi venne restituito un uomo in grado di scrivere ancora una The Old Man Down The Road con la stessa semplicità di un tempo. (NG)
 1985
1985
Lone Justice
Lone Justice[Geffen]
Bionda, carina e con una bella e squillante voce country: Maria McKee sembrava dovesse spaccare il mondo, ma oggi sappiamo come è andata a finire. Al suo esordio con i Lone Justice sembrò di sentire la versione femminile dei Tom Petty & The Heartbreakers, ma senza ancora gli annacquamenti mainstream già accusati dalle loro produzioni di quel periodo. Il buon Petty contribuì con un brano strepitoso come Ways To Be Wicked, Benmont Tench e Little Steven insegnarono alla band a suonare in studio, Jimmy Iovine produsse il tutto con la proverbiale potenza del suo suono, la mega-star del momento Annie Lennox benedì con la sua voce il fortunato singolo Sweet, Sweet Baby (I'm Falling). Loro ci misero canzoni all'altezza e la grinta e l'urgenza dei vent'anni, tutta merce di lusso che già scomparve nel disastroso album successivo. (NG)
 1985
1985
The Long Ryders
State of Our Union [Island]
Mentre le band californiane si scambiavano i vinili dei gruppi garage degli anni 60, i Long Ryders di Sid Griffin si accontentavano dei dischi dei Byrds. Ma non si limitarono ad omaggiarli inserendo la Y nel loro nome o edulcorando il jingle-jangle sound della chitarra di McGuinn, ma anche ricordando a tutti che era esistito Sweetheart Of The Rodeo, Gram Parsons e il country-rock. Senza saperlo crearono il roots-rock moderno come lo conosciamo e definiamo oggi, anticipando di un paio d'anni la decisiva svolta in questa direzione dei Green On Red. The State Of Our Union fu l'album della maturità e la loro eredità più importante, paradossalmente più apprezzato in Inghilterra che da un America poco vogliosa di riscoprirsi, e che decretò con la sua disattenzione il prematuro declino della band. (NG)
Take #2, prova anche: Native Sons (Zippo 1984)
 1986
1986
R.E.M.
Life's Rich Pageant [IRS]
Per trovare un' identità definitiva, i R.E.M. passarono nel giro di un anno da un album prodotto da Joe Boyd, padre di tutto il brit-folk storico, a questo Lifes Rich Pageant, che fu messo nelle mani di Don Gehman, produttore di John Cougar e uomo dai gusti più rudi e puramente americani. Peter Buck per le parti di chitarra studiò tutta la sua collezione di vinili di garage-rock degli anni 60, confessò un' insospettabile passione per l'hard rock degli anni 70 e fece tesoro di tutta la violenza del punk californiano dei primi anni 80. Un supporto ideale per le virulente invettive politiche di un grintosissimo e rauco Michael Stipe, ma anche l'occasione giusta per definire il lato più duro ed elettrico di una band che saprà maturare ancora, ma non ripeterà mai più un simile perfetto mix di rabbia e gusto melodico. (NG)
Take #2, prova anche: Murmur (IRS 1983)

1987
John Mellencamp
The Lonesome Jubilee [Mercury]
Nonostante il suo blue-collar rock suonasse sempre più adulto e meno radio-friendly disco dopo disco, John Cougar non era ancora riuscito ad evitare di finire, per l'immaginario comune, nella schiera dei "nuovi Bruce Springsteen". Ma quello che fece sentire con The Lonesome Jubilee era indefinibile e lo emancipò definitivamente: non era rock, non era country e non era neanche folk, e oltretutto riusciva a sembrare moderno nonostante lo schieramento di violini, fisarmoniche e mandolini. Il fatto è che non era nemmeno più John Cougar, era John Mellencamp, un ex bulletto del rock che urlando il proprio sdegno per la "reaganomic" aveva ritrovato il suo vero nome e soprattutto un sound, il suo, un'assoluta novità nel 1987, una regola consolidata per tutto il rock americano oggi. (NG)
Take #2, prova anche: Big Daddy (Mercury 1989)
 1987Robbie Robertson
1987Robbie Robertson
Robbie Robertson [Geffen]
Nessuno ci aveva creduto al ritiro dalle scene annunciato da Robbie Robertson dopo l'ultimo valzer con la Band. La molla che lo rimise in pista fu la morte dell'amico Richard Manuel, ma l'uomo che lo convinse fu l'emergente Daniel Lanois, che gli portò in studio i protagonisti degli altri capolavori che stava producendo in quell'anno. Gli U2 di Joshua Tree, il Peter Gabriel di So, più le voci dei Bodeans e della fidanzata Maria McKee, i fiati di Gil Evans e i vecchi compari Rick Danko e Garth Hudson, tutti assieme per creare una delle migliori realizzazioni del Lanois-pensiero. In questo Robbie contribuì con una voce profonda e convinta, un tocco di chitarra mai così rude e nove canzoni perfette che parlavano dell'America magica e selvaggia dei pellerosse e di quella cinica ed erosiva degli yankee non dando mai l'impressione di parlar di politica. (NG)
 1987
1987
Ry Cooder
Get Rhythm [Warner]
A furia di scavare nel fangoso sottobosco della tradizione, la musica di Ry Cooder stava mostrando un po' la corda. Ry decise così di dedicare anima e corpo solo al più remunerativo lavoro di produttore e soundtrack-maker, non prima però di pubblicare questa definitiva summa di tutto quello che aveva scoperto in vent'anni di onorata carriera. In Get Rhythm c'era Elvis Presley, c'era Johnny Cash, c'era Chuck Berry, c'era la frontiera raccontata attraverso l'immortale Across The Borderline dell'amico John Hiatt, c'era la musica di New Orleans e c'era il blues del Reverendo Davis. C'era il suo suono più aspro ed elettrico, quello che presterà a tanti altri artisti, quello che meglio sfruttava la sua voce spigolosa e sgraziata. E c'era tutta l'America che suona da sempre nei nostri stereo. (NG)
Take #2, prova anche: The Slide Area (Reprise 1982)
 1987Suzanne Vega
1987Suzanne Vega
Solitude Standing [A&M]
Non fu solo l'aver azzeccato uno di quei singoli che conoscono anche i muri come Luka, non fu solo l'aver aperto la porta al mondo discografico ad una schiera di nuove giovani cantautrici, non fu nemmeno il fatto che una esile e timida ragazza senza gli attributi tipici della vamp anni 80 divenne improvvisamente una star. Fu soprattutto che grazie a Solitude Standing ancora oggi intere generazioni di ragazze in tutto il mondo trovano la forza e la convinzione di imbracciare una chitarra e scrivere canzoni. Poco importa che non sarà nemmeno il disco migliore di Suzanne Vega e che la produzione di Lenny Kaye (chitarrista del Patti Smith Group) fosse anche parecchio furbetta. Contò il miracolo di aver riportato in cima alle charts la leggerezza e la semplicità di una folk-song, e non fu davvero poca cosa. (NG)
Take #2, prova anche: Suzanne Vega (A&M 1985)
 1987Thin White Rope
1987Thin White Rope
Moonhead[Frontier]
Non ci basta lo spazio per elencare i motivi validi per ritenere i Thin White Rope una band fondamentale e ancora oggi incredibilmente influente. Il californiano Guy Kyser li fondò quasi per scherzo, scegliendo come nome l'espressione usata da William Borroughs per descrivere l'eiaculazione e riunendo altri pazzi che come lui mal digerivano la musica solare della loro terra, prediligendo le chitarre garage-rock degli anni 60, la psichedelia di San Francisco mischiata con echi del primo hard-rock più gotico, lo spleen dei Dark e della New Wave degli 80 e persino la granitica freddezza del kraut-rock tedesco dei 70. Un impasto di roots-rock acido e "desertico" che raggiunse con Moonhead, un'altra pietra miliare del Paisley Underground, la massima perfezione stilistica, una qualità che resterà comunque pressochè intatta fino all'abbandono delle scene del 1992. (NG)
Take #2, prova anche: In the Spanish Cave (Frontier 1988)
 1987Warren Zevon
1987Warren Zevon
Sentimental Hygene[Virgin]
Vengono in mente pochi altri artisti oltre Warren Zevon in grado di smuovere nomi così altisonanti in proprio soccorso. La pletora di ospiti presenti nell'estremo saluto di The Wind aveva infatti già un precedente in Sentimental Hygiene, dove Neil Young, Bob Dylan, i R.E.M., Don Henley, Brian Setzer, Flea, George Clinton (per non citare i tanti chitarristi illustri presenti) festeggiavano il ritorno di questo sfortunato eroe dalla "Detox Mansion" dove si era ripulito dall'alcool. Il merito di Zevon fu quello di non sprecare tanta grazia coinvolgendo tutti in un disco che rilanciava a gran voce la forza dei songwriters di stampo classico, con il produttore Niko Bolas bravo a cucire addosso a dieci ottime canzoni un sound aspro e radiofonico al tempo stesso. Purtroppo ad accorgersi del gran risultato continuarono ad essere solo gli addetti ai lavori. (NG)
Take #2, prova anche: The Envoy (Asylum 1982)