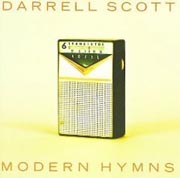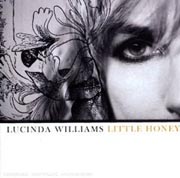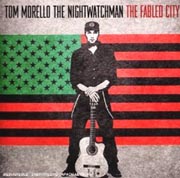14/11/2008
Rootshighway
VOTO: 7
Gli studi Zuma di Lubjana in Slovenia sono diventati da alcuni anni un vero e proprio laboratorio di idee per
Chris Eckman. Il leader dei Walkabouts ha spostato qui il centro dei suoi interessi, e da qualche tempo sta sperimentando una via tutta europea per pensare musica. Da questa factory artistica sono già uscite molte sue produzioni (quest'anno lui stesso aveva licenziato Dirtmusic, un disco co-firmato con Hugo Race e Chris Brokaw), ma anche il recente disco di
Steve Wynn (
Crossing Dragon Bridge) o quello di
Terry Lee Hale dello scorso anno (Shotgun Pillowcase), tutti album caratterizzati da un sound molto levigato e lontano dalla polvere del rock stradaiolo d'oltreoceano. Naturale dunque che Eckman abbia sentito il bisogno di dedicare alla Slovenia questo nuovo
The Last Side Of The Mountain, un progetto che nasce dalla sua scoperta dell'opera di
Dane Zajc, un poeta neo-espressionista sloveno poco conosciuto in Italia, ma di grande fama internazionale grazie ad una raccolta di poesie intitolata Scorpions. E proprio da questo libro Eckman ha estrapolato dieci poemi nella loro versione in inglese (curata dallo stesso Zajc), e li ha musicati ottenendo un risultato davvero affascinante. La formula utilizzata è presto detta: una sezione d'archi imponente (registrata a Praga) dona un tocco sinistro alle sue tipiche dark-songs elettro-acustiche, mentre, rispetto ad altri dischi cotti nel forno sloveno, viene ben accolto l'utilizzo parco e morigerato di tastiere e interventi elettronici. Down Down, la soave Eyes o la soffocante Ransom sono un inizio folgorante, con la voce di Chris ormai arrivata ai livelli sotterranei di un Mark Lanegan e gli splendidi (e alquanto pessimistici) versi di Zajc. Particolarmente suggestiva riesce Who Will Light Your Path?, splendido duetto con la vocalist polacca Anita Lipnicka, che ricorda tanto le murder ballads con Kyle Minogue e Pj Harvey di Nick Cave, e piace molto anche la cavalcata da country fuorilegge di Stranger, con la sua armonica penetrante. Fino a questo punto il cd riesce a tenere un ottimo livello di tensione, ma dalla trasposizione di Scorpions (da brividi il poema) in poi cominciano a prendere il sopravvento gli archi e certi barocchismi colpevoli di appiattire il sound. La sofferta Hourse viene lasciata a crogiolarsi fin troppo in un arpeggio secco e monotono, cosa che succede anche in With What Mouth, dove forse Eckman confida un po' troppo nell'effetto evocativo della sua voce. Dopo l'incalzante The Same, si chiude il tutto con uno strumentale orchestrale (The Last Side Of The Mountain) e con un recital in sloveno dello stesso Dane Zajc. Peccato dunque che dopo una prima parte a dir poco esaltante, il finale del disco si adatti troppo alle esigenze strutturali del progetto, perdendo leggermente in intensità, ma questo non toglie che The Last Side Of The Mountain sia forse il risultato più maturo e compiuto della sua ricerca mitteleuropea. (Nicola Gervasini)
VERSIONE LUNGA
Buscadero
Dicembre 2008
Gli studi Zuma di Lubjana in Slovenia sono diventati da alcuni anni un vero e proprio laboratorio di idee per Chris Eckman. Il leader dei Walkabouts (che, per la cronaca, esistono ancora, e usciranno con un disco nuovo nel 2009) ha spostato qui il centro dei suoi interessi, e da qualche tempo sta sperimentando una via tutta europea per produrre dischi. Da questa factory artistica, creata con un gruppo di validi musicisti sloveni, sono già uscite molte sue produzioni (quest’anno lui stesso aveva già licenziato Dirtmusic, un disco co-firmato con Hugo Race e Chris Brokaw), ma anche il recente disco di Steve Wynn (Crossing Dragon Bridge) o quello di Terry Lee Hale dello scorso anno (Shotgun Pillowcase), tutte caratterizzate da un sound molto levigato e lontano dalla polvere del rock stradaiolo d’oltreoceano. Ovvio che, dopo aver succhiato linfa creativa ad una terra ed un popolo che da qualche anno sta trovando la forza di essere protagonista nel mondo dell’arte (particolare rilievo sta assumendo il teatro sloveno), Eckman abbia sentito il bisogno di dedicare alla Slovenia un suo progetto. The Last Side Of The Mountain nasce dalla sua scoperta dell’opera di Dane Zajc, un poeta neo-espressionista sloveno poco conosciuto in Italia, ma di grande fama internazionale grazie ad una raccolta di poesie intitolata Scorpions. E proprio da questo libro Eckman ha estrapolato dieci poemi nella loro versione in inglese (curata dallo stesso Zajc) e li ha musicati ottenendo un risultato davvero affascinante. La formula utilizzata è presto detta: una sezione d’archi imponente (registrata a Praga) dona un tocco sinistro alle sue tipiche dark-songs elettro-acustiche, mentre, rispetto ad altri dischi cotti nel forno sloveno, viene ben accolto l’utilizzo parco e morigerato di tastiere e interventi elettronici. Down Down, la soave Eyes o la soffocante Ransom sono un inizio folgorante, con la voce di Chris ormai arrivata ai livelli sotterranei di un Mark Lanegan e gli splendidi (e alquanto pessimistici) versi di Zajc. Particolarmente suggestiva riesce Who Will Light Your Path?, splendido duetto con la vocalist polacca Anita Lipnicka, che ricorda tanto le murder ballads con Kyle Minogue e Pj Harvey di Nick Cave, e piace molto anche la cavalcata da country fuorilegge di Stranger, con la sua armonica penetrante e un ritmo insolitamente accelerato. Fino a questo punto il cd riesce a tenere un livello di tensione sensazionale, ma dalla trasposizione di Scorpions (da brividi il poema) in poi cominciano a prendere il sopravvento gli archi e certi barocchismi che hanno pesato anche sul disco di Steve Wynn, colpevoli di appiattire il sound, invece di esaltare la lugubre intensità del binomio chitarra-voce di Eckman. La sofferta Hourse viene lasciata a crogiolarsi fin troppo in un arpeggio secco e monotono, cosa che succede anche in With What Mouth, dove forse Eckman confida un po’ troppo nell’effetto evocativo della sua voce. Dopo l’incalzante The Same, si chiude il tutto con uno strumentale orchestrale (The Last Side Of The Mountain) e con un recital in sloveno dello stesso Dane Zajc. Peccato dunque che dopo una prima parte a dir poco esaltante, il finale del disco si adatti troppo alle esigenze strutturali del progetto, perdendo leggermente in intensità, ma questo non toglie che The Last Side Of The Mountain sia forse il risultato più maturo e compiuto della sua ricerca mitteleuropea, la giusta chiusura di un cerchio artistico che sarebbe rimasto altrimenti alquanto irrisolto. E non è difficile ipotizzare che anche il prossimo capitolo dei Walkabouts possa partire proprio da qui. (Nicola Gervasini)
 17/11/2008
17/11/2008