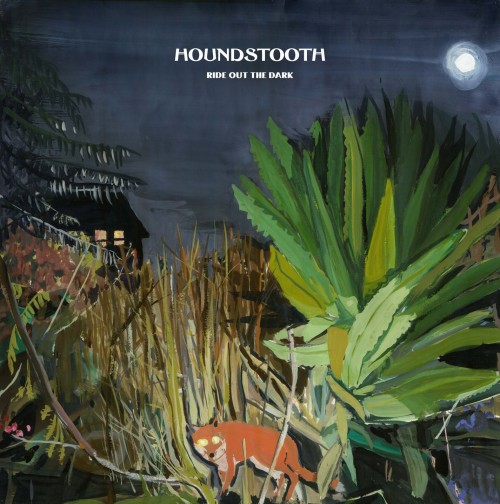| Roy Harper Man & Myth [Bella Union 2013] www.royharper.co.uk di Nicola Gervasini (02/12/2013) |  | ||
Quest'anno Fanfare di Jonathan Wilson finirà in molte classifiche di fine anno, come anche nella nostra d'altronde. Questo nonostante abbia scatenato discussioni ovunque (anche nella nostra redazione) sul suo reale spessore, se lui ci sia o ci faccia solamente, o se il suo perfezionismo nel ricreare suoni e atmosfere degli anni settanta sia solo perizia da musicista o arte con perizia. Ai posteri l'ardua sentenza diceva un tale oggi poco di moda, quello che è importante è che il produttore Jonathan Wilson ha una abilità che, messa al servizio di artisti con più spessore compositivo, non può che portare risultati straordinari. Fino ad oggi Wilson aveva messo il suo know-how tecnico a disposizione di nomi giovani del nuovo indie americano (Dawes, Father John Misty, Mia Doi Todd tra gli altri), ma con la firma su questo grande ritorno di un vecchio leone del folk allucinato del Regno Unito come Roy Harper, Jonathan firma probabilmente la sua migliore produzione.
Harper non pubblicava da tredici anni, da quell'ostico quanto affascinante The Green Man del 2000, che fu però ignorato dai più. E' sempre stato un problema esportare la musica di Roy Harper al di fuori dell'Inghilterra, e se non ci erano riusciti i Led Zeppelin e i Pink Floyd, che gli fecero non poca pubblicità in best seller come III e Wish You Were Here, pare difficile che ci possa riuscire il giovane Wilson, per quanto colto nel suo momento forse di maggiore notorietà. In ogni caso la perfezione raggiunta da Man And Myth sta tutta nell'equilibrio con cui Wilson è intervenuto nelle lisergiche folk-song del vecchio Roy, colto in stato di grazia compositiva straordinaria, lasciando che sia solo la sua voce e la sua chitarra a parlare quando davvero non c'è nulla da aggiungere (Time Is Temporary, January Man,The Stranger), ma intervenendo pesantemente laddove invece ha ravvisato la possibilità di rendere lo stile aspro e spigoloso di Roy decisamente più levigato e melodico.
In questa direzione vanno brani come The Enemy, la splendida Cloud Cuckooland (dove Pete Townshend veste i panni di disturbatore elettrico solitamente vestiti da Jimmy Page), e il gran finale di The Exile. In mezzo i quindici minuti e passa di Heaven Is here, uno di quei tour de force a cui Roy ci ha da sempre abituati (d'altronde Stormcock, il suo capolavoro, conta solo quattro brani di simile lunghezza), in cui Jonathan Wilson si diletta a giocare con ardite orchestrazioni e cambi di registro. L'operazione ricorda molto l'incontro tra gli Okkervil River e Rory Erickson (nell'labum True Love Cast Out All Evil nel 2010), ma Man & Myth resta un disco di Roy Harper al 100%, e pure uno dei migliori della sua già lunga e gloriosa discografia.
Harper non pubblicava da tredici anni, da quell'ostico quanto affascinante The Green Man del 2000, che fu però ignorato dai più. E' sempre stato un problema esportare la musica di Roy Harper al di fuori dell'Inghilterra, e se non ci erano riusciti i Led Zeppelin e i Pink Floyd, che gli fecero non poca pubblicità in best seller come III e Wish You Were Here, pare difficile che ci possa riuscire il giovane Wilson, per quanto colto nel suo momento forse di maggiore notorietà. In ogni caso la perfezione raggiunta da Man And Myth sta tutta nell'equilibrio con cui Wilson è intervenuto nelle lisergiche folk-song del vecchio Roy, colto in stato di grazia compositiva straordinaria, lasciando che sia solo la sua voce e la sua chitarra a parlare quando davvero non c'è nulla da aggiungere (Time Is Temporary, January Man,The Stranger), ma intervenendo pesantemente laddove invece ha ravvisato la possibilità di rendere lo stile aspro e spigoloso di Roy decisamente più levigato e melodico.
In questa direzione vanno brani come The Enemy, la splendida Cloud Cuckooland (dove Pete Townshend veste i panni di disturbatore elettrico solitamente vestiti da Jimmy Page), e il gran finale di The Exile. In mezzo i quindici minuti e passa di Heaven Is here, uno di quei tour de force a cui Roy ci ha da sempre abituati (d'altronde Stormcock, il suo capolavoro, conta solo quattro brani di simile lunghezza), in cui Jonathan Wilson si diletta a giocare con ardite orchestrazioni e cambi di registro. L'operazione ricorda molto l'incontro tra gli Okkervil River e Rory Erickson (nell'labum True Love Cast Out All Evil nel 2010), ma Man & Myth resta un disco di Roy Harper al 100%, e pure uno dei migliori della sua già lunga e gloriosa discografia.