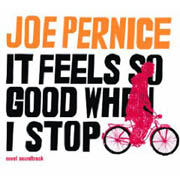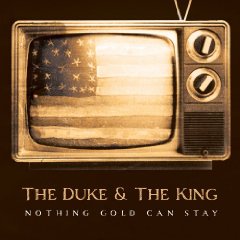Dicembre 2009
Rootshighway
Da dove preferireste che si cominciasse? Da un'introduzione su Greenpeace e sui suoi nobili obiettivi? Dalle considerazioni su questa uscita (in ritardo di quasi quarant'anni) e sui tanti benefit-concert sparsi negli anni che mancano ancora all'appello discografico? Oppure che vi parlassimo dei tre protagonisti di questa serata? Decidiamo noi: partiamo da Phil Ochs, ma come pretesto per parlare di tutto. Che vuol dire partire da uno sconfitto che vuole combattere ancora mille battaglie, da un ex folk singer del Greenwich Village che nel 1970 si è giocato tutto il credito che il mondo era disposto a dargli (pochissimo a dir la verità…), e che a febbraio licenziò con l'improbabile Greatest Hits (il titolo più ironico della storia del rock) il suo ultimo album in studio. Persi i contratti e la voglia di scrivere nuove canzoni, Ochs sarebbe andato subito alla deriva (ci arrivò con più calma sei anni dopo) se non avesse incontrato Irving Stowe, colui che nel 1966, cercando di fermare i test nucleari statunitensi nell'isola Amchitka in Alaska, inventò quasi per caso l'organizzazione ecologista Greenpeace. Questo concerto interamente acustico, organizzato da Stowe nell'ottobre del 1970, è da sempre considerato il vero e proprio start-up dell'organizzazione a livello internazionale, e da qui in poi Ochs avrebbe dato vita e partecipato a concerti di beneficienza per tutti gli ultimi anni della sua vita, con tutta la sua tipica cieca caparbietà, ma anche una lucida abilità nel cogliere i temi di interesse futuro per cui combattere. Amchitka potrebbe dunque essere il primo dei tanti possibili omaggi che si dovrebbero fare a questo sfortunato e lungimirante artista, se solo si scavasse bene negli archivi e si cercassero i suoi concerti a favore di Salvador Allende, John Sinclair, George McGovern o la gran celebrazione della fine della guerra del Vietnam ("War Is Over" del 1975, con John Lennon tra i tanti illustri ospiti), da lui fortemente voluta, e incredibilmente mai pubblicata su disco. Anche perché il suo set qui presente rappresenta il meglio dell'Ochs più tagliente e incazzato, con convinte versioni di Rhythms of Revolution, Chords of Fame, l'immancabile I Ain't Maching Anymore e la torrenziale Joe Hill. Una testimonianza ben lontana da quella che offrirà il suo ultimo live Gunfight at Carnegie Hall (pubblicato nel 1975, ma registrato sei mesi prima di questo concerto), dove scimmiottava Elvis Presley per affondare definitivamente la sua credibilità di giornalista-cantante. La parte di Ochs occupa metà del primo dei due cd, giusto il tempo di suonare otto brani prima di farsi sostituire da un James Taylor fresco di insperato successo e notorietà, come lui stesso ribadisce presentando Carolina In My Mind. La parte di Taylor, costituita da sette strafamose canzoni tratte dai suoi primi tre album (Fire And Rain è sempre un colpo al cuore in qualunque veste la si presenti) è interessante soprattutto perché non vi sono sue testimonianze live del periodo, anche se James non è uomo da grandi variazioni sul tema e si tiene ligio agli originali. L'intero secondo cd è invece dedicato alla giovane Joni Mitchell, vera mattatrice della serata. Cinquanta minuti frizzanti e convinti i suoi, che servirono anche a presentare al pubblico alcuni inediti che costituiranno l'ossatura del suo disco successivo (il capolavoro Blue), vale a dire My Old Man, A Case Of You (presentata con un titolo molto più lungo) e una versione da dieci minuti di Carey in medley con una Mr. Tambourine Man di Dylan cantata a due voci con James Taylor. La Mitchell appare in forma, e la giocosa versione di Big Yellow Taxi che si trasforma nel classico Boney Maroney (con la memorabile rima iniziale "I got a girl name of Boney Maroney, she's as skinny as a stick of macaroni"), così come i classici Woodstock e The Circle Game, sono più che vibranti. Una testimonianza importante che va a coprire il periodo più da folk singer pura della Mitchell, visto che di lì a quattro anni il live Miles Of Aisles racconterà già una Joni diversa. Considerazioni sociali a parte sull'argomento Greenpeace (per le quali rimandiamo al ben redatto booklet di 48 pagine, che racconta tutto il raccontabile sull'argomento), il gran valore musicale di Amchitka è quello di essere formato da tre live realmente inediti e storicamente necessari per capire i percorsi di tre grandi artisti della canzone americana. E vista la gran quantità di materiale pressoché inutile e ridondante, pubblicato dalle case discografiche in questi ultimi vent'anni di forsennato recupero di vecchi archivi, non è davvero poco. (Nicola Gervasini)