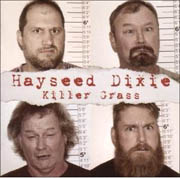L'intervista

Prima di tutto complimenti per la vostra musica. Non è facile trovare una categoria per descriverla, penso che l'insieme dei vostri stili ricordi soprattutto il circuito delle jam band degli anni '90, come Widespread Panic o Blues Traveler ad esempio. Vi sentite in qualche modo figli di quel movimento? Rich Wooten - Grazie! Sono d'accordo che sia difficile da categorizzare. Molte persone che apprezzano la nostra musica sono fan di band quali Widespread Panic e Blues Traveler. Nutro rispetto per queste band, hanno contribuito a riempire il vuoto lasciato nei '90 dai Grateful Dead. Ma personalmente in quegli anni io stavo seguendo la musica di Son Volt, Wilco, Matthew Sweet e Bob Dylan. Il nostro nuovo percorso in Shining Bright si è spostato dal sound delle jam band. Paul Tervydis - Per quel che mi riguarda sono stato molto influenzato da Bruce Hornsby, che è stato spesso inserito nel novero delle jam bands degli anni '90, o per lo meno in quel periodo. Essendo un fan della musica di Bruce, sono stato coinvolto da quella dei Grateful Dead e sono diventato un ammiratore tanto della loro musica quanto della loro filosofia dei live show. Sai, tutta quella filosofia di improvvisazione per cercare costantemente di entrare nella tua anima e inventare una qualche nuova via per suonare sul palco - cercando di intensificare l'espressione originale della canzone - tutto questo ha avuto una grossa influenza su di me. Penso tuttavia che una buona fetta del nostro songwriting abbia una forte connotazione dal punto di vista dei testi, mentre un sacco di jam band di oggi tendono a non considerare molto la sostanza delle liriche, sono più interessati all'aspetto dell'improvvisazione musicale Siete originari di St. Louis, che tipo di scena musicale si muove nella vostra città? Avete avuto qualche collaborazione con band o artisti di St. Louis? Pierce Crask - Si trova un po' di tutto da queste parti, blues, rock, jazz, country, hip hop. Non collaboriamo davvero con molte persone, ma Mike Martin (il proprietario e ingegnere del suono al Broom Factory Studio) è stato parte integrante della nostra cresicta. Rich Wooten - St. Louis non ha al momento una vera e propria scena, anche se ci sono alcune ottime band da queste parti. I Bottle Rockets ad esempio sono una fantastica band che arriva dall'area di St. Louis. Il nostro tecnico del suono Mike Martin ha lavorato con un sacco di grandi musicisti del posto, tra cui Jay Farrar, così esiste una sorta di legame indiretto attraverso la sua persona e siamo stati fortunati ad avere il supporto di Mike. Chuck Berry vive ancora a St. Louis e continua a suonare qui. È fantastico pensare di avere qualcuno qui in St. Louis che ha influenzato tutti i giganti del rock'n'roll, da Buddy Holly a Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan. Riuscite a suonare molto anche al di fuori del Missouri oppure è difficile per una band locale uscire dai propri confini? Rich Wooten - È complicato per noi muoverci, non avendo un manager o un'etichetta, ci piacerebbe averne l'opportunità. In Italia ci sono parecchie persone che apprezzano il vostro tipo di musica, ma è difficile riunirli in un unico posto per un concerto, per questo è sempre molto complicato per le band americane venire dalle nostre parti. Sapete che gente come Tom Petty, Bob Seger o John Mellencamp non sono mai venuti in tour in Italia per ragioni legate agli alti costi, e molti artisti arrivano da noi senza musicisti al seguito. Pensate che essere un'entità come una band sia un ostacolo per un grosso tour in Europa? Pierce Crask - Sono sicuro che per produzioni più grandi ci siano molti problemi di tipo logistico, ma noi siamo una questione molto più semplice e diretta. Credo che mettere insieme le date e i luoghi per i concerti sarebbe l'ostacolo più grosso, salire sul palco e suonare la nostra musica sarebbe facile. Rich Wooten - Se avessimo il successo commerciale di uno qualsiasi di questi artisti (Seger, Petty, Mellencamp) posso assicurarti che troveremmo un modo per girare in tour per l'Europa. Voglio che i Falling Martins suonino in Italia, è il mio obiettivo principale in questo momento con la band. Abbiamo suonato circa 800 show dalle nostre parti, è giunta l'ora di muoverci in qualche altro posto Abbiamo conosciuto i Falling Martins attraverso il passaparola sul web riguardo al disco Live At The Old Rock House, che abbiamo molto apprezzato. Vent'anni fa senza una grande etichetta che distribuisse la vostra musica probabilmente questo non sarebbe successo. Come vivete la vostra condizione di musicisti indipendenti? Cambiereste tutto ciò per un contratto con un'etichetta che vi fornisse più visibilità, ma minore libertà in studio?
Paul Tervydis - Il modo di essere musicista è cambiato tantissimo negli ultimi vent'anni, sia nel bene che nel male. Le tecniche di registrazione hanno portato praticamente possibilità illimitate e vantaggi per l'artista che vuole registrare le sue composizioni, e i computer e internet hanno fatto si che una band del Midwest facesse arrivare la sua musica in Italia. Può essere una bella cosa avere a disposizione la tecnologia per registrare e far conoscere la propria band, senza essere sotto il controllo di un'etichetta. Ma la tecnologia, anche se conveniente, offre tali e tante opportunità da confondere la concentrazione di un artista (i limiti a volte possono essere un fatto positivo!). Inoltre credo che i vecchi metodi di registrazione analogici infondessero delle qualità quasi "magiche" ai dischi, cosa che oggi non accade nel regno del digitale. La cosa positiva del vecchio modello di music business era che gli artisti potevano concentrarsi per gran parte del tempo sulla loro musica, mentre adesso devono bilanciare il loro tempo fra l'essere musicisti, produttori, tecnici e uomini d'affari. Visto il folle mondo in cui viviamo, penso che la nostra band stia facendo un buon lavoro nel bilanciare tutto questo al melgio delle nostre possibilità, ma è veramente difficile curarsi di tutto ciò e al tempo stesso mantenere la concentrazione sull'aspetto creativo, potrei andare avanti per ore su questi argomenti, ma come qualsiasi altro aspetto della vita tutto si riduce ad una lotta fra Convenienza contro Qualità, e su come sia difficile scegliere la qualità in un mondo che in larga parte sposa la convenienza Pierce Crask - Penso che stia diventando sempre più chiaro che gli artisti non hanno davvero bisogno delle etichette discografiche come una volta. Detto questo, non scambierei mai la libertà per i soldi, li prenderei entrambi, grazie. Rich Wooten - La risposta dall'Italia per quanto riguarda Live At The Old Rock House è stata sorprendente. Il ritorno positivo dall'Europa ha motivato ancoa di più i Falling Martins nel proseguire in quello che stavamo facendo. C'è un vero apprezzamento per questo tipo di musica in Italia e la cosa ci fa piacere Un lungo doppio album dopo soli tre dischi è qualcosa che si può aspettare da una jam band. Vi considerate una live-band o pensate che il lavoro di studio sia predominante nella vostra vita artistica?
Rich Wooten - Sono d'accordo, pubblicare un doppio album dal vivo è abbastanza raro per una band come la nostra. Ma la vita è corta. Le canzoni dei nostri primi tre dischi di studio sembravano evolversi e continuavamo a suonarle sul palco. È stato bello poterle registrare ancora. Il tempo speso in studio di registrazione è molto ristretto rispetto a quello che spendiamo suonando dal vivo. Mi piacciono entrambe le situazioni, ma suonare dal vivo è la nostra vera essenza. Paul Tervydis - Cerchiamo di sperimentare giusto un poco, ma non ci vedrai spendere delle ore in studio per trovare un suono di chitarre che non si è mai sentito prima. Prendiamo sul serio il lavoro in studio, ma spendiamo certamente molto più tempo sul palco Bill Mauldin's Star ha un sound molto diverso se paragonato al resto di Shining Bright, in altri tempi sarebbe stato un grande singolo, è molto radiofonico. Ma anche la sua storia è davvero speciale, è dedicata ad un cartoonist di St. Louis durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Cosa mi potete raccontare di questa canzone?
Rich Wooten - Si, Bill Mauldin's Star è una canzone diversa e potrebbe essere un brano popolare. Per quanto riguarda l'origine della canzone, c'è una strada in St. Louis chiamata Delmar Loop. I marciapiedi lungo la via hanno una 'Walk of Fame', con targhe a forma di stella simili a quelle di Hollywood Boulevard in California. A parte il fatto che queste targhe sono dedicate a grandi cittadini di St. Louis. Alcune di queste persone sono famose anche nel mondo come Chuck Berry, Miles Davis, T.S. Elliot, Maya Angelou. Altre non sono così famose. Ero seduto ad un cafè all'aperto in Delmar Loop durante una sera di luna piena e notai la targa di Bill Mauldin sul marciapiede. Non avevo mai sentito parlare di lui. Era una notte perfetta e pensai che Bill Mauldin's Star sarebbe stato un grande titolo per una canzone. Incominciai subito a scrivere le parole e uscirono di getto. Le liriche sono molto libere e di base forniscono un'istantanea del Loop in quella particolare serata. Andai a casa per scrivere la musica tutta la notte e buona parte del gorno dopo. Mesi dopo quando la registrammo, tutti nel gruppo compreso il nostro tecnico del suono, hanno aggiunto il loro contributo personale alla canzone, migliorandola. Al contrario Outside The Door ha un suono che potremmo sentire da una bar band di Austin, con un piano rock e ruvide chitarre. Pensate che la vostra musica possa essere definita come Americana, come gli Uncle Tupelo ad esempio
Rich Wooten - Si, la nostra musica può essere definita Americana e paragonare il nostro sound in Outside the Door ad una bar band di Austin è un gran complimento, grazie. Jay Farrar ha scritto Outside the Door e il brano contiene molti riferimenti musicali a St. Louis, alla storia musicale della città che comprende ragtime, jazz and blues. Gli Uncle Tupelo si sono formati a Belleville, illinois, che è una sorta di sobborgo di St. Louis aldilà del Mississippi. Il suono degli Uncle Tupelo è una grande influenza e i membri dei Tupelo furono influenzati da Doug Sahm, il grande musicista texano, registrarono con lui (sul disco Anodyne del 1994, ndr). Così è tutto collegato. Paul Tervydis - Tutta la nostra band è influenzata direttamente o indirettamente dalle forme tradizionali della musica americana: blues, jazz, folk e country. Per quel che mi riguarda comunque le mie principali ispirazioni sono più indirette e tendono ad arrivare da una specie di "onda" delle influenze precedenti. In altre parole i miei punti di riferimento (Bruce Hornsby, Keith Jarrett, Pat Metheny) sono stati essi stessi influenzati dalle forme della tradizione come blues, jazz e country ma le hanno mischiate con un suono più moderno che supera i singoli generi tradizionali. Alle mie orecchie la maggior parte delle band classificate come Americana oggi sono soprattutto influenzate dal country, dal folk e dal rock, che a sua volta è influenzato dal resto. Così non credo sia sbagliato definirci Americana, ma sento che c'è qualcosa di più nel nostro suono che non semplicemente il mix di generi citati in precedenza. Voi cinque arrivate tutti da diversi percorsi musicali, e questo significa diversi stili all'interno della vostra musica. Come nascono le vostre canzoni?
Rich Wooten - Le nostre canzoni evolvono, nel gruppo c'è un grande accordo. Pierce Crask scrive la maggior parte delle nostre canzoni e di solito lascia che ciascuno agguinga il suo contributo creativo. A volte le canzoni ci parlano e ci dicono di cosa hanno bisogno. Paul Tervydis - Quando Pierce e Rich scrivono una nuova canzone cerco di restare il più possibile fedele alla sua forma e struttura mentre nello stesso tempo cerco di trovare un modo per immettere un suono che mi colpisca ancora di più. Di solito apprezzo davvero le loro canzoni fin dall'inizio, così mi chiedo "cosa posso portare a questa canzone perché mi piaccia ancora di più?". Questo è quello che cerco sempre di fare, sia in studio sia dal vivo, anche se abbiamo già suonato quella particolare canzone cinquecento volte in passato. Ho speso molto del mio tempo studiando cose come teoria musicale, accordi, scale ecc., così solitamente riesco ad immaginarmi qualcosa di interessante da aggiungere. Cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi dischi dei Falling Martins? Pierce Crask - Una maggiore crescita artistica. Rich Wooten - Il nostro suono continuerà a maturare, il nostro songwriting si sta facendo più forte di giorno in giorno e il suono sta diventando sempre più esclusivo e personale. Aiutatemi a trovare cinque dischi di altri artisti che potrebbero descrivere la vostra musica alle persone che non hanno mai sentito prima il nome dei Falling Martins
Falling Martins - 1. Bob Dylan, Blood On The Tracks 2. Wilco, Being There 3. Steve Earle, Washington Square Serenade 4. Bruce Hornsby, Spirit Trail 5. John Prine, The Missing Years |