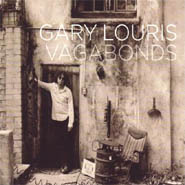TOP 10 2008
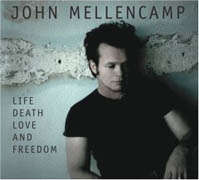 1
1
DISCHI CALDI 2008 (11-20)
11) BASEBALL PROJECT - VOLUME 1-FROZEN ROPES AND DYIN' QUAILS
12)HOLD STEADY - STAY POSITIVE
13) SILVER JEWS - LOOKOUT MOUNTAIN, LOOKOUT SEA
14) BLACK CROWES - WARPAINT
15) RYAN ADAMS - CARDINOLOGY
16) JJ GREY & MOFRO - ORANGE BLOSSOMS
17) CONOR OBERST - CONOR OBERST
18) THE GASLIGHT ANTHEM - THE 59 SOUND
19) JACKIE GREENE - GIVING UP THE GHOSTS
20) JENNY LEWIS - ACID TONGUE
21) DAN BAIRD & THE HOMEMADE SIN
22) DON CHAMBERS GOAT - ZEBULON
23) JASON COLLETT - HERE'S TO BE THERE
24) FRANK CARILLO & BANDOLEROS - SOMEDAY
25) ALI ESKANDERIAN - NOTHING TO SAY
26) HYACINTH HOUSE - BLACK CROWS COUNTRY
27) DAVID VANDERVELDE - WAITING FOR THE SUNRISE
28) LUCINDA WILLIAMS - LITTLE HONEY
29) WHIPSAWS - 60 WATT AVENUE 2008
30) GIANT SAND - PROVISIONS
31) TONI CHILDS – KEEP THE FAITH
32) BON IVER - FOR EMMA, FOREVER AGO
33) JOE JACKSON - RAIN
34) JAMEY JOHNSON - THAT LONESOME SONG
35) LAST MAN STANDING - FALSE STARTS AND BROKEN PROMISES
36) SHAWN MULLINS - HONEYDEW
37) GANDALF MURPHY & SLAMBOVIAN CIRCUS OF DREAMS - THE GREAT UNRAVEL
38) MYSTIX - BLUE MORNING
39) NEVA DINOVA - YOU MAY ALREADY BE DREAMING
40) OKKERVIL RIVER - THE STAND INNS
41) PORT O'BRIEN - ALL WE CAN DO IS SING
42) MATTHEW RYAN - VS SILVER STATE
43) DANIEL MARTIN MOORE - STRAY AGE
44) SHEARWATER - ROOK
45) RANDY THOMPSON - FURTHER ON
46) TEDDY THOMPSON - A PIECE OF WHAT YOU NEED
47) EDDIE COLE – IT’S THE APOCALYPSE BABY
48) BUTCH WALKER – SYCAMORE MEADOWS
49) MICAH P HINSON - AND THE RED EMPIRE ORCHESTRA
50) COUNTING CROWS - SATURDAY EVENING, SUNDAY MORNINGS
ALTRI DISCHI ITALIANI DA SEGNALARE PER VALORE (ORDINE SPARSO)
2) MASSIMILANO LAROCCA- LA BREVE ESTATE
3) DAVIDE VAN DE SFROOS - PICA!
4) LILITH & THE SINNERSAINTS - THE BLACK LADY AND THE SINNER SAINTS
5) THE PIEDMONT BROTHERS - BORDERTOWN
6) GRAZIANO ROMANI - BETWEEN TRAINS
ALTRE CLASSIFICHE 2008
LIVE ALBUM
1) ROLLING STONES - SHINE A LIGHT
2) WILLIE NILE - LIVE FROM THE STREETS OF NEW YORK
3) MAVIS STAPLE - LIVE, HOPE AT THE HIDEOUT
COVER ALBUM
1) MARIANNE FAITHFULL - EASY COME EASY GO
2) DARRELL SCOTT - MODERN HYMNS
3) RICHIE HAVENS - NOBODY LEFT TO CROWN (non tutto cover, ma le cover sono la cosa migliore del disco)
DELUSIONI 2008
MY MORNING JACKET - EVIL URGES
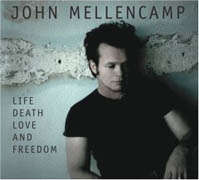 1
1 JOHN MELLENCAMP -
LIFE, DEATH, LOVE AND FREEDOM
Perché un uomo da rock altisonante e chitarre in libertà ha fatto centro al primo album pseudo-acustico della sua carriera. T Bone Burnett ci mette del suo, ma Mellencamp ha dimostrato di essere uno dei pochi eroi del rock americano ancora vivo creativamente. Sicuramente l’unico a non essere ancora mai morto.
 2
2
Perché un uomo da rock altisonante e chitarre in libertà ha fatto centro al primo album pseudo-acustico della sua carriera. T Bone Burnett ci mette del suo, ma Mellencamp ha dimostrato di essere uno dei pochi eroi del rock americano ancora vivo creativamente. Sicuramente l’unico a non essere ancora mai morto.
 2
2 BONNIE "PRINCE" BILLY
LIE DOWN IN THE LIGHT
Perché è il disco dove Oldham trova la quadratura del cerchio, perché gli arrangiamenti sono pieni e perfetti e le canzoni si fanno tutte ricordare…solo dopo molti ascolti. Ma se non siamo in grado di dedicare pazienza e tempo ad un autore così possiamo darci pure al punto e croce.
 3
3
Perché è il disco dove Oldham trova la quadratura del cerchio, perché gli arrangiamenti sono pieni e perfetti e le canzoni si fanno tutte ricordare…solo dopo molti ascolti. Ma se non siamo in grado di dedicare pazienza e tempo ad un autore così possiamo darci pure al punto e croce.
 3
3 KATHLEEN EDWARDS
ASKING FOR FLOWERS
Altro disco partito in sordina nei miei ascolti, ma arrivato sul podio sgomitando con le sue canzoni perfette, la sua irresistibile cantabilità e una serie di melodie che davvero non ti si scollano di dosso…. Ruba il posto al disco Acid Tongue di Jenny Lewis come miglior performance femminile dell'anno
Altro disco partito in sordina nei miei ascolti, ma arrivato sul podio sgomitando con le sue canzoni perfette, la sua irresistibile cantabilità e una serie di melodie che davvero non ti si scollano di dosso…. Ruba il posto al disco Acid Tongue di Jenny Lewis come miglior performance femminile dell'anno
ALEJANDRO ESCOVEDO
REAL ANIMAL
Poteva essere un’inutile amarcord di un artista sul viale del tramonto, è risultato essere il più bello e convinto omaggio alla grandezza del rock anni 70 e alle sue mille idee. Imprescindibile come gli eroi che omaggia. E ci restituisce pure il Chuck Prophet che rivorremmo sentire
http://www.rootshighway.it/recensioni/escovedo.htm
 5
5
Poteva essere un’inutile amarcord di un artista sul viale del tramonto, è risultato essere il più bello e convinto omaggio alla grandezza del rock anni 70 e alle sue mille idee. Imprescindibile come gli eroi che omaggia. E ci restituisce pure il Chuck Prophet che rivorremmo sentire
http://www.rootshighway.it/recensioni/escovedo.htm
 5
5 JAMES JACKSON TOTH
WAITING IN VAIN
Se nella canzone americana è davvero impossibile inventarsi qualcosa di nuovo allora questa è la soluzione: Dylan incontra i Wilco che incontrano Frank Zappa che incontrano un giovane pop-rocker dai toni strampalati e stralunati. Capire questo disco è un obbligo se non vogliamo morire nella noia della dilagante medietà.
http://ennegi.blogspot.com/search?q=toth
 6
6
Se nella canzone americana è davvero impossibile inventarsi qualcosa di nuovo allora questa è la soluzione: Dylan incontra i Wilco che incontrano Frank Zappa che incontrano un giovane pop-rocker dai toni strampalati e stralunati. Capire questo disco è un obbligo se non vogliamo morire nella noia della dilagante medietà.
http://ennegi.blogspot.com/search?q=toth
 6
6 THE MUDCRUTCH
THE MUDCRUTCH
L’altra faccia di Mellencamp: Petty è un artista in fase calante, dopo due dischi decisamente minori rispetto ai suoi standard temporeggia ancora con un disco con vecchi amici. Mudcrutch non toglie i dubbi su un’ispirazione appannata: le cose migliori sono cover e la penna a volte scivola ancora nel dejà vu, ma riconsegna un rocker in piena forma e il suono che vogliamo da lui. E Bootleg Flyer è la performance chitarristica dell'anno, e ormai sono rare.
L’altra faccia di Mellencamp: Petty è un artista in fase calante, dopo due dischi decisamente minori rispetto ai suoi standard temporeggia ancora con un disco con vecchi amici. Mudcrutch non toglie i dubbi su un’ispirazione appannata: le cose migliori sono cover e la penna a volte scivola ancora nel dejà vu, ma riconsegna un rocker in piena forma e il suono che vogliamo da lui. E Bootleg Flyer è la performance chitarristica dell'anno, e ormai sono rare.
RAY LAMONTAGNE
GOSSIP IN THE GRAIN
Gliela dovevo una nomination a Lamontagne dopo che nel 2006 avevo ingiustamente escluso il suo meraviglioso secondo disco. Gossip in The Grain sembra essere un gradino sotto il predecessore, ma lo conferma alla grande come l’unico uomo in grado di rifarsi a Van Morrison sembrando sperimentale. La conferma di uno dei pochi nomi da comprare a scatola chiusa in questi anni.
 8
8
MARAH
Gliela dovevo una nomination a Lamontagne dopo che nel 2006 avevo ingiustamente escluso il suo meraviglioso secondo disco. Gossip in The Grain sembra essere un gradino sotto il predecessore, ma lo conferma alla grande come l’unico uomo in grado di rifarsi a Van Morrison sembrando sperimentale. La conferma di uno dei pochi nomi da comprare a scatola chiusa in questi anni.
 8
8 MARAH
ANGELS OF DESTRUCTION!
Più che un disco un vero casino, ma resta il miglior guazzabuglio di rock and roll e quant’altro dell’annata…
Più che un disco un vero casino, ma resta il miglior guazzabuglio di rock and roll e quant’altro dell’annata…
DRIVE BY TRUCKERS
BRIGHTER THAN CREATION'S DARK
Probabilmente il disco dell’anno come scrittura e come spessore, un po’ penalizzato da qualche canzone di troppo e da una produzione leggermente loffia, ma a mio parere il miglior disco di una band che non mi aveva mai convinto fino in fondo ed è sulla buona strada per riuscirci.
Probabilmente il disco dell’anno come scrittura e come spessore, un po’ penalizzato da qualche canzone di troppo e da una produzione leggermente loffia, ma a mio parere il miglior disco di una band che non mi aveva mai convinto fino in fondo ed è sulla buona strada per riuscirci.
GARY LOURIS
VAGABONDS
Il disco che aveva tentato di fare con I Jayhawks di Smile gli riesce per caso e quando nessuno lo aspetta...e resterà il suo titolo più incompreso. The Band meets Beatles meets un personaggio fondamentale della musica americana.
Il disco che aveva tentato di fare con I Jayhawks di Smile gli riesce per caso e quando nessuno lo aspetta...e resterà il suo titolo più incompreso. The Band meets Beatles meets un personaggio fondamentale della musica americana.
DISCHI CALDI 2008 (11-20)
11) BASEBALL PROJECT - VOLUME 1-FROZEN ROPES AND DYIN' QUAILS
12)HOLD STEADY - STAY POSITIVE
13) SILVER JEWS - LOOKOUT MOUNTAIN, LOOKOUT SEA
14) BLACK CROWES - WARPAINT
15) RYAN ADAMS - CARDINOLOGY
16) JJ GREY & MOFRO - ORANGE BLOSSOMS
17) CONOR OBERST - CONOR OBERST
18) THE GASLIGHT ANTHEM - THE 59 SOUND
19) JACKIE GREENE - GIVING UP THE GHOSTS
20) JENNY LEWIS - ACID TONGUE
DISCHI DA RICORDARE
(TOP 30-50 - IN ORDINE SPARSO)
21) DAN BAIRD & THE HOMEMADE SIN
22) DON CHAMBERS GOAT - ZEBULON
23) JASON COLLETT - HERE'S TO BE THERE
24) FRANK CARILLO & BANDOLEROS - SOMEDAY
25) ALI ESKANDERIAN - NOTHING TO SAY
26) HYACINTH HOUSE - BLACK CROWS COUNTRY
27) DAVID VANDERVELDE - WAITING FOR THE SUNRISE
28) LUCINDA WILLIAMS - LITTLE HONEY
29) WHIPSAWS - 60 WATT AVENUE 2008
30) GIANT SAND - PROVISIONS
31) TONI CHILDS – KEEP THE FAITH
32) BON IVER - FOR EMMA, FOREVER AGO
33) JOE JACKSON - RAIN
34) JAMEY JOHNSON - THAT LONESOME SONG
35) LAST MAN STANDING - FALSE STARTS AND BROKEN PROMISES
36) SHAWN MULLINS - HONEYDEW
37) GANDALF MURPHY & SLAMBOVIAN CIRCUS OF DREAMS - THE GREAT UNRAVEL
38) MYSTIX - BLUE MORNING
39) NEVA DINOVA - YOU MAY ALREADY BE DREAMING
40) OKKERVIL RIVER - THE STAND INNS
41) PORT O'BRIEN - ALL WE CAN DO IS SING
42) MATTHEW RYAN - VS SILVER STATE
43) DANIEL MARTIN MOORE - STRAY AGE
44) SHEARWATER - ROOK
45) RANDY THOMPSON - FURTHER ON
46) TEDDY THOMPSON - A PIECE OF WHAT YOU NEED
47) EDDIE COLE – IT’S THE APOCALYPSE BABY
48) BUTCH WALKER – SYCAMORE MEADOWS
49) MICAH P HINSON - AND THE RED EMPIRE ORCHESTRA
50) COUNTING CROWS - SATURDAY EVENING, SUNDAY MORNINGS
THE BEST FROM ITALY 2008
LOWLANDS
THE LAST CALL
Perchè uno dei migliori dischi di Americana è nato a Pavia...disco maturo, emozionante e coronato da ottima scrittura e grandi suoni.....
ALTRI DISCHI ITALIANI DA SEGNALARE PER VALORE (ORDINE SPARSO)
2) MASSIMILANO LAROCCA- LA BREVE ESTATE
3) DAVIDE VAN DE SFROOS - PICA!
4) LILITH & THE SINNERSAINTS - THE BLACK LADY AND THE SINNER SAINTS
5) THE PIEDMONT BROTHERS - BORDERTOWN
6) GRAZIANO ROMANI - BETWEEN TRAINS
ALTRE CLASSIFICHE 2008
LIVE ALBUM
1) ROLLING STONES - SHINE A LIGHT
2) WILLIE NILE - LIVE FROM THE STREETS OF NEW YORK
3) MAVIS STAPLE - LIVE, HOPE AT THE HIDEOUT
COVER ALBUM
1) MARIANNE FAITHFULL - EASY COME EASY GO
2) DARRELL SCOTT - MODERN HYMNS
3) RICHIE HAVENS - NOBODY LEFT TO CROWN (non tutto cover, ma le cover sono la cosa migliore del disco)
DELUSIONI 2008
MY MORNING JACKET - EVIL URGES
MARK OLSON & GARY LOURIS - READY FOR THE FLOOD
JAKOB DYLAN - SEEING THINGS
JESSE MALIN - ON YOUR SLEEVE
PAUL WELLER - 22 DREAMS
CROOKED FINGERS - FORFEIT FORTUNE
BRETT DENNEN - HOPE FOR THE HOPELESS
JACKSON BROWNE - TIME, THE CONQUEROR
NICK CAVE - DIG LAZARUS DIG!
WILLY DEVILLE - PISTOLA
JOHN HIATT - SAME OLD MAN
RANDY NEWMAN - HARPS AND ANGELS