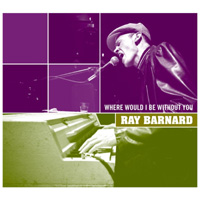Colin Meloy nelle foto di
presentazione di What a Terrible World, What a Beautiful World (Rough Trade, titolo rubato da un discorso di Barack
Obama), ha la faccia sorridente e sorniona di chi in qualche modo ce l’ha
fatta. Con numeri rapportati ai nostri tempi (quindi bassi), la storia dei suoi
Decemberists ricorda davvero quella dei R.E.M., band passata al successo
planetario dopo dieci anni di gavetta underground. Anche la loro musica era
finita per sembrare quella dei R.E.M., forse anche fin troppo nel precedente The King Is Dead del 2011, album che li
ha consacrati a gruppo simbolo dell’indie-rock di questi anni 2000. Ma i
Decemberists non erano partiti dal jingle-jangle rock di Stipe e soci: prima
c’erano stati il folk stralunato e cabarettistico di album come Her Majesty e Picaresque, poi il flirt con il prog di The Crane Wife e il rock anni 70 del concept The Hazards Of Love. Ma il nuovo album li conferma definitivamente:
ora i Decemberists piacciono a tutti, avanguardisti e tradizionalisti, classic-rocker
e giovani alternativi. E la vera vittoria è che per mettere d’accordo tutti,
Meloy ha realizzato il più classico dei Greatest Hits stilistici da band in
piena maturità. Qui ci sono tutte le loro anime, quella stravagante (come terminare
la scaletta con un brano intitolato A
Beginning Song), quella istrionica (l’esperimento sixty-pop di Philomena), quella tradizionalista (Make You Better è puro mainstream-rock) e,
ora, dopo quindici anni di carriera, anche quella più furba, fin dall’idea di
produrre un disco di brani easy & catchy
con fiati da canticchiare in coro (Cavalry
Captain) e archi sinuosi (Lake Song).
Manca quindi il loro lato più ostico e cervellotico, ma Meloy appare un uomo
diverso oggi, meno tormentato, più risolto, forse meno artista e più rockstar. Uno
stato di grazia produttivo quanto pericoloso il suo, che per qualcuno è
significato l’appiattimento e l’appagamento, per altri l’inizio di una nuova intrigante
vita artistica. Per loro chissà: di certo a rifare un album così perfettamente
orecchiabile al primo colpo come questo si rischierà la perdita del colpo di
scena, e quindi la noia. C’è dunque solo da sperare che Colin si complichi di
nuovo la vita.
lunedì 25 maggio 2015
venerdì 22 maggio 2015
RAY BARNARD
Il soul non è materia per timidi, anche nelle sue versioni più sofferte e lamentose, necessita di spiccate doti di istrionismo e di esternazione piena dei sentimenti, per cui l'espressione indie-soul appare davvero stridente. Per il resto abbiamo un nuovo bravo emulo in città signori miei, che ci propone un album fresco e veloce che non aggiunge nulla a quanto ci aveva già portato in casa un Aloe Blacc, per dirne uno tra i più famosi. Ma a questo punto una piccola sorpresa: Ray Barnard infatti non è un tipico americano nero in cerca dei propri padri musicali, ma un bianco texano abituato a presentarsi con Stetson di ordinanza. Prima del suo esordio infatti era il leader dei Copperheads, band che deve proprio a Steve Earle la propria denominazione sociale, che hanno realizzato tre album in proprio negli anni 2000 e sono stati usati come concert-band da artisti come Rosie Flores, Jack Ingram, Chris Scruggs e tanti altri. Questo spiega i vaghi sapori roots sparsi anche in questo Where Would I Be Without You (le armoniche e slides di Lost In The Flood ad esempio), un po' meno una voce decisamente soulful e black. Il che davvero dimostra quanto siano finiti i tempi del "razzismo al rovescio" per cui un tempo si pensava che solo uomini dalla pelle nera potessero suonare vero blues e soul, e forse anche evidenzia quanto questi ormai tanti anni di rinascita del soul classico abbiano ormai codificato il genere in regole talmente semplici e lineari, che anche un texano dagli occhi di ghiaccio può far emozionare tra fiati, piani wurlitzer, chitarre wah-wah e ritmi funky-soul. Segnalo poco i brani perché il disco si ascolta con piacere, ma manca delle classiche zampate del fuoriclasse, per quanto Roseville sia intensa, l'apertura di Bone Of My Bones impressioni, e il funky corale diBrothers riporti ai migliori Neville Brothers. In ogni caso la storia del soul non passa da queste parti. |
mercoledì 20 maggio 2015
CHADWICK STOKES
CHADWICK STOKES
THE HORSE COMANCHE
Nettwerk
***
Chadwick Stokes è
il leader di alcune interessanti band di Boston di questi anni 2000 (spesso
accreditato come Chad Urmston), i Dispatch (5 album tra il 1996 e il 2012, un
trio in qualche modo assimilabile alla Dave Matthews band come filosofia
musicale a metà tra jam, pop e roots-rock) e gli ancor più noti State Radio
(quattro album tra il 2006 e il 2012, di cui il terzo, Let It Go del 2009, è entrato anche nella Billboard americana
grazie al passaparola dei fans). Di suo aveva già prodotto due album (Live At the Brattle Theater del 2009 e Simmerkane II del 2011), ma è da questo
interessante The Horse Comanche che
possiamo senza remore occuparci di lui come di artista maturo e pronto a
solleticare anche i nostri esigenti palati. L’album ha avuto una genesi davvero
particolare, per quanto evidente segno
dei tempi: il nostro infatti ha chiesto ai propri fans di tutto il mondo la
disponibilità a organizzare degli house concerts (massimo 50 invitati) in cui
ascoltare, discutere e scegliere i dieci brani che hanno poi costruito l’album.
Una sorta di via democratica alla composizione che fa storcere il naso per chi
magari vede ancora l’artista come qualcuno che dovrebbe elevarsi dalla massa e
non confondersi, ma se il risultato è interessante è perché poi dopo un anno di
tour, prove e ripensamenti, Stokes ha realizzato il tutto con la dovuta
professionalità. Innanzitutto si è affidato a due mostri di genere, il grande Sam Bean alias Iron & Wine (e basta
ascoltare la conclusiva Walter per
sentirne la pesante eredità) e l’espertissimo produttore Brian Deck, per un
suono puramente indie-folk solo apparentemente scarno. Poi ha lavorato molto
sugli impasti vocali, un po’ Bon Iver, un po’ Fleet Foxes, un po’ John Grant,
un po’ anche sé stesso in alcune buone nuove idee, forse per lo più racchiuse
nei funambolici sei minuti e passa della title-track. Il disco per il resto si
barcamena tra momenti di intimo indie-folk (Pine
Needle Tea), pop stralunati e percussivi (Mother Maple) , strani esperimenti di indie-limbo caraibico (Prison Blue Eyes), l’innesto quasi-rap
di Our Lives Our Time, brano che
gravita in area Decemberists. Tanta carne al fuoco, anche se forse manca il
brano che faccia la differenza, a parte forse il bel singolo New Haven, impreziosito dall’intervento
dei Lucius. In ogni caso un artista da seguire lungo questo suo nuovo percorso.
Nicola Gervasini
lunedì 18 maggio 2015
XAVIER RUDD & THE UNITED NATIONS
XAVIER RUDD & THE UNITED NATIONS
NANNA
Nettwerk
***1/2
Devoto paladino del “chi fa da sé, fa per tre”, anche Xavier Rudd si arrende e registra con
una band il suo ottavo album. Famoso per
le sue funamboliche e variopinte (e multi-strumentali) registrazioni ed
esibizioni, Rudd si presenta infatti accompagnato dagli United Nations, nome
programmatico di un combo nato a tavolino secondo un preciso schema multiculturale,
con una ratio politically correct
limitata solo dal numero di strumenti necessari. Per cui spazio ad un
australiano ma anche ad un aborigeno, ai quali si aggiungono musicisti provenienti
dal Sudafrica, da Samoa, dalla Germania e da Papua Nuova Guinea. Un bel meltin’ pot culturale per un minestrone
di cinquantaquattro minuti amalgamato da un unico elemento ritmico: il reggae.
Non è la prima volta che Rudd evidenzia un certo tono alla Bob Marley della sua
voce, ma Nanna vuole essere un (riuscito) omaggio alla world-music e non
solo al grande artista giamaicano. Ma
ovviamente è a Marley che si pensa quando si legge della decisione di far
mixare il tutto a Errol Brown,
ingegnere del suono della mitica etichetta Tuff Gong, proprio la persona che ha
lavorato negli studi di Kingston in Giamaica dove sono nati i capolavori di
Marley, Peter Tosh, Burning Spear, Third World e tanti altri. Un po’ come
intingere l’opera nell’aria giusta per ottenere uno dei dischi reggae più
freschi e avvincenti degli ultimi anni, e chissà se Sir Mick Jagger avrà
occasione di rendersi conto che era questo il disco che ci si aspettava dai
suoi fallimentari SuperHeavy. Sul contenuto siete avvertiti: se siete tra
quelli che pensano che un disco intero di Bob Marley sia noioso perché le
canzoni sembrano tutte uguali perché hanno tutte lo stesso ritmo, allora state
lontani da Nanna, se invece siete tra quelli che pensano che il genere possa
ancora dire la sua senza troppo imbastardirsi con altri generi (come ha
dimostrato anche il buon ritorno di Jimmy Cliff tre anni fa), allora date una
chance a Rudd, artista ormai scafato e in grado di reggere anche un intero
disco a tema. Certo, magari non tutto gira a meraviglia e la sensazione di già
sentito impera sempre, ma brani come la frizzantissima Hanalei , la quasi funky Come
People (che pare più guardare a Ziggy Marley piuttosto che a Bob) che si
trasforma poi in una Sacred che ha la
potenza spirituale del miglior Ben Harper. Interessante anche la title-track
con il suo crescendo, anche se la seconda parte del disco inevitabilmente
ribadisce il già detto e forse andava tagliata di almeno un paio di brani. In
ogni caso un bel “debutto” per Rudd in versione frontman, che speriamo di poter
magari gustare anche dal vivo in Italia, dove da sempre può contare su un
nutrito seguito di appassionati.
Nicola Gervasini
venerdì 15 maggio 2015
JOHN CARPENTER
Dal 2001 ad oggi ha girato un
solo film (il discusso e ignorato The
Ward-Il Reparto), ma a 67 anni John Carpenter non ha perso la voglia di
scherzare con il proprio mito. Noto per essere uno dei pochi registi che ha
scritto ed eseguito le musiche della maggior parte dei suoi film, Carpenter è
infatti visto da molti anche come un piccolo genio non riconosciuto della
musica elettronica. Esiste già una bella raccolta (edita dalla Silva America
nel 1992) che si intitola Halloween: The
Best Of John Carpenter e racchiude tutte le sue più celebri colonne sonore
(The Fog, Dark Star, Escape From New York
e tante altre), ma Lost Themes (Sacred Bones), disco edito a sorpresa in questo
inizio del 2015, è un’operazione diversa. Sono inediti, scritti e suonati dal
vecchio John assieme al figlio Cody (musicista vero lui, nella band dei
Ludrium) e il chitarrista Daniel Davies, leader degli Year Long Disaster (e
figlio di Dave Davies dei Kinks), tutti rigorosamente strumentali, ma con
titoli eloquentissimi come Vortex,
Mystery, Abyss, Purgatory, Night e via dicendo. E sono esattamente come ve
li aspettate, con un sound che potrebbe essere ancora quello di un qualsiasi horror-score
dei primi anni ottanta, immersi in un orgia di sintetizzatori e drum-machines
con contrappunti di piano e chitarra elettrica, con tutti gli inevitabili rimandi
ai Goblin e a Mike Oldfield. Il denominatore comune di questi nove brani è la
paura e la tensione di un film inesistente, che si materializza nella sua e
nella nostra testa all’ascolto. E al di là della curiosità per cinefili,
l’ascolto è suggestivo e intrigante, per quanto completamente fuori dal tempo. Presentando
l’album Carpenter ha sottolineato la giocosità del progetto, quasi abbia timore
che lo si pigli davvero per un musicista, ma ha anche detto che spera che
queste musiche possano ispirare qualche nuovo film di un giovane regista. Come
dire che lui ha già dato, ma visto che nessuno prova più ad osare tanto, deve ancora
una volta fare tutto lui.
Nicola Gervasini
mercoledì 13 maggio 2015
BELLE AND SEBASTIAN
Girls in Peacetime Want to Dance sta perlomeno facendo parecchio discutere, ed effettivamente, esaurita la sorpresa di scoprirli per metà album alle prese con sonorità che avreste potuto trovare in un vecchio disco di Kim Wilde o Kyle Minogue (Play For Today su tutte), li risolleva anche come forza creativa moderna. Prodotto dal mixerista pop Ben H. Allen III (dagli Animal Collective a Christina Aguilera i suoi clienti), il disco si divide in due anime: da una parte quella più soft, folk-pop e orchestrata che già si conosceva (The Cat With The Cream,Today), dall'altra una serie di dance-songs più o meno spensierate nell'anima, ma fortunatamente non nel songwriting. Quello che piace dell'esperimento, sempre che siate dell'umore di sorbivi una serie di tastiere e drum-machines che magari speravate ormai appartenere solo all'airplay di Radio Capital, è proprio che Stuart Murdoch e soci non hanno perso l'occhio sulle canzoni, valide anche sui ritmi danzerecci di The Party Line o di una Enter Sylvia Plath che richiama i Pet Shop Boys strizzando l'occhio al Mark Lanegan più recente. La vittoria quindi è stata quella di aver dato sostanza ad un genere "leggero" come la dance, la sconfitta però, se così la possiamo definire, sta nel fatto che poi alla fine i brani che si ricordano più volentieri sono quelli in cui la band flirta con un pop adulto e per nulla easy come le iniziali Nobody's Empire e Allie o la brit-oriented The Everlasting Muse. Tra alti e bassi e gran confusione di suoni e ispirazioni diverse, Girls in Peacetime Want to Dance risulta essere il loro disco più divertente da parecchio tempo a questa parte, ma se poi sia abbastanza per rilanciarne il nome tra i top del decennio, è questione ancora tutta da discutere. |
lunedì 11 maggio 2015
WATERBOYS
 | The Waterboys Modern Blues [Kobalt/ Self 2015] www.mikescottwaterboys.com di Nicola Gervasini (27/01/2015) |  |
Mike Scott sa benissimo di avere fatto qualcosa di importante in carriera. Il cofanetto delle sessions di Fisherman's Blues è lì a dimostrarlo, opera imponente a autocelebrativa della âge d'or dell'artista scozzese. Sarà forse per questo che la discografia dei Waterboys, da quell'album in poi, è stata un continuo rincorrere il mito e cercare il colpo ad effetto. Dal 1990 ad oggi non c'è un loro disco che assomigli al precedente, e se questo è garanzia di vitalità artistica, va detto che, con i suoi alti e bassi, non solo Scott non ha più raggiunto le vette degli anni ottanta (ma sarebbe stato anche troppo pretenderlo), ma ha prodotto anche una serie di album alterni, poco significativi, e soprattutto ininfluenti se visti con l'occhio più ampio dello scenario musicale di questi anni 2000.
In questo senso va letto il tentativo con Modern Blues di tornare ad essere "moderni" pur conservando il marchio sonoro "alla Waterboys", con una operazione di mix tra vecchio e nuovo che alla fine lascia perplessi. Il vecchio sta tutto nella costruzione delle canzoni, mai come mai legate alla lezione Van Morrison (l'omaggio al jazz che fu di Nearest Thing To Hip si avvicina molto al plagio stilistico), nel recupero di melodie tipicamente da "periodo folk" della band, nella collaborazione di vecchi compari come Steve Wickham accanto a nuovi innesti provenienti dal mondo della soul music come il tastierista Paul Brown e l'ultrasettantenne bassista David Hood, figura mitica dei Muscle Shoals e padre del Patterson dei Drive By Truckers. Ma Scott non si adagia solo su quel sound morrisoniano che già aveva recuperato in Book Of Lightning del 2007: porta tutti a registrare a Nashville, ma invece di lasciarsi coinvolgere dal clima del luogo, modernizza tutto con un sound pompatissimo e rockeggiante da radio FM anni 80, lo stesso che avrebbe potuto usare un Joe Cocker dell'epoca. E, in più, appesantisce ogni brano con arrangiamenti magniloquenti, big drums d'altri tempi, assoli un po' strafottenti.
Insomma, il meglio di Fisherman's Blues mischiato al peggio di album come Dream Harder e A Rock In The Weary Land convivono assieme per un disco che suona brillante e decisamente accattivante, quanto anche inutilmente sguaiato e esibizionista. E se poi a volte basta la canzone a perdonare riffoni di chitarra davvero fuori luogo (Destinies Entwined e il travolgente finale di Long Strange Golden Road), in altri casi il risultato sfiora un po' il ridicolo, come nel blues di Still A Freak. Modern Blues è dunque un ottimo album rovinato da un autore che cerca di far scena, ci mette troppe idee e troppi suoni inutili, portandoci alcuni dei migliori brani usciti dalla sua penna negli ultimi vent'anni (splendide I Can See Elvis e November Tale), ma anche tante canzoni che meritavano altro sviluppo (Rosalind, The Girl Who Slept For Scotland) e qualcuna proprio minore (Beautiful Now). Forse perché, se proprio aveva intenzione di riportarci agli anni ottanta, allora era This Is The Sea con il suo vago taglio new wave il disco da riprendere in mano, non questa versione da arena rock sporcata da black music di Fisherman's Blues.
In questo senso va letto il tentativo con Modern Blues di tornare ad essere "moderni" pur conservando il marchio sonoro "alla Waterboys", con una operazione di mix tra vecchio e nuovo che alla fine lascia perplessi. Il vecchio sta tutto nella costruzione delle canzoni, mai come mai legate alla lezione Van Morrison (l'omaggio al jazz che fu di Nearest Thing To Hip si avvicina molto al plagio stilistico), nel recupero di melodie tipicamente da "periodo folk" della band, nella collaborazione di vecchi compari come Steve Wickham accanto a nuovi innesti provenienti dal mondo della soul music come il tastierista Paul Brown e l'ultrasettantenne bassista David Hood, figura mitica dei Muscle Shoals e padre del Patterson dei Drive By Truckers. Ma Scott non si adagia solo su quel sound morrisoniano che già aveva recuperato in Book Of Lightning del 2007: porta tutti a registrare a Nashville, ma invece di lasciarsi coinvolgere dal clima del luogo, modernizza tutto con un sound pompatissimo e rockeggiante da radio FM anni 80, lo stesso che avrebbe potuto usare un Joe Cocker dell'epoca. E, in più, appesantisce ogni brano con arrangiamenti magniloquenti, big drums d'altri tempi, assoli un po' strafottenti.
Insomma, il meglio di Fisherman's Blues mischiato al peggio di album come Dream Harder e A Rock In The Weary Land convivono assieme per un disco che suona brillante e decisamente accattivante, quanto anche inutilmente sguaiato e esibizionista. E se poi a volte basta la canzone a perdonare riffoni di chitarra davvero fuori luogo (Destinies Entwined e il travolgente finale di Long Strange Golden Road), in altri casi il risultato sfiora un po' il ridicolo, come nel blues di Still A Freak. Modern Blues è dunque un ottimo album rovinato da un autore che cerca di far scena, ci mette troppe idee e troppi suoni inutili, portandoci alcuni dei migliori brani usciti dalla sua penna negli ultimi vent'anni (splendide I Can See Elvis e November Tale), ma anche tante canzoni che meritavano altro sviluppo (Rosalind, The Girl Who Slept For Scotland) e qualcuna proprio minore (Beautiful Now). Forse perché, se proprio aveva intenzione di riportarci agli anni ottanta, allora era This Is The Sea con il suo vago taglio new wave il disco da riprendere in mano, non questa versione da arena rock sporcata da black music di Fisherman's Blues.
giovedì 7 maggio 2015
RODDY DOYLE
Può Il rock and roll sconfiggere la paura della morte?
Domanda antica, da indomiti musicofili quale è Jimmy Rabbitte, il mitico
manager dei Commitments nel romanzo di Roddy Doyle del 1987, divenuto poi un
noto film di Alan Parker nel 1991. Nel 2014 Jimmy continua imperterrito a
vivere di rock, nonostante abbia figli adolescenti e un tumore con cui venire a
patti. Prova dunque a buttarla sul serio Doyle in La Musica E’ Cambiata (Guanda), sequel dei Commitments più per
motivi di marketing che altro, visto che trattasi di romanzo del tutto
indipendente. L’autore irlandese, noto
anche per la sua vasta letteratura per bambini, prova ad affrontare temi
importanti (la malattia, la tenuta dei rapporti sentimentali davanti
all’imminenza della morte), interessandosi ad osservare un eterno adolescente
alle prese con i “veri problemi”, e misurandone il coraggio (il titolo
originale del libro è infatti questo, The
Guts, Il Coraggio). E così la leggerezza di una storia/pretesto che farà
ritrovare al protagonista il senso della vita solo inventandosi un finto gruppo
bulgaro dedito al rock and roll grazie al quale vincerà la guerra di
visualizzazioni in YouTube, diventa l’esaltazione della easy-way-of life della generazione dei nuovi quarantenni, incapaci
di finir di giocare anche davanti al pericolo di morte. Doyle narra usando
tanti dialoghi, poche descrizioni, e mille citazioni musicali, perdendo di
vista un po’ il senso “pesante” del libro a favore della frivolezza. Ma anche
così si muore un po’ di meno.
Nicola Gervasini
lunedì 4 maggio 2015
THE DISTRICTS
THE DISTRICTS
A FLOURISH AND A SPOIL
Fat Possum records
***
Il rock non è il calcio. Nell’arte del pallone, si sa, il
talento non basta. Serve anche esperienza, furbizia e testa da campione. Cose
che si costruiscono nel tempo. Nel rock invece l’esperienza aiuta, serve, ma il
grande fuoco del talento del teen-ager è spesso bastato a generare grandi
dischi, pieni di quell’urgenza e spontaneità che sono alla base del linguaggio
pop. Nessun dubbio quindi che anche una band di diciannovenni al debutto possa
competere con i nomi già consolidati del panorama pop-rock, per cui anche
un’etichetta come la Fat Possum, attentissima a cercare nuovi nomi
dell’underground da affiancare ai propri cavalli di razza (Black Keys, Band Of
Horses e tanti altri), non ha avuti dubbi a concedere la prima occasione ai Districts, quartetto di volenterosi
universitari della Pennsylvania. A Flourish And A Spoil è stato
prodotto da John Congleton (già visto dietro i mixer per St Vincent e gli Swans)
con un target doppio: da una parte mantenere il sound chitarristico di base
della band, e dall’altra esaltarne una certa vena radio-friendly, sia mai che
in tempi in cui i Black Keys sono riusciti ad entrare chissà come negli airplay
più mainstream, non si trovi anche qualche nuovo piccolo fenomeno grazie al
quale risollevare il mercato musicale. Niente di male, Roob Grote (voce e chitarra), Connor Jacobus (basso), Braden
Lawrence (batteria) e il chitarrista Pat Cassidy sembrano sapere il fatto loro
con un mix di riff molto garage-oriented o Black Keys-like, con un uso continuo
del gioco di corse, frenate in momenti riflessivi e spesso pischedelici (Young Blood) e ripartenze che
movimentano non poco la loro proposta. Il loro pregio maggiore sembra proprio quello
di non essere banali nella costruzione dei brani, spesso vere e proprie piccole
suite di rock underground, ma dall’altra parte la band sembra ancora avere da
imparare sul piano della scrittura, perché a questi dieci brani manca ancora la
forza di imprimersi nella memoria dell’ascoltatore al primo, e forse nemmeno al
decimo, colpo. Come se restassero ancora troppo in superficie, accontentandosi
di aver prodotto un esordio interessante e con tutti i crismi del rock-record
moderno, ma senza portare alla causa la voglia di spaccare il mondo e quella
sana presunzione che ci si potrebbe aspettare da dei neo-ventenni. Hounds e Suburban Smell potrebbero essere i brani da segnarsi, anche per
ricordarsi in futuro di dar loro una seconda chance: si sa che spesso,
nell’emozione di essere finalmente arrivati a registrare il primo disco della
propria carriera, ci si dimentica anche di imprimergli tutta la personalità di
cui potrebbero anche essere pieni, e che qui si percepisce solo a piccole e
troppo misurate dosi.
Nicola Gervasini
venerdì 1 maggio 2015
H HAWKLINE
IN THE PINK OF CONDITION
Heavenly
records
***1/2
Bello sapere che certi semi piantati nel corso della storia
da vari artisti continuano a generare nuove piante, anche quando il terreno ha
smesso di essere fertile. Bello sapere che esistono ancora artisti come H Hawkline, pieni di riferimenti e
atteggiamenti ad un mondo indie-pop che possiamo ormai considerare del passato.
Vezzi indie come l’uso di un nickname, in verità a rappresentanza del Signor Huw
Gwynfryn Evans, uno con un nome probabilmente pronunciabile solo in Galles. E
poi la musica contenuta in questo In The Pink of Condition, album di
esordio che arriva dopo una lunga serie di singoli e partecipazioni a
compilation: siamo al ritorno del lo-fi
anni 90, tanto (ma tanto) dei Pavement e dei dEUS, con quel piglio volutamente
scazzato e scanzonato che oggi suona un po’ come un atteggiamento voluto e studiato.
Potremmo quasi inquadrarlo in una forma di 90-revival, azzardando un parallelo
con quei gruppi tipo Sha Na Na che negli anni settanta giravano ancora con
ciuffi in brillantina e rock and roll alla Elvis Presley nella speranza di riportare
indietro la lancetta del tempo. Ma i riferimenti non finiscono qui, perché il
toy-piano di In Love lo troveresti
uguale in un disco degli Eels, e in brani come Dirty Dreams o Rainy Summer
si sente che le più recenti lezioni di Bon Iver, Gruff Rhys o band come i Port
O’Brien, non sono passate invano. Hawkline però è bravo a dosare bene allegre
pop-songs (Moon Is My Mirror – non a
caso il singolo - , Moddion), momenti più
riflessivi (Isobelle) e idee
sperimentali (Everybody’s on the line),
e il disco alla fine suona fresco e godibile, pur portando avanti discorsi già
sentiti. Si segnalano comunque anche la stralunata Spooky Dog e il bel finale di Back
In Town, episodi che chiudono in crescendo un album fino a quel momento
altalenante. Originalità e personalità infatti passano anche da queste parti,
ma solo a tratti e in potenza, e forse
il secondo album avrà più coraggio in questo senso. Ma se i nomi citati sono
già da tempo nella vostra playlist, vale la pena dare una chance a In The Pink Of Condition, che non è titolo
da lasciare nel dimenticatoio troppo presto.
Nicola Gervasini
Iscriviti a:
Post (Atom)
BILL RYDER-JONES
Bill Ryder-Jones Lechyd Da (Domino 2024) File Under: Welsh Sound I Coral sono da più di vent’anni una di quelle band che tutti...
-
12/12/2006 Rootshighway VOTO: 6 Accade di trovarsi davanti ad opere che hanno un doppio valore, uno storico e, potremmo dire, "filologi...
-
NICOLA GERVASINI NUOVO LIBRO...MUSICAL 80 UN NOIR A SUON DI MUSICA E FILM DEGLI ANNI 80 SCOPRI TUTTO SU https://ngervasini.wixsite.com...