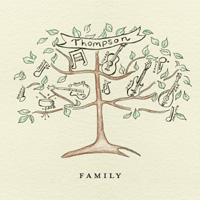Un paesaggio industriale avvolto
nella nebbia proiettato all’interno di figure dall’aria sinistra, e, a commento,
un valzer country pigro e indolente, lugubre, quasi gotico. Inizia così il
serial
True Detective, quanto basta
perché sigla e canzone siano già un nuovo piccolo culto tra gli appassionati.
Il segreto è tutto proprio nella scelta del brano, una
Far From Any Road pescata nel misconosciuto repertorio degli Handsome
Family, duo alternative-country ancora oggi attivo, e titolare di una
discografia altamente consigliata perlomeno per quel che riguarda il periodo
d’oro 1996-2003 (il brano di True Detective proviene dall’album
Singing Bones del 2003). E’ la
dimostrazione che ci vuole talento e fiuto non solo per creare musica per
immagini, ma anche per scegliere e selezionare quella più adatta. E
T-Bone
Burnett, responsabile della soundtrack di tutta la serie di Nic
Pizzolatto, da anni eccelle in entrambe le arti. Lui è uno degli ultimi
produttori di vecchia concezione rimasti nel firmamento del rock americano,
ormai frantumato dall’avvento della produzione casalinga e indipendente. E’ uno
di quelli che quando produce un album impone un proprio suono e una propria
filosofia, con i pro (produzioni pressoché perfette e sempre emotivamente penetranti) e contro (il rischio
è che tanti artisti tra loro diversi finiscano a fare lo stesso disco) che la
cosa comporta, ma quando lavora per il cinema Burnett sa sempre dare la giusta
priorità alle immagini. D’altronde già nel 1976 il suo esordio da musicista
professionista fu immortalato da un Bob Dylan improvvisato a regista per
Renaldo e Clara, film in cui T-Bone,
giovane e sconosciuto chitarrista ritmico della Rolling Thunder Revue, si
muoveva già con la sicurezza del professionista. Ma il suo rapporto con il
cinema inizia solo nel 1993, quando Wim Wenders utilizza un suo brano per il
suo
Fino Alla Fine del Mondo, ed è la
scoperta di quanto il suo suono bene si sposi con la celluloide. Negli anni
novanta produce così le colonne sonore di
Io
Ballo da Sola di Bertolucci
, L’Uomo
che sussurrava ai cavalli di Robert Redford,
Il sapore del Sangue di Dave Dobkin, e supervisiona la scelta di
brani per
Il Grande Lebowski dei
fratelli Coen.

Ed è grazie a loro che nel 2000 che arriva il gran colpo, con lo
score di
O Brother, Where Art Thou?, colonna sonora vendutissima e
premiatissima, che ha avuto anche il merito di lanciare una corrente di
bluegrass-revival che ha ravvivato non poco il mondo musicale americano di
quegli anni. Da allora piovono successi: dal documentario sul mondo bluegrass
Down From The Mountain, nato proprio
sulla scia del lavoro per il film dei Coen, alle soundtrack per
Ritorno a Cold Mountain di Anthony
Minghella,
Ladykillers ancora
dei Coen, e il biopic su Johnny Cash
I Walk The Line (
Quando l’amore brucia l’anima in Italia). Nel 2010 arriva poi la
definitiva consacrazione del matrimonio tra cinema e musica roots con la
colonna sonora di
Crazy Heart di
Scott Cooper, grazie all’oscar vinto dal brano
The Weary Kind, interpretato da Ryan Bingham. Hollywood prova allora
a fargli salire un gradino nello star-system e arrivano lo score pensato per il
blockbuster
Hunger Games e, appunto,
la consacrazione nel mondo dei serial con la colonna sonora per
True Detective. Che è un felice campionario
del meglio della musica roots (e non solo), assemblato con abile mix di
classici e pezzi minori tutti da scoprire. Lui assicura che quella cinematografica
non sia la sua occupazione principale, ma l’impressione è che True Detective
sposterà non poco il focus della sua carriera, visto che già ha molto
rallentato l’attività di produttore (
The
Diving Board di Elton John è l’ultimo album che porta la sua firma), e al
massimo si è concentrato su progetti personali come il recentissimo
Lost On The River: The New Basement Tapes,
album in cui ha musicato una serie di testi inediti di Bob Dylan. Resta dunque solo
da capire per quale altra serie in futuro ci farà ancora da perfetto deejay.
Nicola Gervasini
HANDSOME FAMILY
Diventati artisti più per gioco d’amore che per vocazione, i
coniugi Brett e Rennie Sparks furono ironicamente battezzati The Handsome Family dal loro batterista per il loro look
decisamente anti-estetico. I due venivano da Chicago e si fecero notare dalla
critica nel 1996 con il secondo album Milk And Scissors, forti di una formula
musicale tra le più interessanti di quegli anni, definita dai critici
gothic-country. Strutture tradizionali prettamente a base di chitarre acustiche
e banjo si sposavano infatti a lugubri melodie che guardavano a Nick Cave e ai
nuovi eroi del mondo indie (Bill Callahan su tutti). Il risultato era unico ai
tempi, oggi pare invece imitatissimo, tanto che un loro brano di più di dieci
anni fa finisce pure per sembrare moderno come sigla di un serial televisivo.
Nicola Gervasini