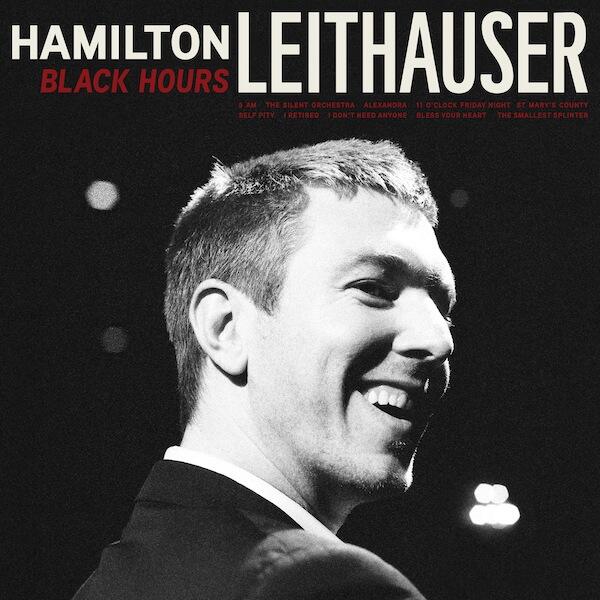Little
Angel & The Bonecrashers
J.A.B.
(Little Angels
& The Bonecrashers, 2014)
File Under: “It’s fucking country western”
 C’è un
motivo preciso per considerare i varesotti Little
Angel & The Bonecrashers un gruppo decisamente controcorrente nel
ribollente panorama roots italiano. Nella scelta se prediligere l’aspetto
autoriale del fare rock delle radici (i Lowlands , ma anche i Mandolin Brothers
più recenti, vanno in quella direzione) o lasciarsi andare ad un plateale yankee re-make a misura di pubblico,
loro scelgono una via intermedia. Bando alle cover di facile richiamo (pegno di
riconoscenza già pagato nel loro primo album), bando al facile jumpin’-country
da sagra per finti-cowboy padani, ma anche bando a personali variazioni sul
tema da un punto di vista stilistico. Cristiano
Carniel è un cultore del rock americano severo e rigoroso, e se rispetto
all’ormai lontano esordio del lontano 2006 ha avuto il tempo di crescere come
autore e assemblare dieci brani che si stampano nella mente fin dal primo
ascolto, è anche regista attento a non uscire mai dal seminato della tradizione.
Gli Uncle Tupelo restano il loro faro (li si sente parecchio quando rallentano
il ritmo in Birdies o nell’ottima
ballata Poor John), il tocco alla
Drive-by Truckers la massima concessione alla modernità (viaggiano in quei
paraggi l’ironica Harry’s Wife e la
conclusione a elettriche spianate di Troubles
Everyday), ma, appena possono, si rifugiano volentieri nella rassicurante
prevedibilità di giri country alla Johnny Cash (Johnny Lee Blues o anche Cowboy’s
Prayer, impreziosita dalla fisarmonica Gianmarco Banzi) con una inflessibilità
espressiva che potrebbe sembrare in contraddizione con il modo decisamente
ironico e scanzonato che hanno nel presentarsi fin dalla copertina. J.A.B.
è un disco maturo anche nel modo di raccontare le storie , sia quella della
prostituta di 1000 Miles Amelia (brano
che esalta la voce di Stefano Tosi e testo che ricorda un po’ la Veronica di Jannacci), sia il “family
drama” di My Last Ride (testo del
chitarrista Gianluca Lavazza, arrangiamento pensato in collaborazione con Davide Buffoli) o lo sfogo esistenziale
di Regrets (Sweet Revenge Song). Sono
solo un’altra band dalla provincia (come cantano in Just Another Band), ma J.A.B.
li elegge a rari paladini nostrani di una disciplinata rilettura della
tradizione americana.
C’è un
motivo preciso per considerare i varesotti Little
Angel & The Bonecrashers un gruppo decisamente controcorrente nel
ribollente panorama roots italiano. Nella scelta se prediligere l’aspetto
autoriale del fare rock delle radici (i Lowlands , ma anche i Mandolin Brothers
più recenti, vanno in quella direzione) o lasciarsi andare ad un plateale yankee re-make a misura di pubblico,
loro scelgono una via intermedia. Bando alle cover di facile richiamo (pegno di
riconoscenza già pagato nel loro primo album), bando al facile jumpin’-country
da sagra per finti-cowboy padani, ma anche bando a personali variazioni sul
tema da un punto di vista stilistico. Cristiano
Carniel è un cultore del rock americano severo e rigoroso, e se rispetto
all’ormai lontano esordio del lontano 2006 ha avuto il tempo di crescere come
autore e assemblare dieci brani che si stampano nella mente fin dal primo
ascolto, è anche regista attento a non uscire mai dal seminato della tradizione.
Gli Uncle Tupelo restano il loro faro (li si sente parecchio quando rallentano
il ritmo in Birdies o nell’ottima
ballata Poor John), il tocco alla
Drive-by Truckers la massima concessione alla modernità (viaggiano in quei
paraggi l’ironica Harry’s Wife e la
conclusione a elettriche spianate di Troubles
Everyday), ma, appena possono, si rifugiano volentieri nella rassicurante
prevedibilità di giri country alla Johnny Cash (Johnny Lee Blues o anche Cowboy’s
Prayer, impreziosita dalla fisarmonica Gianmarco Banzi) con una inflessibilità
espressiva che potrebbe sembrare in contraddizione con il modo decisamente
ironico e scanzonato che hanno nel presentarsi fin dalla copertina. J.A.B.
è un disco maturo anche nel modo di raccontare le storie , sia quella della
prostituta di 1000 Miles Amelia (brano
che esalta la voce di Stefano Tosi e testo che ricorda un po’ la Veronica di Jannacci), sia il “family
drama” di My Last Ride (testo del
chitarrista Gianluca Lavazza, arrangiamento pensato in collaborazione con Davide Buffoli) o lo sfogo esistenziale
di Regrets (Sweet Revenge Song). Sono
solo un’altra band dalla provincia (come cantano in Just Another Band), ma J.A.B.
li elegge a rari paladini nostrani di una disciplinata rilettura della
tradizione americana.
Nicola Gervasini