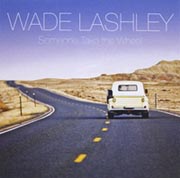13/02/2009
Rootshighway
voto: 6,5
Nell'elenco dei "raccomandati" senza ancora nulla di veramente dimostrato, Liz Durrett vanta una ragguardevole posizione. L'introversa nipotina di Vic Chesnutt, curiosamente nata nella Roma posticcia della Georgia, bazzica le scene da parecchio tempo, con trascorsi da precoce songwriter adolescente per tutti gli anni '90. La produzione della prima parte della carriera è stata registrata e prodotta dallo zio Vic nel disco Husk (che ha visto la luce solo nel 2005), mentre l'esordio vero e proprio è arrivato con il misconosciuto seguito del 2006 (Mezzanine). Outside Our Gates, il suo terzo disco, nasce ad Athens, sotto l'ala esperta di un mago della musica indipendente come Eric Bachmann (Crooked Fingers, Archers of Loaf) e la supervisione di Chesnutt, che partecipa con chitarra e voce. Un team certamente prestigioso, che ha confezionato per la ragazza un sound tetro e autunnale quanto pieno e maturo, grazie soprattutto al genio eclettico di Bachmann (fin troppo eclettico a volte, a giudicare anche dall'ultima confusionaria uscita dei Crooked Fingers), che in questa occasione suona veramente di tutto, fiati compresi.
La Durrett non corre più da sola quindi, ma si lascia trascinare in un vortice di chitarre pigre, archi e tastiere avvolgenti, fiati stridenti e tante percussioni. Un suono sinistro quanto i testi di Liz, che nel singolo Wild As Them sogna di cercare le ossa della persona cara in un bosco, o basterebbero anche solo i versi di Wake To Believe che aprono il cd ("l'orologio gira e gira, e il mio panico suona come un tick tock..") per capire dove si vuole andare a parare. Musica onirica e nebbiosa come le foto offuscate del booklet (l'artwork è stato curato da lei stessa), una ricetta certamente non nuova, che abbandona il minimalismo dei suoi primi dischi (che la faceva assomigliare molto alla Cat Power degli esordi), e si avvicina di più a quello stile moderno condiviso da cantautrici come Kris Delmhorst e Alela Diane. Al di là di decidere se lasciarsi suggestionare da qualche buon trucchetto da sala di incisione, va sicuramente rilevato come la scrittura della Durrett sia in qualche caso cresciuta positivamente, non tanto quando segue l'ermetismo di quelle che, più che canzoni fatte e finite, sembrano essere bozzetti d'artista (i testi di We Build Bridges e Lost Hiker si esauriscono in poche e stringate immagini), quanto dove la vena creativa trova la forza di espandersi in un testo compiuto come Not Running, splendido brano che potrebbe davvero rappresentare il punto di partenza per ulteriori sviluppi.
Sebbene trovi finalmente la quadratura tra suoni e vocalizzi, il disco difetta di varietà, e se l'esperimento corale di The Sea A Dream chiude in maniera più che originale il tutto, alcuni passaggi centrali come Note For A Girl o In The Eaves più che essere eterei, risultano semplicemente impalpabili. Zio Vic scelga: o ci lavora sopra ancora qualche anno, oppure la lasci camminare sulle proprie gambe per vedere se sta in piedi anche da sola.
(Nicola Gervasini)