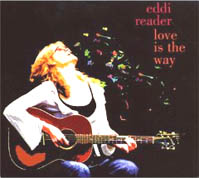10/07/2009
Rootshighway
VOTO: 7
Vista la tanta attenzione e i non pochi riconoscimenti che sta mietendo Joe Purdy, immaginiamo che siano tanti i cantautori indipendenti e "home-made" che ne invidiano la certa notorietà conquistata in questi ultimi anni. Eppure questo atteso Last Clock On The Wall, ufficialmente il suo decimo album in dieci anni di attività, conferma che la sua posizione comincia ad essere parecchio scomoda. Spieghiamoci meglio: chi si è già innamorato del personaggio, magari per le canzoni ascoltate in famosi serial televisivi o per l'acclamato Take My Blanket And Go dello scorso anno, continuerà a trovare emozionante il lamento triste e strascicato della sua voce, e quel suo stile sempre sospeso a metà tra un country di younghiana memoria e melodie da New Dylan anni 2000. Esattamente la ricetta che viene riproposta senza alcun stravolgimento anche in questo nuovo lavoro. Per contro i detrattori (e ce ne sono parecchi) continueranno a trovarlo stucchevole, pesante, e, in soldoni, mortalmente noioso e sempre uguale a sé stesso, visto che anche le nuove piccole gemme sparse in questo album (la lunga title-track ad esempio, o le bellissime Brown Suits And Cadillacs e Been Up So Long) insistono nel piagnucolare più che raccontare storie di border-heroes da letteratura americana d'ordinanza senza darsi troppa pena nel cercare nuove strade da battere.
Prendere o lasciare per ora dunque, Joe Purdy continua ad essere il nuovo poeta minore che tratta la materia tradizionale country/folk con quello spleen da malinconico indi-folker moderno che è tanto di moda, compresa la barba d'ordinanza alla Bonnie Prince Billy/Ray Lamontagne/Sam Bean/ecc/ecc/…Al di sopra di queste considerazioni, volte forse a voler avvertire lo stesso artista che da qui in poi o si cambia registro, o difficilmente riuscirà a non ammorbarci o perlomeno a sorprendere ancora, resta anche il fatto che Last Clock On The Wall palesa e conferma sia un indubbio talento nel scrivere ottime sad-songs per nottate insonni, sia una scarsa fantasia nel trovare lo sviluppo vincente in ogni occasione (soprattutto nella faticosa sequenza centrale Dead End Kids, Dress Is Too Long e Miss Me, che vanta pure un giro rubacchiato a Mr Bojangles di Jerry Jeff Walker).
Lo spessore resta alto, come nell'apertura di Let Me Sing To You e nel finale affidato a Too Young, produzione e suoni sono di primo livello, così come la sua autoindulgenza nel non limitare mai i tempi e nel non cercare mai il brano più brioso che spezzi tensione e incantesimo, come usava fare anche Jackson Browne nei suoi dischi più epici e crepuscolari. Tanti difetti per un disco maturo che suona molto bene e riesce comunque ad emozionare ed incuriosire: davvero non vorremmo essere nei panni di Joe Purdy quando entrerà di nuovo in studio di registrazione e dovrà affrontarli una volta per tutte.
(Nicola Gervasini)