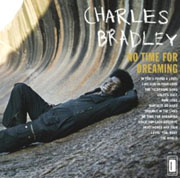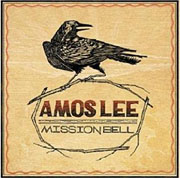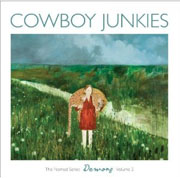Ecco alcune mie piccole schede su album indimenticabili degli anni 70, parte dello speciale pubblicato da Rootshighway
http://www.rootshighway.it/speciali/speciale_70/100.htm
Bonnie Raitt - Give It Up
Nel 1971 che una donna bianca potesse fare dischi di blues, osando pure accollarsi gli assoli di chitarra, era cosa decisamente inusuale. Abituati alle blues-singers manipolate da altri autori e case discografiche, il mondo del rock americano inizialmente non seppe bene come inquadrare Bonnie Raitt, una timida ragazzina dalla voce esile ma decisa, che dopo un esordio già convincente e maturo, infilò con Give It Up l’opera della vita. Dedicate ai Vietcong in pieno climax della guerra del Vietnam, queste canzoni non erano solo blues, erano un viaggio da New Orleans alla West Coast visto per la prima volta al femminile, dove anime lontane come Jackson Browne (Under Falling Sky) Chris Smither (Love Me Like A Man, divenuta un classico) e la sua slow-songs più bella di sempre (Nothing Seems To Matter) convivevano perfettamente. (NG)
Byrds - Untitled
Eliminate tutte le più grandi eminenze grigie passate sotto la sigla Byrds (Crosby, Clark, Parsons), Roger McGuinn traghettò la seconda parte della storia del gruppo nelle acque placide e sicure del nuovo country-rock, tra le accuse di essere il primo reazionario rock o di essersi piegato a mere logiche di mercato. Oggi sappiamo quanto invece il suo progetto fosse sinceramente votato ad una ricerca musicale, e i frutti sono ancora oggi tutt’altro che trascurabili, sebbene privi della portata innovativa della prima era Byrds. Equamente diviso tra un disco live che rileggeva il passato attraverso la chitarra di Clarence White e uno in studio con nuovi classici, Untitled resta il disco che meglio ha rappresentato il passaggio del testimone tra gli anni 60 e i 70. Chiedetelo a Tom Petty perché questo sia stato importante.(NG)
Carole King - Tapestry
Più di dieci anni passati in un palazzo a scrivere classici per altre voci, poi la separazione dal fido co-autore Gerry Goffin, e infine la decisione di provarci da sola. La proverbiale timidezza di Carole King trovò nel suo secondo disco la propria sublimazione, finendo per creare la matrice di ogni disco di pop femminile che si rispetti. Immerso molto più nel nuovo folk della West Coast che nel pop-soul da cui molti di questi brani provenivano, Tapestry è l’icona della perfezione melodica degli anni 70. Diviso tra brani già noti e nuovi classici (su tutte It’s Too Late e You’ve Got A Friend), è stato forse l’ultimo anello di congiunzione tra musica d’autore e musica commerciale, tanto che qui potete trovare le radici sia di Christina Aguilera (che plagerà di fatto Beautiful) come di Natalie Merchant. (NG)
Delbert McClinton - Second Wind
Quando si nasce a Lubbock, nel Texas, si finisce inevitabilmente al centro di tutti i più importanti vortici musicali americani, ma per Delbert McClinton la strada per metabolizzarli è stata lunga. Second Wind era il suo sesto disco, arrivato nel 1978 dopo un’attività iniziata nel 1962, ma che solo con l’approdo alla Capricorn del mentore del southern-rock Johnny Sandlin poté dirsi arrivata a piena maturazione. Blues, rock, soul, il Texas, brani di Jesse Winchester, Taj Mahal, Willie Dixon e Johnny Cash messi vicini come se nascessero dalle medesime matrici stilistiche, e quella sua “B” Movie che diventerà un piccolo classico grazie alla versione dei Blues Brothers: Second Wind rappresenta il perfetto melting pot della musica americana di fine anni settanta (NG)
Doobie Brothers - The Captain And Me
Tom Johnston aveva un sogno: riuscire a creare il perfetto mix tra il blues del delta, il country rock degli esordi, e un certo rock da arena, come se qualità e vendibilità potessero davvero andare di pari passo. Per l’arco di un paio di dischi ci riuscì veramente, e The Captain And Me rasenta ancora oggi una perfezione formale e di sostanza difficilmente riscontrabile in altri dischi del periodo. C’erano i singoli per le charts (Long Train Running, la classica canzone che tutti conoscono senza ricordarsene titolo e autore), riff perfetti per iniziare una trasmissione radio (China Grove), orge di chitarre, perfette country-ballads alla Eagles, blues-rock, cajun del Delta, e persino uno dei primi sintetizzatori usati a livello professionale. Il sogno durò ancora due dischi, poi la sigla Doobie Brothers venne conquistata dal nemico. (NG)
Hot Tuna – Burgers
Mentre Marty Balin, Paul Kantner e Grace Slick nei Jefferson Airplane passavano il tempo a fare proclami di amore hippy e a decantare viaggi lisergici, Jorma Kaukonen e il bassista Jack Cassidy non avevano mai smesso di perdersi nei meandri di noiose partiture di blues acustico del Reverendo Gary Davis. La differenza fu evidente quando le strade si separarono, e gli Hot Tuna attraversarono gli anni settanta passando dal blues acustico a quello elettrico con risultati alterni e, viste le aspettative, anche deludenti. Ma Burgers resta l’opera del perfetto equilibrio tra le due anime, con Kaukonen a suo agio sia come rocker che come bluesman, e una serie di brani che funzionavano alla radio così come sulla strada dove erano nati, e dove rimarranno nello spirito.(NG)
Joni Mitchell – Blue
Non era facile nel 1971 per una donna riuscire a raccontare tutta la propria fragilità e debolezza in amore con piena libertà espressiva, soprattutto nel sessista mondo rock. Eppure Blue rivelò le tribolazioni amorose di una Joni Mitchell rimbalzata tra mille uomini, seguiti, riveriti e abbandonati a causa di un’inquietudine di vivere incomprensibile per le corde emotive maschili. Blue resta il “disco femmina” per antonomasia, perché privo di ogni machismo anche nell’utilizzo di un folk pianistico delicato e non ancora debordante verso il jazz che sarà nei dischi successivi. E’ qui che vorrebbe arrivare il 99% delle cantautrici moderne, ed è qui che hanno provato a finire anche molti colleghi maschi, primo tra tutti il Dylan a cuore aperto di Blood On The Tracks, che a queste canzoni deve tantissimo.(NG)
Little Feat – Sailin’ Shoes
I Little Feat sono rimasti la live-band perfetta anche dopo la sua dipartita, ma finché ha avuto la giusta lucidità, Lowell George è stato il vero genio del gruppo. Sailin Shoes è il suo personale capolavoro a base di country-rock distorto (Texas Rose Cafe), riffoni da cantina (Easy To Slip, Teenage Nervous Breakdown), blues irriverenti (A Apolitical Blues) e roots-music vituperata (Sailin’ Shoes). Il sound tutto New Orleans, che diventerà il loro marchio di fabbrica con il successivo Dixie Chicken, arriva non a caso solo dagli unici due brani scritti da Bill Payne, per il resto la band qui si limita seguire i suoi schizzi di follia, da sempre dipinti dalle bizzarre copertine di Neon Park. E Willin’, tanto necessaria da essere un bis di un brano già apparso sul primo album, resta la truck-ballad più bella degli anni 70. (NG)
Manassas - Manassas
Non è stata solo una questione di alcool e droghe, la morte creativa di Stephen Stills è secondo molti il frutto di una rancorosa invidia verso i colleghi, Neil Young in primis. A determinarla fu anche il fatto che la sua idea di country-rock globale della West Coast, da sempre aperto a influenze caraibiche, rock, blues, e pure qualche sperimentazione progressiva, ha trovato nel primo disco licenziato come Manassas la sua apoteosi artistica, ma non abbastanza elogi. Il titolo infatti resta un cult-record, a cui è mancato forse il singolo epocale per restare nella memoria collettiva come il doppio album più rappresentativo del sound degli anni 70. Dopo quest’avventura (che produrrà un successivo capitolo sempre di buon livello), Stills smetterà di pensare grande rock e diventerà prematuramente vecchio.(NG)
Paul Pena – New Train
Commettiamo un falso storico a inserire questo disco nei top 100 degli anni 70, ma il nostro senso di giustizia ci obbliga a vendicare un torto senza precedenti. New Train infatti è un disco del 1973, uscito però sono nel 2000. Proviamo quindi solo ad immaginare l’impatto che avrebbe potuto avere questo perfetto crocevia tra black music e cantautorato bianco della West Coast (immaginate un disco di Jimi Hendrix prodotto da Jackson Browne), l’ipotetico bigino su cui avrebbero potuto studiare molti artisti moderni abituati a navigare trasversalmente, come Ben Harper o anche il Ray LaMontagne più recente. Neppure il fatto che Jet Airliner divenne poi un successo nelle mani della Steve Miller Band (grazie al loro tastierista Ben Sidran, che qui produceva), fece venir voglia alla Bearsville Records di pubblicarlo. (NG)