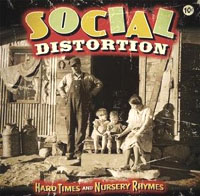Autori Vari
…Next Stop is Vietnam 1961-2008
[Bear Family - Box 13CD 2010]


Il Vietnam, la guerra nel Vietnam, intesa come un unico immaginario, costruito e diramatosi nel conflitto e allargatosi fino a stravolgere la natura stessa dello spirito americano, del "destino manifesto", piuttosto che dei miti della frontiera è il nucleo originario da snocciolare se si vuole capire tutta l'evoluzione di una cultura (americana, e non solo; dell'informazione, e non solo) da allora a oggi. E' qui che …Next Stop is Vietnam 1961-2008, poderoso cofanetto della Bear Family, centra il bersaglio: parte, sì, dalla musica (sentita, prodotta o riferita a quegli eventi storici) ma si allarga a ricostruire tutta l'iconografia della guerra del Vietnam. Lo spettro comprende anche i discorsi ufficiali (in brevi e significative sintesi, per fortuna), riviste (dell'esercito e contro), locandine cinematografiche, memorabilia d'autore e paccotiglia propagandistica. Tutto nella prima metà cartacea (elegantissima, accurata), mentre in quella digitale (13 dischi) c'è tutta la storia attraverso le canzoni, da Masters Of War di Bob Dylan a Galvenston Bay di Bruce Sprigsteen (giusto per citarne un paio).
In una delle numerose note, Samuel G. Fredman scrive che il Vietnam "è stata la prima guerra ad avere una colonna sonora rock'n'roll". Il punto di vista è persino riduttivo: la cronaca del conflitto associando televisione e rock'n'roll diventò un incubo lungo dieci anni, e mai dimenticato, come racconta con una certa eloquenza …Next Stop is Vietnam 1961-2008 perché tutto era destinato a diventare un simbolo, un linguaggio, un luogo comune. Dai nomi delle operazioni militari (Rolling Thunder, solo per ricordare la più esplicita) a Bob Hope sui palchi delle forze speciali, dagli Zippo (esiste un bellissimo libro, molto pop, dedicato alla vita degli accendini nelle zone di guerra) ai graffiti sugli elmetti, per non parlare poi della creatività, abbastanza nota, del movimento contro la guerra.
Tutto quello che c'è da sentire, qui dentro risponde all'appello (manca Ohio di Neil Young, ma i curatori si scusano per non essere riusciti a ottenere i diritti, e questa la dice lunga sulla loro dedizione). Da leggere c'è solo l'imbarazzo della scelta, anche se un'occhiata a Rolling Vietnam è sempre obbligatoria. Da vedere, per capire cos'è stato il Vietnam e cos'è la guerra, basta Apocalypse Now. Lo spirito con cui è stato assemblato …Next Stop is Vietnam 1961-2008 è quello. Un oggetto "culturale" di rilevanza indiscutibile e anche una pietra miliare nelle produzioni discografiche degli ultimi anni.
(Marco Denti)
Tutti i dettagli di …Next Stop is Vietnam 1961-2008:
www.bear-family.de
Saigon State Of Mind
(a cura di Nicola Gervasini)
 Una milanese di origini vietnamite mi raccontava che l'impressione che si ha viaggiando per il Vietnam nei giorni nostri è che tutto ciò che riguarda la guerra con gli americani sia stato in qualche modo cancellato e rimosso. La popolazione è oggi anagraficamente molto giovane, e nessuno pare aver voglia di guardarsi alle spalle. Anche perché - secondo lei - la vera guerra che nessuno ha voglia di riesumare non è stata quella con gli yankee invasori, quanto quella fratricida tra nord e sud, che ha vissuto proprio nel momento della dipartita degli americani il momento più tragico e truce, quando venne il tempo delle vendette personali e dei conti da saldare. Nella cultura statunitense invece la parola Vietnam continua a risvegliare sempre nuovi fantasmi. La ferita è talmente aperta, che un cofanetto di canzoni dedicate ad un avvenimento storico ufficialmente concluso nel 1975 può permettersi di spingersi fino al 2008 nel trovare nuove testimonianze in musica. Ed è solo perché bisognava trovare un limite che si sono fermati, perché poi a ben guardare qualsiasi canzone sulla guerra scritta in America negli ultimi quarant'anni, pensa a quella guerra. Willie Nile ad esempio ha confessato che il brano Now That The War Is Over, contenuto nel suo House Of Thousand Guitars del 2009, è stato scritto con il pensiero agli anni 70 e a quel conflitto, ma all'ultimo momento ha sostituito la parola "Vietnam" con "Pakistan" per renderlo più attuale. Scrupolo inutile probabilmente, perché poi a ben guardare di canzoni che pensano al Vietnam continuano ad uscirne più che di ogni altro scenario bellico odierno, forse perché è ancora presto per misurare l'impatto che gli avvenimenti più recenti hanno avuto sulla nostra vita, come invece ha potuto fare il Tom Russell di East Of Woodstock, West Of Viet Nam (brano del recente album Blood and Candle Smoke), in cui il vecchio cantastorie ricorda gli anni della perdita del suo "cuore adolescente" legandoli proprio a quegli avvenimenti. Ma non sono solo i rocker anziani a ragionare sempre in termini di Vietnam: Elvis Perkins nella sua Emile's Vietnam In The Sky(era su Ash Wednesday del 2007) si spinge a citare una frase di sua madre ("sai dove si va quando si muore?") pronunciata dalla sfortunata pochi giorni prima di morire davvero su uno degli aerei dell'11 settembre 2001, ma la immerge storicamente nella cupa atmosfera del Vietnam del periodo coloniale e della guerra di Indocina. E proprio la tragedia delle Torri Gemelle ha evidenziato quanto la guerra del Vietnam sia stata la vera svolta cruciale nella storia americana, perché invece di sostituirsi come shock culturale preponderante, ne ha rianimato l'interesse e le citazioni, come se anche il lutto nazionale dell'11 settembre potesse essere elaborato solo ripercorrendo il sentiero di Ho Chi Minh ancora un volta. Per dirla come l'avrebbe detta Billy Joel dunque, il Vietnam è uno stato della mente, neanche più un fatto storico. Di libri e cofanetti che raccontano come il rock e il Vietnam vivano sempre in perfetta simbiosi potremo leggerne ed ascoltarne ancora a lungo, forse fino a quando un'altra potenza egemone, un'altra cultura dominante, o un altro tipo di arte pregna della fresca carica comunicativa che fu del rock di quarant'anni fa, non troveranno un loro Vietnam.
Una milanese di origini vietnamite mi raccontava che l'impressione che si ha viaggiando per il Vietnam nei giorni nostri è che tutto ciò che riguarda la guerra con gli americani sia stato in qualche modo cancellato e rimosso. La popolazione è oggi anagraficamente molto giovane, e nessuno pare aver voglia di guardarsi alle spalle. Anche perché - secondo lei - la vera guerra che nessuno ha voglia di riesumare non è stata quella con gli yankee invasori, quanto quella fratricida tra nord e sud, che ha vissuto proprio nel momento della dipartita degli americani il momento più tragico e truce, quando venne il tempo delle vendette personali e dei conti da saldare. Nella cultura statunitense invece la parola Vietnam continua a risvegliare sempre nuovi fantasmi. La ferita è talmente aperta, che un cofanetto di canzoni dedicate ad un avvenimento storico ufficialmente concluso nel 1975 può permettersi di spingersi fino al 2008 nel trovare nuove testimonianze in musica. Ed è solo perché bisognava trovare un limite che si sono fermati, perché poi a ben guardare qualsiasi canzone sulla guerra scritta in America negli ultimi quarant'anni, pensa a quella guerra. Willie Nile ad esempio ha confessato che il brano Now That The War Is Over, contenuto nel suo House Of Thousand Guitars del 2009, è stato scritto con il pensiero agli anni 70 e a quel conflitto, ma all'ultimo momento ha sostituito la parola "Vietnam" con "Pakistan" per renderlo più attuale. Scrupolo inutile probabilmente, perché poi a ben guardare di canzoni che pensano al Vietnam continuano ad uscirne più che di ogni altro scenario bellico odierno, forse perché è ancora presto per misurare l'impatto che gli avvenimenti più recenti hanno avuto sulla nostra vita, come invece ha potuto fare il Tom Russell di East Of Woodstock, West Of Viet Nam (brano del recente album Blood and Candle Smoke), in cui il vecchio cantastorie ricorda gli anni della perdita del suo "cuore adolescente" legandoli proprio a quegli avvenimenti. Ma non sono solo i rocker anziani a ragionare sempre in termini di Vietnam: Elvis Perkins nella sua Emile's Vietnam In The Sky(era su Ash Wednesday del 2007) si spinge a citare una frase di sua madre ("sai dove si va quando si muore?") pronunciata dalla sfortunata pochi giorni prima di morire davvero su uno degli aerei dell'11 settembre 2001, ma la immerge storicamente nella cupa atmosfera del Vietnam del periodo coloniale e della guerra di Indocina. E proprio la tragedia delle Torri Gemelle ha evidenziato quanto la guerra del Vietnam sia stata la vera svolta cruciale nella storia americana, perché invece di sostituirsi come shock culturale preponderante, ne ha rianimato l'interesse e le citazioni, come se anche il lutto nazionale dell'11 settembre potesse essere elaborato solo ripercorrendo il sentiero di Ho Chi Minh ancora un volta. Per dirla come l'avrebbe detta Billy Joel dunque, il Vietnam è uno stato della mente, neanche più un fatto storico. Di libri e cofanetti che raccontano come il rock e il Vietnam vivano sempre in perfetta simbiosi potremo leggerne ed ascoltarne ancora a lungo, forse fino a quando un'altra potenza egemone, un'altra cultura dominante, o un altro tipo di arte pregna della fresca carica comunicativa che fu del rock di quarant'anni fa, non troveranno un loro Vietnam.
Nicola Gervasini - Rolling Vietnam. Radiografia di una guerra (Pacini editore)
Lo speciale su Rolling Vietnam:
www.rootshighway.it/rolling.htm
compralo dall'autore
scrivi a n.gervasini@tin.it e richiedi la copia autografata senza spese di spedizione aggiunte!







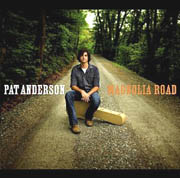

 Una milanese di origini vietnamite mi raccontava che l'impressione che si ha viaggiando per il Vietnam nei giorni nostri è che tutto ciò che riguarda la guerra con gli americani sia stato in qualche modo cancellato e rimosso. La popolazione è oggi anagraficamente molto giovane, e nessuno pare aver voglia di guardarsi alle spalle. Anche perché - secondo lei - la vera guerra che nessuno ha voglia di riesumare non è stata quella con gli yankee invasori, quanto quella fratricida tra nord e sud, che ha vissuto proprio nel momento della dipartita degli americani il momento più tragico e truce, quando venne il tempo delle vendette personali e dei conti da saldare. Nella cultura statunitense invece la parola Vietnam continua a risvegliare sempre nuovi fantasmi. La ferita è talmente aperta, che un cofanetto di canzoni dedicate ad un avvenimento storico ufficialmente concluso nel 1975 può permettersi di spingersi fino al 2008 nel trovare nuove testimonianze in musica. Ed è solo perché bisognava trovare un limite che si sono fermati, perché poi a ben guardare qualsiasi canzone sulla guerra scritta in America negli ultimi quarant'anni, pensa a quella guerra. Willie Nile ad esempio ha confessato che il brano Now That The War Is Over, contenuto nel suo House Of Thousand Guitars del 2009, è stato scritto con il pensiero agli anni 70 e a quel conflitto, ma all'ultimo momento ha sostituito la parola "Vietnam" con "Pakistan" per renderlo più attuale. Scrupolo inutile probabilmente, perché poi a ben guardare di canzoni che pensano al Vietnam continuano ad uscirne più che di ogni altro scenario bellico odierno, forse perché è ancora presto per misurare l'impatto che gli avvenimenti più recenti hanno avuto sulla nostra vita, come invece ha potuto fare il Tom Russell di East Of Woodstock, West Of Viet Nam (brano del recente album Blood and Candle Smoke), in cui il vecchio cantastorie ricorda gli anni della perdita del suo "cuore adolescente" legandoli proprio a quegli avvenimenti. Ma non sono solo i rocker anziani a ragionare sempre in termini di Vietnam: Elvis Perkins nella sua Emile's Vietnam In The Sky(era su Ash Wednesday del 2007) si spinge a citare una frase di sua madre ("sai dove si va quando si muore?") pronunciata dalla sfortunata pochi giorni prima di morire davvero su uno degli aerei dell'11 settembre 2001, ma la immerge storicamente nella cupa atmosfera del Vietnam del periodo coloniale e della guerra di Indocina. E proprio la tragedia delle Torri Gemelle ha evidenziato quanto la guerra del Vietnam sia stata la vera svolta cruciale nella storia americana, perché invece di sostituirsi come shock culturale preponderante, ne ha rianimato l'interesse e le citazioni, come se anche il lutto nazionale dell'11 settembre potesse essere elaborato solo ripercorrendo il sentiero di Ho Chi Minh ancora un volta. Per dirla come l'avrebbe detta Billy Joel dunque, il Vietnam è uno stato della mente, neanche più un fatto storico. Di libri e cofanetti che raccontano come il rock e il Vietnam vivano sempre in perfetta simbiosi potremo leggerne ed ascoltarne ancora a lungo, forse fino a quando un'altra potenza egemone, un'altra cultura dominante, o un altro tipo di arte pregna della fresca carica comunicativa che fu del rock di quarant'anni fa, non troveranno un loro Vietnam.
Una milanese di origini vietnamite mi raccontava che l'impressione che si ha viaggiando per il Vietnam nei giorni nostri è che tutto ciò che riguarda la guerra con gli americani sia stato in qualche modo cancellato e rimosso. La popolazione è oggi anagraficamente molto giovane, e nessuno pare aver voglia di guardarsi alle spalle. Anche perché - secondo lei - la vera guerra che nessuno ha voglia di riesumare non è stata quella con gli yankee invasori, quanto quella fratricida tra nord e sud, che ha vissuto proprio nel momento della dipartita degli americani il momento più tragico e truce, quando venne il tempo delle vendette personali e dei conti da saldare. Nella cultura statunitense invece la parola Vietnam continua a risvegliare sempre nuovi fantasmi. La ferita è talmente aperta, che un cofanetto di canzoni dedicate ad un avvenimento storico ufficialmente concluso nel 1975 può permettersi di spingersi fino al 2008 nel trovare nuove testimonianze in musica. Ed è solo perché bisognava trovare un limite che si sono fermati, perché poi a ben guardare qualsiasi canzone sulla guerra scritta in America negli ultimi quarant'anni, pensa a quella guerra. Willie Nile ad esempio ha confessato che il brano Now That The War Is Over, contenuto nel suo House Of Thousand Guitars del 2009, è stato scritto con il pensiero agli anni 70 e a quel conflitto, ma all'ultimo momento ha sostituito la parola "Vietnam" con "Pakistan" per renderlo più attuale. Scrupolo inutile probabilmente, perché poi a ben guardare di canzoni che pensano al Vietnam continuano ad uscirne più che di ogni altro scenario bellico odierno, forse perché è ancora presto per misurare l'impatto che gli avvenimenti più recenti hanno avuto sulla nostra vita, come invece ha potuto fare il Tom Russell di East Of Woodstock, West Of Viet Nam (brano del recente album Blood and Candle Smoke), in cui il vecchio cantastorie ricorda gli anni della perdita del suo "cuore adolescente" legandoli proprio a quegli avvenimenti. Ma non sono solo i rocker anziani a ragionare sempre in termini di Vietnam: Elvis Perkins nella sua Emile's Vietnam In The Sky(era su Ash Wednesday del 2007) si spinge a citare una frase di sua madre ("sai dove si va quando si muore?") pronunciata dalla sfortunata pochi giorni prima di morire davvero su uno degli aerei dell'11 settembre 2001, ma la immerge storicamente nella cupa atmosfera del Vietnam del periodo coloniale e della guerra di Indocina. E proprio la tragedia delle Torri Gemelle ha evidenziato quanto la guerra del Vietnam sia stata la vera svolta cruciale nella storia americana, perché invece di sostituirsi come shock culturale preponderante, ne ha rianimato l'interesse e le citazioni, come se anche il lutto nazionale dell'11 settembre potesse essere elaborato solo ripercorrendo il sentiero di Ho Chi Minh ancora un volta. Per dirla come l'avrebbe detta Billy Joel dunque, il Vietnam è uno stato della mente, neanche più un fatto storico. Di libri e cofanetti che raccontano come il rock e il Vietnam vivano sempre in perfetta simbiosi potremo leggerne ed ascoltarne ancora a lungo, forse fino a quando un'altra potenza egemone, un'altra cultura dominante, o un altro tipo di arte pregna della fresca carica comunicativa che fu del rock di quarant'anni fa, non troveranno un loro Vietnam.