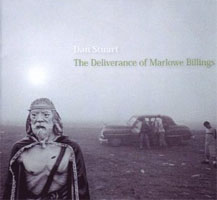PETER BRODERICK
THESE WALLS OF MINE
Erased Tapes/Self
***
Se siete dei
cultori della musica indie europea (“intenditore” è troppo vista la mole di
materiale che circola nel genere) non vi saranno sfuggiti a suo tempo i dischi
degli Efterklang, band danese molto apprezzata anche negli Stati Uniti. Tra i
musicisti che si sono uniti alla loro epopea sia in studio che live c’è anche Peter Broderick, violinista dell’Oregon
trapiantato a Berlino (ha suonato anche con M Ward) che da qualche anno ha
intrapreso anche una nutritissima carriera solista sotto l’egida della Bella
Union, etichetta specializzata nel dare voce agli artisti più originali e
sperimentali dei nostri anni. Ma che nel caso di These Walls Of Mine deve
essersi tirata indietro, se è vero che questa “Esplorazione dal gospel al soul
attraverso il parlato, il rap e il beatboxing” (che, per la cronaca, è
l’imitazione delle percussioni fatta con la voce tipica dei rapper da strada)
esce per le vie ancor più indipendenti della Erased Tapes. Un esperimento folle
in effetti questo album, tanto da apparire persino affascinante e curiosamente
ascoltabile. Come recitano le note di copertina: “non ho ancora deciso de These
Walls Of Mine è genio o solo sregolatezza. Mi sconvolge alquanto, ma è anche
maledettamente piacevole” . Registrato praticamente in solitaria nel corso di
tre anni di tournee tra Copenahghen e Berlino, i dieci brani che lo compongono
hanno la particolarità di avere testi di varia provenienza della vita di tutti
i giorni, come ad esempio quelli di Freyr!
o I Do This, dove Broderick si limita
a recitare/cantare le parole di alcune email su basi folk. La vita quotidiana
entra nella musica, come un unico social network, o per dirla con le parole di
una delle mail recitate, “Ascoltare una canzone è come caricare una foto su
Flickr, scegliersi una maglietta per uscire, parlare con qualcuno, guardarlo”.
L’arte diventa il nostro quotidiano, roba da fare orrore a chiunque si sia
detto “artista” con la A maiuscola nel novecento, ma che oggi appare quantomai attuale
in un era in cui davvero ascoltare musica non è più considerato un fatto
straordinario. E forse questo album, pieno di provocazioni ma anche di buone
canzoni (la title track ad esempio), potrebbe essere ricordato come un
precursore di una nuova via di fare musica dalla propria camera, con il proprio
pc. E, fortunatamente, ancora con i propri strumenti musicali.
Nicola Gervasini





 Robert
Plant & The Band Of Joy
Robert
Plant & The Band Of Joy