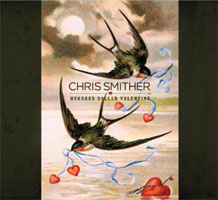 | Chris Smither Hundred Dollar Valentine [Signature sounds 2012] www.smither.com di Nicola Gervasini (09/07/2012) |  | |
Ci sono angoli di mondo che restano immuni a qualsiasi crisi economica, guerra, moda o rivoluzione sociale. Quegli angoli si chiamano songwriters, quelli che magari da anni girano il mondo cantando imperterriti le proprie canzoni a piccole platee, producendo dischi perlopiù dimenticati e persi nei meandri del mondo degli appassionati. Gente come Chris Smither insomma, più di quarant'anni di carriera senza aver mai lasciato nulla che appaia in un'antologia del rock, e spesso neppure nelle liste dei grandi folk/country singer usciti dal calderone degli anni settanta. D'altronde lui, come ad esempio anche Ray Wylie Hubbard, è stato uno che solo negli anni novanta è riuscito a liberarsi dalla morsa tremenda degli uffici marketing delle majors e avere una produzione regolare. Discografia di tutto rispetto la sua, dove anche cogliendo a caso troverete pane per i vostri denti se ritenete Guy Clark (per dirne uno molto simile per stile e timbro di voce) un vostro mito personale.
Normalmente ci si riferisce ad Up On The Lowdown del 1995 come al disco della sua rinascita e dunque quello più consigliato, ma il livello non è mai sceso neanche in questi anni 2000, e non fa eccezione questo Hundred Dollar Valentine, che ha la particolarità di essere il suo primo album senza cover o reinterpretazioni di vecchi brani. D'altronde lo Smither autore cammina da tempo con le proprie gambe, e non è difficile pensare che qualche grande country-singer possa avere voglia di rileggere brani come la splendida On The Edge o la sofficeWhat They Say, titoli che si prestano anche a sofisticati ed elaborati arrangiamenti country-pop volendo. Ma lo Smither performer invece continua ad amare il suono scarno della sua acustica, a cantare come se stesse usando l'ultimo filo di voce rimasto, a toccare spesso e volentieri tonalità blues (I Feel The Same). Ma alla fine è nelle delicate ballate che il nostro riesce sempre a dare il meglio, quando duetta con Anita Suhanin nel country leggiadro di Place In Line o quando si copre con la bella sezione d'archi di Feeling By Degrees.
Sta proprio nella sua versatilità il grande pregio di Hundred Dollar Valentine, che appare subito come uno dei suoi lavori più curati in sede di arrangiamento, e qui bisogna ringraziare il produttore David "Goody" Goodrich(già visto in azione con Jeffrey Foucault), uno che non ha colpi di genio ma solo il grande dono di sapere sempre dove intervenire. Decisivo anche l'apporto di ottimi musicisti come il batterista Billy Conway e l'armonicista Jimmy Fitting, vale a dire metà dei Treat Her Right che furono (e dei Morphine che poi diventeranno sostituendo Fitting con un sassofonista), oppure del violista Ian Kennedy (sentito con Robert Plant e Susan Tedeschi). Siamo alle solite in ogni caso, Smither non fa mai gridare al miracolo e mantiene sempre quel tono dimesso che tiene al riparo chiunque da facili esaltazioni. Eppure mai come in questo caso lo senti necessario per certi momenti della vita.
Normalmente ci si riferisce ad Up On The Lowdown del 1995 come al disco della sua rinascita e dunque quello più consigliato, ma il livello non è mai sceso neanche in questi anni 2000, e non fa eccezione questo Hundred Dollar Valentine, che ha la particolarità di essere il suo primo album senza cover o reinterpretazioni di vecchi brani. D'altronde lo Smither autore cammina da tempo con le proprie gambe, e non è difficile pensare che qualche grande country-singer possa avere voglia di rileggere brani come la splendida On The Edge o la sofficeWhat They Say, titoli che si prestano anche a sofisticati ed elaborati arrangiamenti country-pop volendo. Ma lo Smither performer invece continua ad amare il suono scarno della sua acustica, a cantare come se stesse usando l'ultimo filo di voce rimasto, a toccare spesso e volentieri tonalità blues (I Feel The Same). Ma alla fine è nelle delicate ballate che il nostro riesce sempre a dare il meglio, quando duetta con Anita Suhanin nel country leggiadro di Place In Line o quando si copre con la bella sezione d'archi di Feeling By Degrees.
Sta proprio nella sua versatilità il grande pregio di Hundred Dollar Valentine, che appare subito come uno dei suoi lavori più curati in sede di arrangiamento, e qui bisogna ringraziare il produttore David "Goody" Goodrich(già visto in azione con Jeffrey Foucault), uno che non ha colpi di genio ma solo il grande dono di sapere sempre dove intervenire. Decisivo anche l'apporto di ottimi musicisti come il batterista Billy Conway e l'armonicista Jimmy Fitting, vale a dire metà dei Treat Her Right che furono (e dei Morphine che poi diventeranno sostituendo Fitting con un sassofonista), oppure del violista Ian Kennedy (sentito con Robert Plant e Susan Tedeschi). Siamo alle solite in ogni caso, Smither non fa mai gridare al miracolo e mantiene sempre quel tono dimesso che tiene al riparo chiunque da facili esaltazioni. Eppure mai come in questo caso lo senti necessario per certi momenti della vita.




