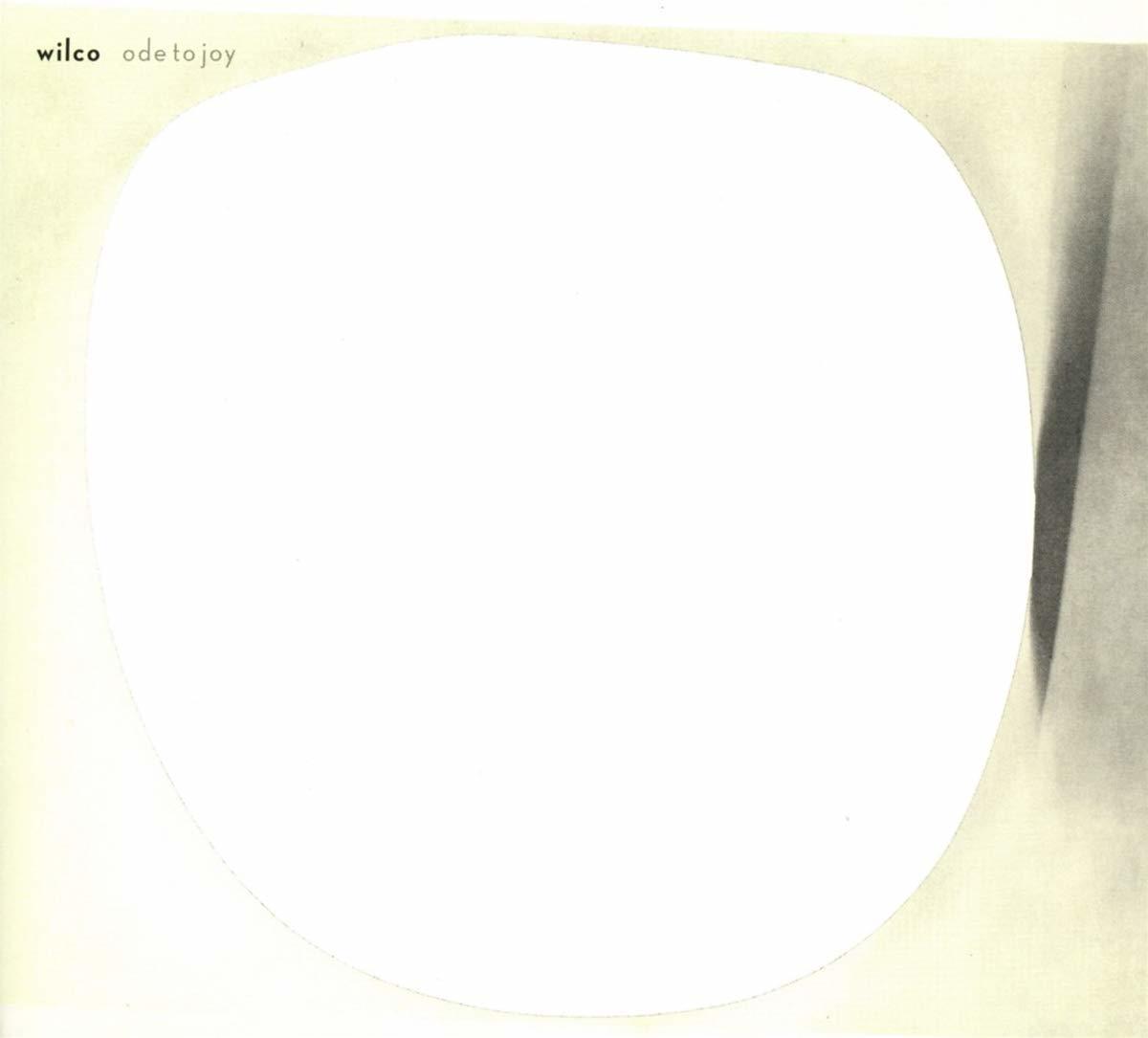Beck (e la musica dei 90s) alla soglia dei 50.
Ho sempre pensato a Beck come ad un Todd Rundgren della seconda era del classic rock. Non più giovanissimo neanche lui (l’anno prossimo compirà 50 anni), Beck David Campbell (questo il suo vero nome) è stato una figura fondamentale negli anni 90, in quella era di sintesi tra i vari stili che fino a quel momento avevano animato il circo del rock su binari separati. Nelle sue canzoni, nate spesso in ore di prove e studi nel chiuso di una sala di registrazione, si trovava di tutto e tutto perfettamente (e spesso per la prima volta) amalgamato, esattamente come Todd Rundgren negli anni 70 produsse artisti stilisticamente agli antipodi, dimostrando come un perfetto lavoro di sala potesse portare chiunque ad un unico ottimo risultato, addirittura magari riuscendo a riprodurre perfettamente i classici come spesso si divertiva a fare in alcuni suoi dischi.

Capitol – 2019
E se Rundgren dagli anni 90 ad oggi si è chiuso in una produzione lontana dai riflettori e dalla scena musicale moderna, perseguendo la sua idea di rock come prodotto di un lungo processo in cui tecnica e creatività vanno a braccetto, Beck, dopo aver ricordato quanto bravo ancora sia a scrivere anche solo semplici canzoni con Morning Phase del 2014 (una sorta di capitolo secondo di Sea Change del 2002), da Colors del 2017 è entrato definitivamente in una fase di sperimentazione stilistica.
Beck – Hyperspace: un vuoto esercizio di stile?
Lunga premessa per dire che Hyperspace, come già il suo predecessore, suona fin dal primo ascolto come un mero esercizio di stile, in cui il nostro vuole dimostrare di maneggiare una materia (chiamiamolo pop elettronico, ma mai come per lui le definizioni stilistiche sono sempre imprecise) che non è esattamente quella di cui si occupa abitualmente. Teoricamente non un problema per uno che in album come lo scanzonato Midnite Vultures o Modern Guilt aveva dimostrato di poter vestire le proprie canzoni con abiti differenti senza perdere credibilità ed efficacia, se non fosse che stavolta però qualcosa non funziona bene, e purtroppo i difetti che già aveva Colors, album che abbiamo un po’ tutti dimenticato presto due anni dopo l’iniziale sorpresa, qui si ingigantiscono.
I collaboratori di Beck in Hyperspace
E il problema non è che sia stata sbagliata l’idea di collaborare con giganti della produzione pop come Pharrell Williams (il Todd Rundgren della terza era del pop? Qui apro un sondaggio perché lui di concorrenza ne ha tanta) o Paul Epworth (l’uomo nell’ombra di Adele), Cole M.G.N. (ingegnere del suono richiestissimo nel mondo alternativo, da Julia Holter a Charlotte Gainsbourg) e Greg Kurstin (produttore molto attivo, ma non so se qualcuno si ricorda dei suoi Geggy Tah negli anni 90, sorta di Talking Heads in salsa roots scoperti da David Byrne).
Per la prima volta Beck suona datato
Il problema è che il risultato non è buono né per il mondo del pop a cui guarda con ammirazione, né per il suo mondo, che davanti a certi suoni, arrangiamenti e canzonette, deve fare uno sforzo di benevolenza. In altre parole, Hyperspace fa lo stesso effetto di quando nelle discoteche per ventenni vedi i cinquantenni in jeans rossi e camicia aperta che cercano di stare al passo dei balli ma tradiscono inesorabilmente il loro essere di un’altra generazione.
Insomma, se Colors in fondo presentava un “pop alla Beck” forse non proprio memorabile, ma del tutto coerente con il suo stile, Hyperspace gioca su terreni dove Beck dimostra di non essere maestro, semmai allievo, e per uno che ad ogni disco ha sempre insegnato qualcosa a qualcuno, suona forse come il peggiore degli insulti. Poi fortunatamente è Beck e non un pivello, per cui dette le magagne, giusto ricordare che anche qui comunque c’è da divertirsi e che i dischi “brutti” sono ben altri. Ma è Beck, e da lui è giusto aspettarsi di più, e che sia lui ad insegnare a Pharrell Williams come fare grande musica, e non viceversa.