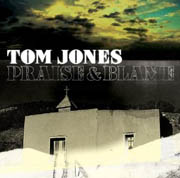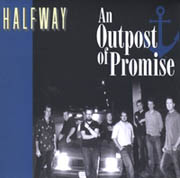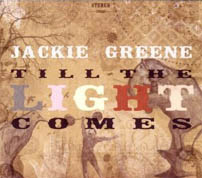Il mondo delle produzioni indipendenti è servito anche a riaprire gli occhi su quanti ragazzi negli USA ancora vivono vagabondando come gli hippie d'un tempo, vuoi perché portano in giro la loro musica, vuoi perché dopo gli anni 70 ci si è dimenticati di questo popolo che vive perennemente fuori dal mondo e on the road. I Delta Spirit vivono in questo limbo giovanile da tempo, si sono affacciati al mondo nel 2006 con un EP e nel 2008 con il primo album (Ode To Sunshine…e già se non è un titolo da flower power questo…), vengono da San Diego ma potevano arrivare dalla Luna che sarebbe stato lo stesso. History From Belowè il loro secondo disco, e nasce da tutto il genuino stupore di chi si affaccia sul mondo reale e scopre all'improvviso che i potenti sono cattivi mentre le "storie dal basso" del titolo parlano di povera gente e buoni sentimenti. Così come il brano che apre il disco (9/11) nasce dalla presa di coscienza di come accadono cose come quelle di quel maledetto 11 settembre e il testo è un'unica lunga domanda "perché accade?", tipica di chi in cuor suo sente che non troverebbe alcuna umana ragione per giustificare tanto orrore, ma si rende conto che per alcuni (troppi) non è davvero così.
Ci sarebbe da sorridere beffardi per i testi del leader Matthew Vasquez, perché sembra davvero di leggere certi proclami umanitari alla Jefferson Airplane, in ritardo di quasi 40 anni, ma poi alla fine ti rendi conto che tutto nasce da una tradizione folk che i Delta Spirit sembrano in grado di tramandare e rinnovare con grande capacità, anche se ancora troppa poca esperienza. Il disco si chiude infatti con la straordinaria Ballad Of Vitality, una lunga intro da folk da Greenwich Village seguita da un esplosione orchestrale, tutto per raccontare la storia (vera e recente) di quel padre russo che ha perso la figlia in un incidente aereo e ha ucciso il controllore di volo svizzero che l'ha causato, una storia dal basso che definisce amaramente la natura umana. Ma è un finale oscuro che serve a rendersi conto che le storie di questo album ci servono ancora, che lo sguardo innocente di questi ragazzi è utile per ricordarci come dovremmo essere, anche se non lo saremo mai, e il bagno purificatore della copertina sembra essere un invito rivolto a tutti più che una semplice foto.
Il tutto ci viene raccontato attraverso un album musicalmente molto studiato (6 mesi di gestazione si sentono) e drammatico (la presenza di Bo Koster dei My Morning Jacket in sede di produzione si sente ancor di più), con momenti di stravolto folk noir alla Felice Brothers (Salt In The Wound, ma ancor più la splendida White Table li ricordano molto), freak-folk alla Okkervil River (Devil Know's You're Dead) o semplice folk e basta (all'orchestrata Randsom Man fa da contraltare la scarna resa di Scarecrow). Definirli è dura, 9/11, Bushwick Blues e Golden State (un giro di piano rubato ai Counting Crows) ad esempio hanno strutture classicissime ma suonano ugualmente moderne, tanto da portarci a dire che se il folk classico ha ancora speranza di poter scandire il ritmo delle nostre coscienze, questa è la via giusta per riuscirci.
(Nicola Gervasini)
deltaspiritbydeltaspirit.blogspot.com
www.myspace.com/deltaspirit