CHIUSO PER LOUTTO
So Long Lou....
domenica 27 ottobre 2013
giovedì 10 ottobre 2013
TRAVIS
TRAVIS
WHERE
YOU STAND
Red Telephone Box / Kobalt Label Services
***
Quando chiami una band con il nome di battesimo del
silenzioso e malinconico protagonista di Paris
Texas di Wim Wenders, hai già segnato la strada da intraprendere. Il Travis
che fu magistralmente interpretato da Harry Dean Stanton era il simbolo della
fuga dalla nuova luccicante modernità degli anni ottanta, lontano dal clamore
di un matrimonio fallito al suono per nulla moderno (per quei tempi) della
slide-guitar di Ry Cooder, mentre i Travis
che tra il 1997e il 1999 raccolsero l’eredità degli Suede, semplificarono gli arzigogoli
mentali dei Radiohead e aprirono la strada a gruppi come Coldplay e Keane, sono
stati uno degli ultimi veri link tra il brit-stardom degli anni novanta e il
nuovo mondo musicale indipendente degli
anni 2000. Decennio quest’ultimo che li ha visti appartarsi sempre più,
fino a scomparire dopo il 2008 e un disco come Ode to J. Smith che fece
incetta di recensioni entusiaste ma evidenziò anche come il loro percorso
avesse ormai perso il contatto con il grande pubblico. Fran Healey d’altronde non è mai stato uomo da grandi riflettori, e
ha anche saggiamente aspettato cinque anni prima di ricomparire con questo Where
You Stand. Che, nonostante l’autoproduzione (esce per un etichetta di
loro proprietà), segue tutti i crismi della divulgazione massiccia, con la
title-track messa in rete già a da maggio e un secondo singolo (Moving) on air prima dell’estate. Sforzo
importante (non ultimo anche le tante edizioni deluxe previste per l’uscita)
per un disco che segna un deciso ritorno alle origini del loro suono. Il solito
malinconico brit-pop, particolarmente levigato nei suoni e nelle melodie, ma
realizzato da una band che ha scritto pagine importanti del genere. La prima
sequenza di canzoni (Mother-Moving-Reminder)
potrebbe essere quella di un loro greatest hits, ed è solo da Warning Sign che cominciano le
variazioni sul tema, ma anche i primi scricchiolii dell’ispirazione. La
sensazione è che Where You Stand sia
un disco pensato per recuperare il tempo perduto e i clamori dei loro esordi,
magari chiedendo giustizia allo spropositato successo dei ben più furbi
Coldplay. Risultato raggiunto in parte, perché se è vero che le stesse Mother o Reminder sono esempi di come la fine-art
of brit pop non possa prescindere dai Travis, è anche vero che la band
spesso scivola in un dèjà vu (anche altrui, si veda Another Guy che pare 1979
degli Smashing Pumkins o Another Room
che recupera senza nasconderlo i Radiohead persi nel tempo) dando alle stampe
il disco che forse sancisce la fine del loro percorso evolutivo e li promuove
al rango di band storica intenta a riproporre sé stessa all’infinito.
Esattamente quello che stanno facendo quasi tutte le altre band storiche in
fondo.
Nicola Gervasini
martedì 8 ottobre 2013
POLLY SCATTERGOOD
POLLY
SCATTERGOOD
ARROWS
(Mute)
***
L’Inghilterra negli ultimi anni pullula di
personaggi come Polly Scattergood:
ragazze nate con il santino di Bjork sul comodino e una lunga serie di muse
rock e pop (da Debbie Harry a PJ Harvey) da cui attingere a seconda
dell’ispirazione. Ventiseienne dell’Essex, Polly Scattergood ha esordito nel
2009 con il disco omonimo che aveva riscosso qualche buona critica (ma non l’unanimità
che spesso ricevono gli esordi inglesi) e l’attenzione verso un personaggio
eccentrico e sicuramente talentuoso. Arrows potrebbe essere il disco della consacrazione
nel mondo indie, e ha un alto potenziale commerciale, che, per quanto conti
ancora qualcosa nel nuovo mercato discografico, potrebbe anche portarle qualche
vendita interessante. Il sound è sempre un mix di elettronica con occhio
puntato sia sulla new wave anni ottanta che sugli ambienti dance del Manchester
Sound. L’inizio fa ben sperare se siete comunque disposti a entrare in un mondo
fatto al 90% di tastiere e suoni campionati: Cocoon apre le danze con lo spirito di Tori Amos nel motore, la
danzereccia Falling riesce in un
colpo solo ad unire il techno-pop dei primi anni ottanta e i Cure, Machines cala il ritmo e pensa agli
esperimenti elettronici di Kate Bush, Disco
Damnaged Kid promette un ballo che non c’è con buon mestiere. Il disco, dopo
una partenza briosa e intelligente, si adagia poi un po’ troppo nella
riproposizione degli schemi appena elencati, finendo ad affogare in un mare di
tastiere anche quando il brano potrebbe sembrare più che stimolante (Colours Colliding). I momenti di valore
ci sono comunque, il singolo Wonderlust (di
cui gira già da tempo un bizzarro video) ha la forza del tormentone
radiofonico, la piano song Miss You è
dotata di una giusta dose di teatralità brechtiana, ma altrove l’album stenta
un po’ a trovare il colpo del KO. Non è comunque escluso che la sua uscita
possa essere salutata da trombe e fanfare dalla stampa musicale inglese, visto
come riescono spesso ad esaltare fenomeni che poi scompaiono nel giro di due anni,
figuriamoci in questo caso dove comunque c’è della discreta carne al fuoco.
L’attendiamo magari sul palco in Italia per verificarne la tenuta anche dal
vivo.
Nicola Gervasini
domenica 6 ottobre 2013
CASE STUDIES
CASE
STUDIES
THIS
IS ANOTHER LIFE
Sacred Bones
***1/2
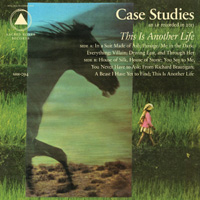 Non è facile dopo più di dieci anni di produzioni
indie depresse e soporifere (al di là dei grandi valori artistici raggiunti da
molti nomi) convincervi ancora ad affrontare un disco come This Is Another Life dei Case
Studies. Ma se avete ancora pazienza e tempo di spegnere le luci e
lasciarvi trascinare da una musica che fa del sussurro, se non proprio del
silenzio, un arte, magari con la stessa devozione che avete dedicato a un disco
dei National o dei Low (per dare subito un paio di coordinate chiare), allora
anche lo slow-core rivisto e corretto da Jesse
Lurtz e soci potrebbe conquistarvi. Lurtz è già noto come la parte maschile
dei The Duchess And The Duke, autori di due album usciti a fine del decennio
scorso fatti di folk sparato ad alta velocità, tanto da trovarli spesso catalogati
addirittura come garage-rock. Ma la Seattle da cui provengono non è più la
stessa dell’era Cobain, e persa la collaboratrice Kimberly Morrison, Lurtz ha generato un nuovo nickname (già
titolari dell’esordio The World Is
Just a Shape to Fill the Night di due anni fa) per affrontare
un’esperienza che si allontana da quanto fatto in precedenza. Folk magari, ma
fortemente tinto di musica inglese o magari con in testa qualcosa vicino al
mondo di Mark Eitzel. In A Suit Made Of
Ash, il brano che apre il disco, fa capire subito l’indirizzo: pianoforte
in evidenza, sezione archi e canto alquanto votato al melodico, e il resto del
disco cambia solo raramente registro, fin dai tesissimi quasi sette minuti di Passage/Me In The Dark. Quando poi
interviene Marissa Nadler nella
ipnotica Villain il sapore è quello
di una versione più acustica dei Walkabouts, mentre se avete amato le atmosfere
malinconiche del John Grant di Queen of Denmark allora magari vi ritroverete a
casa in brani come House of Silk, House
Of Stone o You Say To Me, You Never Have to Ask (quest’ultimo potrebbe
anche richiamare il Bill Fay recentemente riesumato dall’oblio della storia).
Testi interessanti e sufficientemente folli per giustificare l’incedere impregnativo
del disco, con durate anche oltre i sei minuti non facili da reggere al primo
impatto. Il limite sta ovviamente nella voluta monotonia ritmica del tutto,
come se l’artista non chiedesse, ma proprio pretendesse la nostra attenzione
sempre più bombardata da stimoli on-line. Potrebbe avere ragione Lurtz, e
sapere di riuscire ancora ad apprezzare un disco come This is Another Life potrebbe davvero rappresentare la nostra
salvezza dalla modernità.
Non è facile dopo più di dieci anni di produzioni
indie depresse e soporifere (al di là dei grandi valori artistici raggiunti da
molti nomi) convincervi ancora ad affrontare un disco come This Is Another Life dei Case
Studies. Ma se avete ancora pazienza e tempo di spegnere le luci e
lasciarvi trascinare da una musica che fa del sussurro, se non proprio del
silenzio, un arte, magari con la stessa devozione che avete dedicato a un disco
dei National o dei Low (per dare subito un paio di coordinate chiare), allora
anche lo slow-core rivisto e corretto da Jesse
Lurtz e soci potrebbe conquistarvi. Lurtz è già noto come la parte maschile
dei The Duchess And The Duke, autori di due album usciti a fine del decennio
scorso fatti di folk sparato ad alta velocità, tanto da trovarli spesso catalogati
addirittura come garage-rock. Ma la Seattle da cui provengono non è più la
stessa dell’era Cobain, e persa la collaboratrice Kimberly Morrison, Lurtz ha generato un nuovo nickname (già
titolari dell’esordio The World Is
Just a Shape to Fill the Night di due anni fa) per affrontare
un’esperienza che si allontana da quanto fatto in precedenza. Folk magari, ma
fortemente tinto di musica inglese o magari con in testa qualcosa vicino al
mondo di Mark Eitzel. In A Suit Made Of
Ash, il brano che apre il disco, fa capire subito l’indirizzo: pianoforte
in evidenza, sezione archi e canto alquanto votato al melodico, e il resto del
disco cambia solo raramente registro, fin dai tesissimi quasi sette minuti di Passage/Me In The Dark. Quando poi
interviene Marissa Nadler nella
ipnotica Villain il sapore è quello
di una versione più acustica dei Walkabouts, mentre se avete amato le atmosfere
malinconiche del John Grant di Queen of Denmark allora magari vi ritroverete a
casa in brani come House of Silk, House
Of Stone o You Say To Me, You Never Have to Ask (quest’ultimo potrebbe
anche richiamare il Bill Fay recentemente riesumato dall’oblio della storia).
Testi interessanti e sufficientemente folli per giustificare l’incedere impregnativo
del disco, con durate anche oltre i sei minuti non facili da reggere al primo
impatto. Il limite sta ovviamente nella voluta monotonia ritmica del tutto,
come se l’artista non chiedesse, ma proprio pretendesse la nostra attenzione
sempre più bombardata da stimoli on-line. Potrebbe avere ragione Lurtz, e
sapere di riuscire ancora ad apprezzare un disco come This is Another Life potrebbe davvero rappresentare la nostra
salvezza dalla modernità.
Nicola Gervasini
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Emma Swift
Emma Swift The Resurrection Game (2025, Tiny Ghost Records) File Under: Sophisticated Lady Il rock non è più materiale da bruciar...
-
NICOLA GERVASINI NUOVO LIBRO...MUSICAL 80 UN NOIR A SUON DI MUSICA E FILM DEGLI ANNI 80 SCOPRI TUTTO SU https://ngervasini.wixsite.com...
-
Jonathan Jeremiah Good Day [ Pias/ Self 2018 ] facebook.com/jjeremiahmusic File Under: il nostro disco che suona… di Nicola Gerva...




