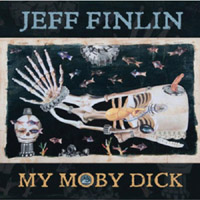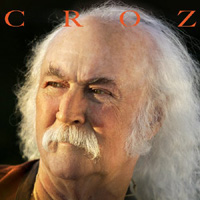| Andrea Schroeder Where the Wild Oceans End [Glitterhouse 2014] www.andreaschroeder.com di Nicola Gervasini (25/03/2014) |  | |
Se non ne avete mai sentito parlare, sappiate che la giunonica dark lady berlinese Andrea Schroeder si era già fatta notare con l'album Blackbird, il suo fascinoso disco d'esordio di due anni fa. Quando si parla di lei pare obbligatorio il paragone con Nico, con la quale condivide stazza fisica, nazionalità, e anche il modo profondo e vibrante di usare la voce, così come pare inevitabile citare la romantica durezza di Marlene Dietrich. Ma se in quel primo album si notava più lo stile delle canzoni, per il secondo capitolo - Where The Wild Oceans End - la Schroeder ha puntato sulla sostanza e ha ridefinito il suono. E chi meglio di Chris Eckman poteva portare in dote quel tocco americano misto al gusto mitteleuropeo necessario ad una simile svolta, lo stesso che ormai da anni costituisce il marchio di fabbrica della sua casa di produzione?
Sotto la guida della mente dei Walkabouts, le canzoni di Andrea Schroeder acquistano una forma definita, arrivando finalmente a toccare i livelli desiderati in episodi come Ghosts Of Berlin o l'iniziale Dead Man's Eyes. Certo, poi è naturale che l'episodio che risalta subito (e che, non a caso, è stato scelto anche come singolo) è l'azzeccatissima versione di Helden, la sorella tedesca di Heroes (che lo stesso David Bowie cantò in tedesco per omaggiare lo spirito berlinese che animava i suoi dischi della seconda metà degli anni settanta), ma non sfugga la crescita della Schroeder come autrice, in grado di vestire i panni che competono solitamente a Carla Torgerson in una acustica e decisamente rootsy Fireland (che davvero rammenta i migliori Walkabouts di due decenni fa). Il nebbioso tocco berlinese comunque non manca, e lo si sente nel rintocco di piano di The Spider (che ricorda tanto quello di Sense Of Doubt, sempre dal Bowie di Heroes), nel numero da cabaret alla Ute Lemper della title-track, nel blues infernale alla Nick Cave di The Rattlesnake, o in una Summer Came To Say Goodbye che sarebbe piaciuta molto a Jim Morrison.
Il tutto sempre con un'aria decadente e velvettiana che rappresenta insieme il pregio e il limite del disco, laddove l'eredità dei riferimenti continua a rimanere pesante. Ma il passaggio da un produttore decisamente preponderante come Eckman sembra essere un passaggio obbligato per imparare la nobile arte dell'espressione di una propria definita personalità (pensate a come anche i dischi di due autori molto diversi tra loro come Steve Wynn e Terry Lee Hale, da lui prodotti in anni recenti, suonino molto simili, o come la sua mano sia riconoscibile anche nelle vene della canzone d'autore italiana dell'Evasio Muraro di Scontro Tempo). In ogni caso Where The Wild Oceans End conferma una nuova interessante artista, tra l'altro ben supportata da una validissima band, che vede nella violinista Catherine Graindorge e nell'ottimo chitarrista danese Jesper Lehnkuhl (uno che ha studiato bene i corsi di Lou Reed e Tom Verlaine) gli elementi da tenere d'occhio.
Sotto la guida della mente dei Walkabouts, le canzoni di Andrea Schroeder acquistano una forma definita, arrivando finalmente a toccare i livelli desiderati in episodi come Ghosts Of Berlin o l'iniziale Dead Man's Eyes. Certo, poi è naturale che l'episodio che risalta subito (e che, non a caso, è stato scelto anche come singolo) è l'azzeccatissima versione di Helden, la sorella tedesca di Heroes (che lo stesso David Bowie cantò in tedesco per omaggiare lo spirito berlinese che animava i suoi dischi della seconda metà degli anni settanta), ma non sfugga la crescita della Schroeder come autrice, in grado di vestire i panni che competono solitamente a Carla Torgerson in una acustica e decisamente rootsy Fireland (che davvero rammenta i migliori Walkabouts di due decenni fa). Il nebbioso tocco berlinese comunque non manca, e lo si sente nel rintocco di piano di The Spider (che ricorda tanto quello di Sense Of Doubt, sempre dal Bowie di Heroes), nel numero da cabaret alla Ute Lemper della title-track, nel blues infernale alla Nick Cave di The Rattlesnake, o in una Summer Came To Say Goodbye che sarebbe piaciuta molto a Jim Morrison.
Il tutto sempre con un'aria decadente e velvettiana che rappresenta insieme il pregio e il limite del disco, laddove l'eredità dei riferimenti continua a rimanere pesante. Ma il passaggio da un produttore decisamente preponderante come Eckman sembra essere un passaggio obbligato per imparare la nobile arte dell'espressione di una propria definita personalità (pensate a come anche i dischi di due autori molto diversi tra loro come Steve Wynn e Terry Lee Hale, da lui prodotti in anni recenti, suonino molto simili, o come la sua mano sia riconoscibile anche nelle vene della canzone d'autore italiana dell'Evasio Muraro di Scontro Tempo). In ogni caso Where The Wild Oceans End conferma una nuova interessante artista, tra l'altro ben supportata da una validissima band, che vede nella violinista Catherine Graindorge e nell'ottimo chitarrista danese Jesper Lehnkuhl (uno che ha studiato bene i corsi di Lou Reed e Tom Verlaine) gli elementi da tenere d'occhio.