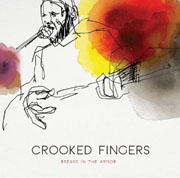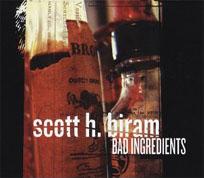inserito 20/12/2011 | |
Cass McCombs |
martedì 31 gennaio 2012
CASS McCOMBS - Humor Risk
venerdì 27 gennaio 2012
CROOKED FINGERS . Breaks In The Armor
inserito 13/12/2011 | |
Crooked Fingers |
mercoledì 18 gennaio 2012
CESARE CARUGI - Here's To The Road
Perchè un ragazzo - ormai neanche più tanto ragazzo - di Cecina decide di investire tempo, neuroni e energia nel produrre un disco in pieno 2012, destinato a perdersi nel mare magnum del iper-produttività di questi anni 2000? Per compiacere sè stesso, certo, per piacere agli amici e conoscenti, certo, per scoprire che al di là del muro di casa esiste qualcuno che condivide la stessa passione per un rock americano che suonava nuovo alla fine degli anni 70, quando un disco così serviva a far esordire uno Steve Forbert o un Willie Nile al grido "abbiamo il nuovo Springsteen o il nuovo new Dylan!". Certo. Quante copie potrebbe vendere Here's To The Road? Quanta storia può scrivere oggi una Caroline, la ballatona che ancora mancava nel perfetto songbook del blue-collar loser, o una Too Late To Leave Montgomery che ruba un incipit a Lucinda Williams ma poi riesce a trovare una strada tutta sua per diventare uno dei vostri tormentoni quotidiani se solo gli concedete più di un ascolto? Quante citazioni potrebbe guadagnarsi fra vent'anni un disco come quello di Cesare Carugi? E quanti, come lui, hanno imparato in anni di ascolti e passione un verbo (qui è quello del più puro rock americano) e ora lo sanno parlare alla perfezione, proprio quando sono rimasti però in pochi a capirlo? Già, perchè ascoltando Here's To The Road si hanno due obbligatorie reazioni: la prima è "cazzo, ma sta roba è tutta già sentita!". La seconda invece è "cazzo, ma 'sto tipo però è bravo". Già, il Carugi canta bene, sa come si scrive una canzone, e nei limiti di una autoproduzione casalinga, ha saputo anche registrarle. Poi ci pensi, e realizzi che se un Jimmy Iovine dei tempi d'oro avesse prenotato la casa per le vacanze a Marina di Cecina, e alla sera, tra una finocchiona e un ragù di cinghiale, avesse dato un paio di dritte al Carugi per rendere più potente una There Ain't Nothin' Wrong With Goin' Nowhere (grande brano e grande titolo...), se il Michael McDermott che passa in visita di cortesia in Dakota Lights & The Man Who Shot John Lennon (grande brano e grande titolo...) fosse ancora seguito dall'entourage da major che confezionò così bene il suo lontano esordio, se lo stesso Carugi si rendesse conto che se sa tirar fuori un piccolo gioiello come London Rain (pare un pezzo di Shawn Phillips, sempre che ci si ricordi chi diavolo fosse Shawn Phillips...), allora forse può anche andare oltre certi schemi da raduno di springsteeniani, insomma, se questo album fosse uscito 30 anni fa e fosse stato registrato a New York invece che a Bagno a Ripoli....allora....forse....il discorso lo sapete. Insomma, se questa è per la strada, allora che rimanga alla strada, ma un tempo questa roba la si dava prima in pasto alla storia, e non è colpa del Carugi se ora il rock and roll è solo questione di files sul desktop da passare sull'ipod e non più di radio che lanciano colonne sonore agli avvenimenti umani. Le sue canzoni sono le stesse che avremmo amato trent'anni fa, magari facendole passare per importanti, per cui che importa se oggi lo saranno solo per quei quattro gatti che avranno tempo per ascoltarle. Ci sono, e sono davvero sulla strada. Questo è il bello. (Nicola Gervasini)
martedì 17 gennaio 2012
KD LANG - Sing it Loud

Fin dal 1984 i suoi dischi rappresentano il perfetto riassunto di decenni di musica canadese, eppure k.d.lang resta un personaggio poco riconosciuto, che ancora usa firmarsi in caratteri minuscoli nonostante abbia anche venduto parecchio. A dispetto del titolo del suo nuovo album (Sing It Loud, Nonesuch), lei è infatti una che non ha mai urlato, neppure la sua dichiarata omosessualità (resta memorabile il servizio fotografico che ritraeva Cindy Crawford intenta a rasarle la barba) o le sue lotte contro l’industria della carne. Consigliamo invece di dimenticare il personaggio ed ascoltare queste dieci canzoni sofisticate e finemente costruite, che fanno sempre più a meno della musica rurale nordamericana e si avvicinano più al jazz, al pop, e ad un gusto teatrale e melodrammatico decisamente europeo. (Nicola Gervasini)

domenica 15 gennaio 2012
COWBOY JUNKIES - The Nomad Series Vol. 3 - Sing In My Meadow
inserito 11/11/2011 | |
Cowboy Junkies
|
giovedì 12 gennaio 2012
SCOTT H BIRAM - Bad Ingredients
inserito 22/11/2011 | |
Scott H Biram |
mercoledì 11 gennaio 2012
DEVON WILLIAMS - EUPHORIA

DEVON WILLIAMS
EUPHORIA
Slumberland Records
***
Piccoli indipendenti crescono: Devon Williams è ancora un nome poco noto nel firmamento della musica, dopo l’esperienza in band rimaste oggetto di culto per pochi come gli Osker, Fingers-Cut, Megamachine e Lavender Diamond. Nel 2008 aveva esordito con Carefree, piccolo gioiellino di indie-music che non ha fatto però il giusto rumore nel fracasso generale di mille piccole produzioni, ma potrebbe essere la volta buona con il secondo tentativo, il fin dal titolo e copertina colorato Euphoria, una variopinta tavolozza di stili che dal folk minimale di base si estende al pop e a quello stesso amore per gli arrangiamenti complessi dei Fleet Foxes più recenti. Ricetta non nuova ma sempre affascinante la sua, forte di una voce che sa davvero molto di new wave di primi anni 80, ma con lo stesso gusto per i vocalizzi eterei alla Bon Iver. Euphoria è infatti un disco che si appella ad un ben preciso periodo storico del rock, che passa da una title-track che potrebbe davvero essere appartenuta ai Cure meno drammatici di metà anni 80, fino a pop orchestrali come Sufferer, che avremmo potuto anche trovare tranquillamente in un disco del Lloyd Cole che fu. Sicuramente Williams contribuisce al rilancio generale di certe soluzioni degli eighties che erano forse state sepolte con troppa fretta nei ruggenti novanta, come se si potesse far risorgere lo spirito degli Echo & The Bunnymen aggiornati per i nuovi palati legati al freak-folk più recente, anche se le tastiere di Tower Of Thought sono davvero le stesse di quegli anni. Al disco manca forse il guizzo che faccia la differenza, tentato con una Right Direction che prova la via di un jingle-jangle pop che ancora una volta sta dalle parti dei Cure (ma stavolta quelli di Wish), o con una All My Living Goes To You che in tema di sovra-orchestrazioni cerca di fare concorrenza ai Beach Boys. Ma la finale La La La La, che filtra batterie e chitarre in mille effetti, comincia a far pensare che Devon avrebbe voluto nascere nei tempi in cui produttori come Steve Lillywhite confezionavano questi suoni per i nomi più alla moda e le produzioni erano imposte dall’alto. Tutte cose che lasciano il dubbio se Euphoria sia solo un disco moderno con un lieve gusto retrò, o molto probabilmente il risultato di un nuovo feticismo da studio di registrazione. In attesa di capire cosa farà lui da grande, il gioco riesce anche a divertire.
Nicola Gervasini
lunedì 9 gennaio 2012
THE DUKE & THE KING

THE DUKE & THE KING
Deve aver pensato che era giunto il momento di dare il colpo di grazia ai propri fratelli il buon Simone Felice, e così, mentre i Felice Brothers arrancano affannosamente in una modernizzazione senza troppo futuro (ascoltate il recente e deludente Celebration, Florida), lui prova a lucidare il repertorio dei suoi The Duke & The King nella speranza di rendere ben chiaro chi ci ha guadagnato di più nella separazione. Il progetto del Duca e del Re (personaggi presi da Mark Twain) è giunto al terzo disco ormai, un album senza titolo che è in verità una sorta di “The Best” dei primi due lavori (l’ottimo esordio Nothing Gold Can Stay e il più incerto ma variegato Long Live), pensato e ideato per il mercato americano, visto che le due prime pubblicazioni hanno riguardato solo l’Europa. L’occasione è dunque quella di ripartire da zero e considerare che il progetto di Simone e del suo partner Robert "Chicken" Burke ha tutte le credenziali per produrre in futuro ottime cose, visto quanta grazia già ci offrono i questi solchi. Se non le conoscete, scoprite allora brani come If You Ever Get Famous o The Morning I Get To Hell, che nulla hanno da invidiare all’applauditissimo John Grant, oppure l’irresistibile folk-pop di Shaky (come si fa a resistere ad un ritornello che canta “The Jackson 5 grew up so fast, Cmon baby, Just come and shake that country ass”?), o la bella No Easy Way Out cantata dalla violinista Simi Stone. Il riferimento a John Grant può aiutare per capire lo stile: folk americano e pop inglese qui s’intersecano alla perfezione, con in più qualche inserimento percussivo un po’ obliquo, logico contributo di Burke, un nato alla scuola per deejay di George Clinton (anche il batterista Nowel Haskins viene dal giro dei Parliament). Ma quello che piace, anche risentendo questa panoramica che si divide quasi equamente tra estratti dei loro primi due lavori, è proprio la scrittura delle canzoni, malinconica ma mai autoindulgente, con un’attenzione particolare alla melodia senza però scadere nell’ovvio (sentite anche una semplice folk-song come O’Gloria). Come sempre accade in questi casi la scelta delle canzoni non collima perfettamente con quella che avremmo operato noi (ad esempio dal secondo album avremmo evitato la pesante Just You And I), e dal primo album manca all’appello qualche titolo fondamentale, ma in attesa di verificare la positiva evoluzione del duo, The Duke & The King è un consigliatissimo cd per essere aggiornati su una delle migliori nuove realtà della canzone americana.
Nicola Gervasini
domenica 8 gennaio 2012
JOSH ROUSE - Josh Rouse and The Long Vacations
 | Josh Rouse |
|
sabato 7 gennaio 2012
DIEGO GARCIA - Laura
| Diego Garcia |
|
Emma Swift
Emma Swift The Resurrection Game (2025, Tiny Ghost Records) File Under: Sophisticated Lady Il rock non è più materiale da bruciar...
-
NICOLA GERVASINI NUOVO LIBRO...MUSICAL 80 UN NOIR A SUON DI MUSICA E FILM DEGLI ANNI 80 SCOPRI TUTTO SU https://ngervasini.wixsite.com...
-
Jonathan Jeremiah Good Day [ Pias/ Self 2018 ] facebook.com/jjeremiahmusic File Under: il nostro disco che suona… di Nicola Gerva...