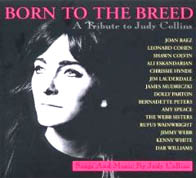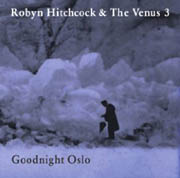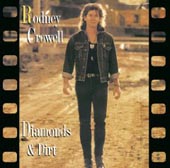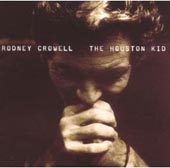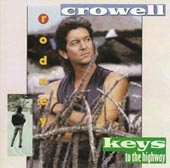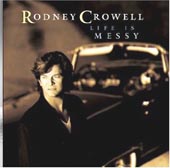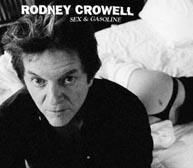"Scrivere canzoni è una cosa misteriosa: a volte si scrive senza una ragione, a volte scrivi fino a che fa male, a volte scrivi per vendetta, ma è solo un cercare la verità. A volte tutto quello che serve è uno sparo nel buio per poter vedere la luce…".
"Scrivere canzoni è una cosa misteriosa: a volte si scrive senza una ragione, a volte scrivi fino a che fa male, a volte scrivi per vendetta, ma è solo un cercare la verità. A volte tutto quello che serve è uno sparo nel buio per poter vedere la luce…". (
Guy Clark, note di copertina dell'album Diamonds & Dirt di Rodney Crowell)
a cura di Nicola Gervasini
:: Il ritratto
"C'era una volta una città magica, piena di una musica che si poteva sentire ovunque, nelle strade, nei bar, nelle radio. E in quella città i musicisti erano divinità, retti esempi della stessa "good way of life" cantata in quelle dolci e disincantate canzoni, fatte di storie di famiglia, lavoro e amore per la propria terra. Ma un giorno successe qualcosa di brutto: uno di quei cantanti divenne mito, cantò di depressione, violenza e sbronze esistenziali, e morì da esiliato. La città magica lo pianse tirando un sospiro di sollievo, ma la miccia era accesa, e dopo di lui vennero una serie di fuorilegge che misero a ferro e a fuoco la città. I vecchi potenti della città si difesero cercando di addomesticare i riottosi, coinvolgendoli il più possibile nei propri progetti fatti di sicurezza e tradizione, ma serviva che fosse un giovane a riportare tutti sulla retta via. Così venne Lui, e li mise d'accordo tutti, i vecchi con i giovani, i tradizionalisti con i fuorilegge, i reazionari con i rivoluzionari, sposò la figlia del capo dei cattivi e la portò dalla parte dei buoni. La città lo ringraziò, ma, risolto il problema, gli voltò subito le spalle, e si dimenticò prestò del nuovo eroe; il quale, deluso e abbandonato, scappò, tornando anni dopo solo per cantare la corruzione e la falsità di quella città, che rimase, nonostante tutto, sempre e comunque magica…"
Sembra la favola del Pifferaio di Hamlin, invece è (con parecchie licenze poetiche) la storia di Rodney Crowell. La vita dell'uomo che salvò Nashville inizia il 7 agosto 1950 a Houston in Texas, ma la sua storia artistica inizia nel 1972 con un gruppo locale chiamato The Arbitrators. E' in quegli anni che stringe una forte amicizia con due suoi eroi, Guy Clark e Townes Van Zandt, ed è proprio per seguire i due che Rodney approda a Nashville, la Mecca della country-music, la città magica dove cercare la giusta occasione. La prima gliela regala il chitarrista Jerry Reed (scomparso recentemente), mito locale che lo assume come autore per la sua società di pubblicazioni. Ma la vera occasione arriva quando Rodney incontra Emmylou Harris, giovane promessa pronta a sbocciare dopo la morte del suo mentore Gram Parsons. La Harris lo imbarca subito come chitarrista nella seminale avventura della sua Hot Band e ne sfrutta fin da subito le doti di autore, incidendo per prima molti suoi brani come Amarillo, Till I Gain Control, Tulsa Queen, e I Ain't Livin' Long Like This. Forte della notorietà acquisita al fianco di Emmylou, Crowell prova il gran passo, prima fondando con Vince Gill un estemporaneo gruppo di giovani promesse (i Cherry Bombs, che pubblicheranno un unico album nel 2004 in pieno clima nostalgico), e poi firmando per la Warner Bros un contratto a proprio nome. Le sue doti di songwriter e musicista sono ormai riconosciute da tutti, tanto che nel 1979 è nientemeno che Rosanne Cash, la figlia di Johnny, a chiamarlo a scrivere e produrre il suo album di debutto Right Or Wrong (che uscirà solo nel 1980), un matrimonio artistico talmente ben riuscito, da diventare nozze effettive anche nella vita. Nonostante le ottime premesse però, la carriera solista di Crowell non prende quota: il primo ottimo disco vende appena 20.000 copie, il secondo riesce appena a piazzare il singolo Ashes By Now al trentasettesimo posto delle country-charts, mentre il terzo disco del 1981 sparisce presto dagli scaffali.
La sua carriera di fatto era partita fuori tempo massimo: la Nashville che aveva sognato stava lentamente scomparendo, molti eroi degli anni 70 come Willie Nelson (e la stessa Emmylou Harris) vennero a patti con le esigenze dell'industria discografica per rimanere a galla negli anni 80, qualcuno provò a navigare da solo (John Prine), molti altri scomparirono dalla scena (Lee Clayton e molti altri). In questo scenario di sconfitta per il cosiddetto country d'autore, Crowell salvò la pelle grazie alla sua attività di autore, e mentre i suoi dischi prendevano polvere nei negozi, i suoi brani devastavano le charts grazie ad altri artisti. Gli Oak Ridge Boys con Leavin' Louisiana In The Broad Daylight, Crystal Gale con Till I Gain Control Again, Bob Seger con Shame on the Moon sono solo alcune dei numeri uno di Billboard firmati Crowell nei primi anni '80. Ma il decennio fu difficile: il matrimonio con Rosanne cominciò a deragliare nelle droghe e nell'alcool, mentre la Warner Bros nel 1984 rifiutò di pubblicare l'album Street Language perché non in linea con le richieste del mercato (il titolo vide la luce solo nel 1986 grazie alla Columbia). Le cose ricominciarono a girare bene solo nel 1987, prima grazie al successo dell'album di Rosanne Cash, King's Record Shop, da lui prodotto, e poi con il clamoroso botto commerciale del suo Diamonds & Dirt, il disco che salvò letteralmente Nashville. Forte di un successo che lo vedeva per la prima volta protagonista in prima persona, Crowell tentò di portare avanti un suo discorso di country-pop d'autore con convinzione e (finalmente) anche mezzi, ma ancora una volta Nashville fagocitò le sue speranze, inebriata da un rilancio commerciale i cui frutti furono poi raccolti da una nuova generazione di giovani country-singers dalle vendite a dir poco vertiginose. Così mentre Garth Brooks diventava l'artista più venduto di sempre pubblicando dischetti pensati spremendo Diamonds & Dirt fino al midollo e rilevandone solo il lato più radiofonico, a metà anni 90 Crowell era di nuovo un reietto abbandonato dall'industria discografica e dalla moglie Rosanne (divorzio ufficiale nel 1991).
Tornerà in alto negli anni 2000, con una produzione di gran livello e la libertà di cantare la sua città con nuove parole, dure e taglienti come quelle degli innamorati respinti.Tipico personaggio da dietro le quinte dello show-business, Crowell ha rappresentato l'ala destra del movimento dei neo-tradizionalisti di fine anni '80, impersonando il link mancante tra la tradizione pura e la generazione dei nuovi fuorilegge nashvilliani (Steve Earle, Dwight Yoakam…). Sul suo nome si registrano attestazioni di stima da entrambe le parti, e forse è a causa di questo suo essere sempre in mezzo al guado che il suo non è mai stato nome di culto, oltre che per quel suo stile pulito e da bravo ragazzo che lo ha reso sempre carente di fascino da rockstar. Nella sua carriera ha fatto dischi importanti e anche molto influenti, ma gli è forse mancato il capolavoro universalmente riconosciuto per poter essere annoverato tra i numeri uno. Ed è forse proprio perché la sua firma è stata più decisiva della sua opera che quest'ultima merita di essere riascoltata e ripensata sotto una nuova luce.
:: Il capolavoro
 Ain't Living Long Like This
Ain't Living Long Like This[Warner Bros. 1977]
1. Elvira // 2. (Now And Then There's) A Fool Such As I // 3. Leaving Louisiana In The Broad Daylight // 4. Voila, An American Dream // 5. I Ain't Living Long Like This // 6. Baby, Better Start Turnin' Em Down // 7. Song For The Life // 8. I Thought I Heard You Callin' My Name // 9. California Earthquake (A Whole Lotta Shakin' Goin' On)
Ain't Livin' Long Like This, o anche "quello che sarebbe stata la musica di Rodney Crowell se fosse nato dieci anni prima", è insieme a The Houston Kid il disco migliore e generalmente più consigliato della sua opera. Non è il più rappresentativo in verità, perché lo stile da vero country-outlaw evidenziato da questo esordio rimarrà un caso unico nella sua discografia. I riferimenti più evidenti qui erano Gram Parsons e Guy Clark, ma dal punto di vista produttivo il disco si allineava all'opera contemporanea di John Prine e Lee Clayton, vale a dire quella parte di Nashville che stava cercando una via che unisse la tradizione bianca al soul nero (evidente nei fiati della title-track) o a certe ruvidezze del rock. A dispetto della sua fama d'autore, il disco parte alla leggera con due cover che vennero anche presentate come singolo, una scoppiettante Elvira del mitico country-songwriter Dallas Frazier e una Fool Such As I in versione da porch-song che sarebbe sicuramente piaciuta all'appena scomparso Elvis Presley. Ma il viaggio nella fine del sogno americano era guidato dalle sue storie, tutte incentrate sul tema della fuga, come quella di Mary che segue un fuorilegge senza speranza nella calda e inospitale Louisiana (Leaving Louisiana in the Broadlight), quella della mente sulle spiagge della Giamaica (Voilà An American Dream, con versi ben eloquenti come "sento che una vacanza tropicale possa essere l'unica risposta a questa birra Hillbilly"), quella dalla prigione del fuorilegge braccato della title-track o quella amarissima dalla realtà che uccide la libera espressione (Baby, Better Start To Turnin'em Down). L'uomo dalla ballata facile usciva già allo scoperto con la dolcissima Song For The Life, brano tra i suoi più rivisitati, e dopo una terza cover (I Heard You Callin' My Name di Lee Emerson, forse l'episodio più old-style), il disco si chiudeva con i sensazionali sei minuti di California Earthquake (Whole Lotta Shakin Goin'On), che dietro il secondo omaggio al rock and roll, celava un racconto degno di John Steinbeck del grande terremoto californiano del 1883 e dell'epopea della povera gente costretta a ricostruire una vita sulle macerie di un sogno. Un'immagine devastante di una società americana allo sbando nel momento di dimostrare solidarietà e prontezza davanti alle tragedie, una storia che la recente alluvione di New Orleans ha dimostrato non essere evidentemente stata raccontata ancora abbastanza, e che lo stesso Crowell non avrà più la capacità di raccontare con uguale crudezza fino agli anni 2000.
:: Dischi essenziali
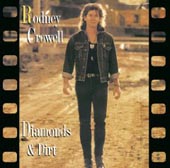 Diamonds & Dirt
Diamonds & Dirt [Columbia/ Legacy 1988]
Esiste un'intera generazione di appassionati di musica che ha scoperto Rodney Crowell con questo album…e se ne è fatto inevitabilmente un'idea distorta. Veniamo ai fatti: nel 1988 era (discutibile) opinione comune che Nashville fosse una bella addormentata che partoriva zuccherosi singoli esclusivamente per le proprie classifiche. Vero era che in quegli anni la parola "country" faceva quasi orrore alle giovani generazioni di ascoltatori, ma le cose cominciarono a cambiare nel 1986, quando la città fu invasa da una nuova generazione di artisti (che vennero bollati come "neo-tradizionalisti") che parlavano un idioma musicale più moderno e "young-friendly". In questo clima di guerra civile tra vecchi appagati e giovani ribelli arrivò questo disco come un fulmine a ciel sereno. Crowell sfruttò le proprie buone credenziali presso le case discografiche per registrarlo in piena libertà e con i musicisti a lui più consoni, in cambio consegnò un bestseller che arrivò fino all'ottavo posto delle classifiche di Billboard e, fatto ancora oggi imbattuto nel libro dei record, 5 singoli autografi tratti dallo stesso album tutti al primo posto. Il segreto di questo improvviso successo fu la "mediazione perfetta" sottoforma di 10 country-pop-songs pulite e perfette come da tradizione, ma suonate con la grinta e la strafottenza dei nuovi monelli nashvilliani. Diamonds & Dirt piacque a tutti, il duetto con la moglie Rosanne di It's Such A Small World era rassicurante quanto la melodia di She's Crazy For Leavin' inevitabilmente contagiosa, Crazy Baby e I Know You're Married baldanzose e sbruffone quanto After All This Time e The Last Waltz malinconiche e ispirate. Se per il pubblico europeo Crowell rimarrà sempre "troppo country" e per quello americano sempre troppo poco, sarà sempre "colpa" di questo disco che suona ancora oggi fresco ed elettrizzante nella sua perfetta essenzialità.
 The Cicadas
The Cicadas [Warner, 1997]
Chi nel 2001 si sorprese per la svolta di The Houston Kid semplicemente era uno dei tanti (praticamente tutti) che avevano ignorato questo side-project uscito in sordina e presto scomparso dalla circolazione (è stato finalmente ristampato nel 2007). Dietro l'effimera sigla di una band si celava un Crowell quasi desideroso di nascondere le proprie intenzioni, ma questo disco è suo al 100%, anche se l'apporto degli ottimi comprimari e collaboratori di lunga data (Steuart Smith -chitarre e co-produttore, Michael Rhodes - basso e Vince Santoro - batteria) fu decisivo nel creare un nuovo sound fieramente rock-oriented. Chitarre affilate, batterie decise e un piglio energico evidenziato in due cover da suonare ad alto volume come una Tobacco Road in chiave quasi Hendrixiana e una Blonde Ambition che respira puro blue-collar rock da bar. Da altri lidi arriva anche la splendida Wish You Were Her, brano co-firmato da Bono degli U2 con T-Bone Burnett nel lontano 1985, mentre significativo è l'attacco del disco di When Losers Rule The World, inno ai perdenti scritto con uno specialista in materia come Ben Vaughn. La voglia di altri suoni lo porta ad una We Want Everything che sembra un brano sfuggito al Tom Petty di Wildflower, una Our Little Town che cementa ancora una volta l'amicizia artistica con il co-autore Guy Clark e altri brani decisamente interessanti come Nothing (cantata con il suo discepolo più meritevole Jim Lauderdale) e Through The Past. Il capolavoro arriva alla fine, con i sei minuti di Still Learning How To Fly, epica ed enfatica al punto giusto. Disco fuori dal tempo, The Cicadas non venne preso sul serio e fu considerato una scampagnata di un autore in cerca di una nuova ragione di essere, quando invece era l'inizio di una maturità che darà ottimi frutti.
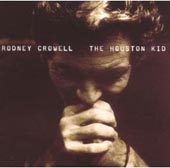 The Houston Kid
The Houston Kid [Sugar Hill, 2001]
Sembra davvero una favola: la fuga da Nashville, il silenzio e l'oblio, e poi il ritorno con il disco cercato per una vita.
The Houston Kid è l'autobiografia di Crowell, raccontata attraverso piccole istantanee della sua fanciullezza a Houston. Un'infanzia non certo spensierata: Rock Of My Soul racconta la storia di un padre che abusa di madre e figlio, I Wish It Would Rain affronta i sensi di colpa per come da ragazzino abbia evitato un vicino di casa malato di AIDS, Wandering Boy è una dedica non proprio serena a tutti gli amici di un tempo, mentre Telephone Road sfiora la letteratura con i ricordi di bagni, giri in motoretta e gelati comprati con soldi grattati qui e là. Su tutto il disco aleggia pesante lo spirito della famiglia Cash: Rodney prova a riconciliarsi a suo modo dedicando alla ex moglie Rosanne l'arrabbiata U Don't Know How Much I Hate You, serie di recriminazioni per un amore mal risolto, ma anche la confessione di quanto oggi si senta solo senza la compagna di mille avventure. Piena riconciliazione invece con l'ex suocero Johnny Cash, prima evocato in Telephone Road, e poi direttamente omaggiato in Walk The Line (Revisited). Pare che Johnny rimproverasse sempre a Rodney di suonare dal vivo la sua canzone con il ritmo sbagliato, così lui pensò bene di terminare la discussione scrivendo un racconto sulla prima volta che sentì il brano alla radio e lasciando a Johnny l'onore di intervenire cantando il brano originale (nel video Cash appare in un filmato d'epoca come un flashback). Ma la vera riconciliazione Crowell la trovò con sè stesso nel suono del disco, perfetto punto di incrocio tra il country più classico, il folk e il rock, esattamente quello che cercava da tempo e che solo accasandosi nell'indipendente Sugar Hill (la stessa etichetta che ha salvato la carriera a Guy Clark…) ha potuto realizzare senza condizionamenti. The Houston Kid non è solo il disco della sua maturità, ma è anche il punto di partenza di una nuova carriera, l'inizio di un sentiero che Rodney avrebbe volentieri percorso fin dal 1977.
 Fate's Right Hand
Fate's Right Hand[DMZ/Epic, 2003]
Presa la mano, Crowell realizza un altro disco imprescindibile con
Fate's Right Hand. Caratterizzato da toni ancora più introspettivi e da un sound elettro-acustico perfettamente prodotto (lo aiuta stavolta il vecchio Pete Coleman) e mai banale, il disco testimonia la ritrovata convinzione nei propri mezzi. La partenza ribadisce la bontà del dimenticato disco dei Cicadas ripescando Learning How To Fly, probabilmente il brano che meglio descrive la storia di un artista dalla lenta e dolorosa maturazione, e soprattutto la raggiunta consapevolezza di essere uno strano ibrido di artista country-rock destinato a battaglie solitarie fino alla fine. Qui trovate alcuni suoi piccoli capolavori d'autore come la diretta Time To Go Inward, bellissimo inventario delle proprie esperienze e delle proprie emozioni dopo trent'anni on the road, oppure l'epica title-track, una delle sue cose migliori di sempre, un testo intraducibile fatto di giochi di parole a dichiarare il proprio totale disorientamento nel mondo moderno. Nè rock, né country, il nuovo Crowell viaggia sulle corde di rock acustico cantautoriale che ben si sposa con la sua forte attitudine melodica, facendo così risplendere brani come The Man In Me, Ridin'Out The Storm e This Too Will Pass. Perfettamente dosato tra riflessione (Adam's Song) e divertimento (Preachin' To The Choir), Fate's Right Hand si può tranquillamente ritenere il suo disco della raggiunta maturità.
:: Il resto But What Will the Neighbors Think
But What Will the Neighbors Think[Warner Bros., 1980]
Fatte le debite distanze, il tentativo fu simile a quello operato dai Byrds di Sweetheart Of The Rodeo: prendere la tradizione di Nashville e portarla su terreni nuovi, senza snaturarne il senso e il suono. Nel caso dei Byrds la terra straniera era quella del rock, qui invece Crowell tentò una strana virata verso la new wave. Il co-produttore Craig Leon era appena uscito dalle sale di registrazione di Blondie, Suicide, Richard Hell & the Voidoids e Ramones, e tentò di aggiornare l'outlaw-sound dell'esordio inserendo batterie più pesanti e chitarre più metalliche. Rodney fornì ottime prove come perfomer, dimostrandosi a suo agio in episodi puramente rock come Here Comes The 80's, Queen Of Hearts o la rockabilly It's Only Rock And Roll, ma perdendo grinta e incisività negli episodi più romantici come Oh, What A Feeling, dove il country-sound qui abiurato (e relegato alla scanzonata Heartbroke di Guy Clark) avrebbe reso ben altri servizi. Se il singolo Ashes By Now resta una delle sue love-song più coinvolgenti, On A Real Good Night segue palesemente le orme delle ballate pianistiche di Bob Seger, e altrove il giovane Rodney cerca di seguire sentieri alternativi, con risultati buoni come il bel viaggio nel delta di Blues In The Daytime (con la chitarra di Albert Lee in gran spolvero) o meno determinati, come lo strano sixties-folk di The One About England.
 Rodney Crowell
Rodney Crowell[Warner Bros., 1980]
Prima di sparire nel vortice di plastica degli anni '80, Crowell pubblicò un buon terzo disco senza titolo, che rimane forse il miglior elenco di ragioni del suo mancato successo. Forte di due brani in puro Gram Parsons-style che diventeranno bestseller in mani altrui (la splendida Shame On The Moon e la ultra-rivisitata Til I Gain Control Again, forse il suo brano più classico), il disco oscillava senza prendere una posizione netta e decisa tra voglie ben poco nascoste di honky-tonk rock (Just Wanna Dance, Don't Need No Other Now e Old Pipeliner) e tentativi di assecondare con piena dignità le richieste di sugar-pop della Warner Bros con le più che accettabili romanze di Victim Or A Fool e Stars On The Water. Avere nello stesso disco canzoni "easy-going" come All You've Got To Do o Only Two Hearts e momenti di canzone d'autore vera come la bella cover di She Ain't Going Nowhere di Guy Clark era troppo disorientante perché il disco potesse creare uno zoccolo duro di fans fedeli. Incapace di accettare completamente i compromessi richiesti dal nuovo mercato discografico, Crowell chiuse la prima parte della sua carriera con un disco puramente nashvilliano che anticiperà di qualche anno la svolta neo-tradizionalista.
 Street Language
Street Language[Columbia, 1986]
E' solo una delle tante storie degli anni '80, l'ennesima prova delle violenze artistiche perpetrate dalle case discografiche, che in quegli anni la facevano veramente da padrone (e meno male che oggi possiamo parlare di queste cose come di un fenomeno passato). Accadde che nel 1984 Crowell presentò il suo quarto disco alla Warner Bros, che lo rifiutò per la mancanza di un 45 giri plausibile. Quando la Columbia accettò di prendersi l'onere erano già passati due anni, ma nonostante Street Language uscisse in ritardo e già vecchio per il mercato, le critiche furono tutto sommato positive. Il disco seguiva la nuova idea di country moderno di Crowell, che per l'occasione accentuò le spruzzate soul mettendo Booker T. Jones alle tastiere, Billy Joe Walker alle chitarre e utilizzando i fiati degli Uptown Horns, ma risultando un po' troppo confuso sul modo di scrivere il nuovo genere. Brillano Let Freedom Ring e Ballad Of Fast Eddie, piace la cover di She Loves The Jerk di John Hiatt (che collaborava a tutto il disco), e sebbene oggi il suono appaia inesorabilmente datato e superato, Street Language risulta essere ancora un disco al di sopra della media del suo periodo.
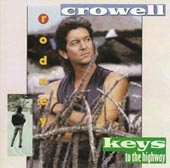 Keys to the Highway
Keys to the Highway[Columbia/Lucky Dog, 1989]
Aveva i soldi, aveva i musicisti (una super-band battezzata The Dixie Pearls) e aveva la fiducia della casa discografica: Keys To The Highway fu il classico fallimento da ansia da prestazione, ma in fondo bisogna rendergli merito sulle ragioni. Diamonds & Dirt infatti era un disco intransigentemente country, esattamente quello che Rodney non voleva essere. Il suo errore fu la fretta: invece di consolidare il successo e sfruttarne successivamente le libertà d'azione, lui consegnò subito alle stampe uno strano ibrido che mischiava senza troppo raziocinio country melenso, cantautorato classico, rock e blues, una ratatouille di influenze che fece solo rimpiangere la monolitica unitarietà e lievità del predecessore. Il pasticcio non fu tanto la varietà, che comunque gli rese di nuovo nemica la Nashville più tradizionalista, quanto l'aver comunque confezionato il tutto con la scintillante e plastificata produzione di Tony Brown, quando invece l'occasione sarebbe stata propizia per una ricerca sonora più coraggiosa e meno radio-friendly. Nulla di male se decidete di dargli una chance, Soul Searchin', Faith Is Mine e Things I've Wish I've Said sono ulteriori testimonianze di una penna felicemente delicata, ma questo era un Crowell troppo lontano dal suo stesso spirito rock and roll di fondo per poter far innamorare.
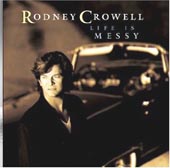 Life is Messy
Life is Messy[Columbia/Lucky Dog, 1992]
Deluso dalle reazioni negative suscitate da Keys To The Highway, Crowell passa i primi anni 90 in piena crisi artistica, indeciso sulla strada da intraprendere. Stanca di una vita passata sulle montagne russe dei suoi umori, la moglie Rosanne lo lascia ufficialmente nel 1991, e se l'ultimo disco da grandi produzioni della sua carriera venne intitolato Life Is Messy (la vita è un casino) non sorprende più di tanto. Life Is Messy tentava (senza riuscirci) una decisa presa di distanza dal nuovo country commerciale di Nashville che lui stesso aveva contribuito a rilanciare, con dieci brani di pop-rock infarciti di melodie sixties (su tutte la bella Answer Is Yes), carellate honky tonk da viaggio in macchina (It Don't Get better Than This o Lovin'All Night) e l'onore di un brano co-firmato con Roy Orbison (la sdolcinatissima What Kind Of Love) e uno con il suocero Johnny Cash (l'epica e struggente I Hardly Know How To Be Myself). La produzione patinatissima e decisamente stagionata del "Signor Joni Mitchell" Larry Klein e del "Signor Shawn Colvin" John Leventhal e uno stuolo di ospiti d'onore (Steve Winwood, Linda Ronstadt, Don Henley, Jim Lauderdale, senza contare l'elenco di session-man di primissimo livello) bastarono solo a dargli un decente commiato dalle luci della ribalta. La Columbia infatti non si preoccupò nemmeno di promuovere il disco e lo scaricò senza troppi complimenti.
 Let the Picture Paint Itself
Let the Picture Paint Itself Jewel of the South
[MCA, 1994/1995]
A risollevare la carriera di Crowell ci prova senza troppa convinzione la MCA dell'amico e produttore
Tony Brown, che produce due dischi tra il 1994 e il 1995, accomunati da copertine orride e una mancanza di focus su chi essere e dove andare da parte del padrone di casa.
Let The Picture Paint Itself parte convinto con la bella title-track, sicuramente episodio da considerare per una suo ipoetico The Best, ma prosegue nell'ovvietà di una serie di country-songs sempre indecise se voler volgere verso suoni più rocciosi o abbracciare la salutare leggerezza del pop. L'amico Guy Clark aiuta il disco ad acquistare spessore co-firmando Stuff

That Works (che finirà anche nel suo Dublin Blues) e The Rose Of Memphis, ma non basta. Senza grandi novità anche
Jewel Of The South, se non qualche buon tentativo di inserire elementi tex-mex nella title-track e nella bella storia di The Ballad Of Possum Potez, brani che con il potente rock di Love To Burn rendono il disco tra i suoi più vari stilisticamente. Compaiono qui titoli comunque importanti come Just Say Yes e una divertita cover del classico Candy Man, altro indiretto omaggio a Roy Orbison, presente in firma ancora una volta nel finale di Que'Es Amor. Il periodo MCA venne così consegnato alla storia come una prova di grande classe e professionalità, con vendite al solito scarse, ma ormai era evidente che Crowell stava rimanendo indietro rispetto alle produzioni contemporanee di un Dwight Yoakam o dell'altro astro nascente Jim Lauderdale.
 The Outsider
The Outsider[Columbia, 2005]
Rinfrancato dalle ottime critiche ricevute con i due dischi precedenti, nel 2005 Crowell torna all'amata/odiata Columbia per pubblicare The Outsider, probabilmente il suo disco più rock e fracassone. Chitarre in libertà (Will Kimborough e Pat Buchanan), suoni con volumi alti e ritmi serrati: The Outsider è un disco nato per poter strabiliare anche dal vivo, con brani assolutamente funzionali all'esaltazione di una folla come Say You Love Me o la serrata invettiva di The Obscenity Prayer, con sassolini da togliersi dalle scarpe verso la Nashville più detestata ("Le Dixie Chicks mi possono baciare il culo, ma non ho ancora avuto il pass per il loro backstage"). Il disco alterna guasconate da bulletto di campagna (Things That Go Bump In The Day, con dichiarazioni tipo "mi sento James Dean con te tra le braccia"..), rockettini facili e cantabili (Don't Get Me Started) a dylanismi vari che vanno da una Dancin Circles Round The Sun che tiene i ritmi dei malati blues sotterranei di Bob, ad una Beautiful Despair che spara subito un verso come "Bella disperazione è ascoltare Dylan alle 3 del mattino…", fino ad una interessante cover di Shelter From The Storm che serve più che altro ad una rimpatriata con la vecchia amica Emmylou Harris. Sempre la Harris e John Prine offrono un recitato nell'altro manifesto elettorale di Ignorance Is The Enemy, corale e retoricissimo appello alla nazione, utile più che altro a ribadire come Crowell rimanga autore poco avvezzo a temi sociali e più a suo agio con i sentimenti. Resta anche la title-track, sorta di resoconto di una vita da eterna promessa e un disco tra i più immediatamente assimilabili del suo catalogo.
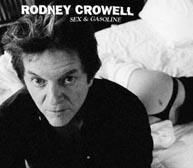 Sex & Gasoline
Sex & Gasoline[Yep Roc, 2008]
L'altra faccia del pompato The Outsider è il rilassato Sex And Gasoline, forte di una copertina da spavaldo latin-lover del giorno dopo, e soprattutto primo grande tentativo della sua carriera di venire a patti con una forte creatività altrui. Il pigmalione del disco è un Joe Henry ormai subissato di richieste come produttore e arrivato al punto di imprimere su ogni disco un marchio fin troppo personale e riconoscibile. Disco di gran livello per suoni (ottime le chitarre di Doyle Bramhall III e Greg Leisz) e songwriting, Sex And Gasoline appare però un po' come un'occasione persa del suo percorso, perché il risultato è appena discreto e decisamente al di sotto delle aspettative. Rodney da par suo ha offerto al progetto alcune ottime canzoni come la divertente title-track o ispirate ballads come The Night's Just Right e Closer To Heaven, ma su tutto il disco Henry fa calare una patina che sa di forzatamente lezioso, ricercato, in fin dei conti pretenziosamente e inutilmente schizzinoso verso qualsiasi tono un po' sopra le righe. Restano comunque alcuni importanti episodi della sua storia come la tesa e dylanesca I Want You #35, il gospel texano alla Lyle Lovett di Who Do You Trust e la baldanzosa Funky And The Farm-Boy.
:: Riepilogo (discografia)
Ain't Living Long Like This (Warner Bros. 1977) 9
But What Will the Neighbors Think (Warner Bros. 1980) 7
Rodney Crowell (Warner Bros. 1981) 7,5
Street Language (Columbia 1986) 6
Diamonds & Dirt (Columbia/Legacy 1988) 8
Keys to the Highway (Columbia/Lucky Dog 1989) 6
Life Is Messy (Columbia/Lucky Dog 1992) 6,5
Let the Picture Paint Itself (MCA 1994) 5,5
Jewel of the South (MCA 1995) 6
The Houston Kid (Sugar Hill 2001) 9
Fate's Right Hand (DMZ/Epic 2003) 8,5
The Outsider (Columbia 2005) 7,5
Sex and Gasoline (Work Song/Yep Roc 2008) 7
The Cicadas
The Cicadas (Warner Bros 1997) 8
The Notorious Cherry Bombs
The Notorious Cherry Bombs (Universal South 2004) 6,5