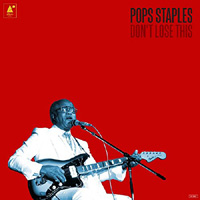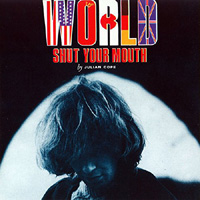AMOS LEE
LIVE AT THE RED ROCKS
ATO Records
***1/2
 Non c’è niente di meglio di un live album per celebrare lo
zenith di una carriera. Era una regola d’oro negli anni settanta, non lo è più
in questi tempi di disordinato e anarchico mercato discografico, ma Amos Lee è da sempre uno che fa le cose
con tradizionale regolarità. Una carriera la sua iniziata tra i favori della
critica americana per una serie di album eleganti e formalmente ineccepibili
come Supply And Demand del 2006 e Last Days On The Lodge del 2008, un
primo periodo, sospeso tra il più rigido Nashville-sound in tema di songwriters
e l’influenza del miglior James Taylor, che fu immortalato nell’elegante dvd Live From Austin, TX alla fine del 2008.
Poi però, un po’ a sorpresa, Amos ha improvvisamente fatto il salto di qualità.
A partire dallo straordinario Mission
Bell del 2011, e bissando con l’altrettanto ottimo Mountains Of Sorrow, Rivers Of Song del 2013, la musica di Lee è
cresciuta di spessore e si è colorata di elementi gospel, rock, persino indie-rock,
diventando forse il miglior erede della composta lezione di Lyle Lovett.
Live At Red Rocks arriva quindi a celebrare un artista nel pieno del
suo salto di qualità, e ci rivela un performer ben più dinamico e eclettico del
compassato e, in fin dei conti, noioso cantautore degli esordi. E grande aiuto
lo da la Colorado Symphony Orchestra, intera sezione d’archi che regala a brani
di per sé già ottimi come Windows Are
Rolled Down, Violin o Colors un sound completamente nuovo. I
concerti con orchestra sono sempre a rischio di kitsch o inutile magniloquenza,
ma il repertorio di Lee vola da sempre basso sulle corde delle emozioni meno
estreme, per cui il mix si rivela decisamente riuscito, con l’apoteosi soul di Jesus, il baldanzoso country-rock alla
Jim Croce di Tricksters, Hucksters and
Scamps, o la sempre meravigliosa El
Camino. E ancora in
scaletta passano Keep It Loose, Keep It
Tight, Flower, Won’t Let Me Go, Arms Of A Woman, Sweet Pea e una gran bella
versione di Street Corner Preacher. E
visto che Lee è in vena di scherzi, nel finale lascia spazio all’orchestra, che
si prodiga in una versione del tema del serial Game Of Thrones che, c’entrerà poco con il contesto, ma dimostra
quanto la mente di Amos Lee si sia aperta e sia ancora pronta a generare grande
musica d’autore. Non sarà un titolo fondamentale della sua discografia, ma Live
At The Red Rocks conferma la statura di primo livello di un autore che ha
saputo prendersi il giusto tempo per crescere e maturare. Proprio come si
faceva ai vecchi tempi.
Non c’è niente di meglio di un live album per celebrare lo
zenith di una carriera. Era una regola d’oro negli anni settanta, non lo è più
in questi tempi di disordinato e anarchico mercato discografico, ma Amos Lee è da sempre uno che fa le cose
con tradizionale regolarità. Una carriera la sua iniziata tra i favori della
critica americana per una serie di album eleganti e formalmente ineccepibili
come Supply And Demand del 2006 e Last Days On The Lodge del 2008, un
primo periodo, sospeso tra il più rigido Nashville-sound in tema di songwriters
e l’influenza del miglior James Taylor, che fu immortalato nell’elegante dvd Live From Austin, TX alla fine del 2008.
Poi però, un po’ a sorpresa, Amos ha improvvisamente fatto il salto di qualità.
A partire dallo straordinario Mission
Bell del 2011, e bissando con l’altrettanto ottimo Mountains Of Sorrow, Rivers Of Song del 2013, la musica di Lee è
cresciuta di spessore e si è colorata di elementi gospel, rock, persino indie-rock,
diventando forse il miglior erede della composta lezione di Lyle Lovett.
Live At Red Rocks arriva quindi a celebrare un artista nel pieno del
suo salto di qualità, e ci rivela un performer ben più dinamico e eclettico del
compassato e, in fin dei conti, noioso cantautore degli esordi. E grande aiuto
lo da la Colorado Symphony Orchestra, intera sezione d’archi che regala a brani
di per sé già ottimi come Windows Are
Rolled Down, Violin o Colors un sound completamente nuovo. I
concerti con orchestra sono sempre a rischio di kitsch o inutile magniloquenza,
ma il repertorio di Lee vola da sempre basso sulle corde delle emozioni meno
estreme, per cui il mix si rivela decisamente riuscito, con l’apoteosi soul di Jesus, il baldanzoso country-rock alla
Jim Croce di Tricksters, Hucksters and
Scamps, o la sempre meravigliosa El
Camino. E ancora in
scaletta passano Keep It Loose, Keep It
Tight, Flower, Won’t Let Me Go, Arms Of A Woman, Sweet Pea e una gran bella
versione di Street Corner Preacher. E
visto che Lee è in vena di scherzi, nel finale lascia spazio all’orchestra, che
si prodiga in una versione del tema del serial Game Of Thrones che, c’entrerà poco con il contesto, ma dimostra
quanto la mente di Amos Lee si sia aperta e sia ancora pronta a generare grande
musica d’autore. Non sarà un titolo fondamentale della sua discografia, ma Live
At The Red Rocks conferma la statura di primo livello di un autore che ha
saputo prendersi il giusto tempo per crescere e maturare. Proprio come si
faceva ai vecchi tempi.
Nicola Gervasini


:format(jpeg):mode_rgb()/discogs-images/R-6912264-1429369166-2923.jpeg.jpg)